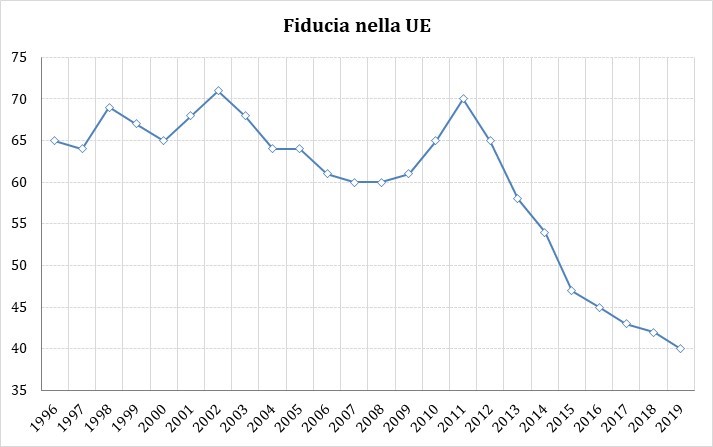Germania e Italia di fronte al sovranismo giuridico
Nel dibattito culturale più recente si parla assai spesso di “sovranismo”; termine che viene inteso pressoché invariabilmente in senso politico, ossia come una rivendicazione della prevalenza degli interessi economici e strategici del singolo Stato rispetto a quelli di altri stati ovvero all’attività e all’agenda di enti e istituzioni sovranazionali. In Italia (e in Europa) il tema si concentra peraltro sulla possibilità di rivendicare maggiori spazi di autonomia a favore degli Stati membri, di fronte al crescere dei vincoli imposti dall’Unione Europea all’azione politica nazionale, sia mediante il ricorso sempre più frequente a direttive e regolamenti nei più disparati settori, sia – più di recente – mediante l’imposizione di condizioni di politica economica e fiscale (le famose “condizionalità”) in seguito alla concessione di aiuti finanziari agli stati membri da parte degli enti che fanno capo all’UE.
Il tema del sovranismo può in realtà essere trattato in termini ben più generali (e meno conflittuali) declinandolo in senso giuridico, ossia come uno dei possibili modelli di gerarchia costituzionale delle fonti del diritto, identificandosi in particolare con quello che vede prevalere le fonti di diritto nazionale – e, in particolare, le norme della costituzione nazionale – rispetto alle norme primarie e secondarie di diritto internazionale (e dunque anche comunitarie).
Sul punto occorre tuttavia svolgere un chiarimento preliminare: l’Unione Europea – in particolar modo la Corte di Giustizie UE – rivendica da sempre e con forza il primato del proprio diritto rispetto a quello degli Stati Membri. Sennonché, pare a chi scrive che proprio il fatto che gli organi UE trovino necessario ribadire diverse volte una certa cosa (nella specie, appunto, il primato del diritto UE), conferma che quella cosa tanto certa poi non è. E non lo è nel senso – evidente a chiunque, anche se non giurista – che, al di là degli argomenti che può indicare la Corte di Giustizia per sostenere le sue tesi, l’UE in ultima analisi è solo un insieme di burocrazie e organi che producono norme giuridiche, ma non ha né un popolo né un territorio “propri”. Dunque l’UE – che esiste, opera (e ha la tendenza a concepire sé stessa) come se fosse un super-stato – in realtà uno stato non è, sia perché non fonda la propria sovranità su un suo popolo sia perché non è in grado di amministrare da sé quella sovranità su un proprio territorio, non avendo né un esercito né una polizia né un insieme di tribunali e altri organi che gli consentano di far rispettare coercitivamente le norme che promulga, dovendosi viceversa valere, per ottenere quel risultato, del “braccio secolare” degli Stati membri. Se dunque l’UE – in via di fatto – esiste solo perché “può comandare in casa d’altri” è evidente che la sua stessa esistenza – ossia la vigenza del diritto che produce – dipende dal consenso che questi “altri” prestano al suo comandare a casa loro. Questo spiega perché il tema del sovranismo non può essere affrontato (e tanto meno risolto) muovendo da quel che sostiene l’UE stessa, per voce della sua Corte di Giustizia, laddove la sua soluzione dipende invece dai limiti in cui gli Stati Membri si ritengono vincolati (o, quanto meno, acconsentono) a rendere vigente il diritto UE nei rispettivi territori: limiti che – ovviamente – sono definiti solo dalle costituzioni nazionali e dall’interpretazione che di esse danno le rispettive Corti costituzionali.
Si badi infatti che tutte le costituzioni non possono che essere sovraniste: qualunque riconoscimento costituzionale della prevalenza del diritto UE, per quanto ampio e incondizionato, resterebbe infatti pur sempre reversibile dallo stato nazionale, vuoi con una modifica costituzionale o vuoi con una uscita dai trattati (in tal senso la brexit ha insegnato quanto poco ci voglia per togliere ogni potere all’UE). In altre parole: se è proprio (e solo) la sovranità dello Stato che consente a quello stesso Stato di prestare il proprio consenso a divenire parte di una convenzione internazionale, non esiste alcuna valida ed efficace convenzione internazionale senza la sovranità degli stati aderenti, i quali tuttavia – proprio in ragione di quella stessa sovranità che consente loro di rendere effettivi i trattati – possono anche sottrarsi unilateralmente alla vigenza di quei trattati, restando esposti solo alle eventuali ritorsioni di diritto internazionale eventualmente decise delle altre parti secondo le regole del diritto internazionale consuetudinario o pattizio.
Questa elementare considerazione sul fondamento ultimo della effettiva vigenza di un qualunque trattato internazionale (che, come si diceva, è proprio la sovranità degli stati che vi aderiscono) ispira con tutta probabilità la giurisprudenza costituzionale tedesca più recente che – quando si è trovata a dover valutare sia norme di matrice UE (i famigerati programmi di acquisto di titoli di stato da parte della BCE nel contesto del cosiddetto quantitative easing) sia trattati multilaterali di grande importanza economico-strategica (come il trattato sulla Corte Unificata dei Brevetti) – ha affermato con una certa decisione il principio secondo cui le norme di qualunque trattato internazionale restano soggette al consenso degli Stati aderenti nei limiti in cui era stato manifestato in sede di adesione al trattato, di guisa che gli organi internazionali eventualmente creati dai trattati (incluse, per quel che concerne l’unione europea, la BCE e la Corte di Giustizia UE) non possono modificare i principi ed i limiti su cui si fondavano “i patti” originariamente sottoscritti dagli Stati in sede di stipulazione del trattato. Questo principio è stato riassunto nel lemma, assai icastico e per certi versi tagliente, secondo cui gli stati aderenti restano i soli veri “padroni” dei trattati (e dunque anche dell’UE). Ma non basta: la Corte ha anche ribadito il suo costante orientamento nel senso che le norme in cui si manifesta la sovranità dello stato nazionale (e dunque le norme fondamentali costituzionali) prevalgono sulle norme di fonte internazionale.
Questo significa, per i giudici costituzionali tedeschi, non solo che i patti internazionali vanno attuati e sono vigenti solo nei limiti in cui sono stati stipulati (o successivamente modificati) dagli stati aderenti (senza che dunque gli organi che amministrano o attuano i trattati possano in via autonoma spingersi ultra vires), ma anche che i principi fondamentali della costituzione nazionale rappresentano un limite implicito del diritto dello stato di aderire ai trattati e dunque prevalgono – nei singoli stati – sulle norme di qualunque trattato internazionale (così come nei confronti della normativa secondaria prodotta dagli organi costituiti in forza dei trattati), che deve essere disapplicato o denunciato nelle parti in cui non rispetti quegli stessi principi. E questo vale anche per il diritto UE.
La Corte a tale riguardo ha infatti precisato che il controllo di costituzionalità del diritto Ue (anche con riferimento ai provvedimenti emanati dagli organi europei nel contesto del processo di integrazione europea) si articola in due diverse valutazioni: quella di conformità dei poteri esercitati dall’Unione rispetto alle funzioni che i Trattati le conferiscono secondo il principio generale di attribuzione (c.d. ultra vires review) e quella di non interferenza degli atti dell’Unione con i “principi fondamentali” ricavabili dalla Legge fondamentale tedesca che siano tali da caratterizzarne l’identità (c.d. identity review). Si noti dunque come la selezione dei principi costituzionali “fondamentali” viene operata in Germania sulla base di un criterio che si può senza dubbio definire nazionalistico, dal momento che considera prevalenti rispetto al diritto UE i principi che consentono di conferire all’assetto costituzionale tedesco la sua “identità” (applicando una dottrina che viene definita in Germania della “identità costituzionale”).
Ebbene: la volontà di subordinare la vigenza del diritto UE in uno stato membro all’“identità costituzionale nazionale” – dunque la dottrina tedesca dell’identità costituzionale – rappresenta a mio avviso un modello di interpretazione dei rapporti tra diritto dell’UE e diritto nazionale che può tranquillamente essere definito come “sovranismo giuridico”, ossia come manifestazione della volontà dello stato nazionale di subordinare – nella gerarchia delle fonti – il diritto UE ai principi fondamentali del suo ordinamento costituzionale.
Il sovranismo giuridico della Corte di Karlsruhe appare peraltro in linea con le norme costituzionali che la corte stessa ha l’obbligo di applicare. L’art. 20 della legge fondamentale tedesca dispone infatti che “La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale” e che “Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e attraverso organi speciali investiti dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario”, mentre l’art. 23 (intitolato “l’Unione europea”) prevede specificamente che “Per la realizzazione di un’Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell’Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l’istituzione dell’Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l’articolo 79, secondo e terzo comma”. La costituzione tedesca, in altre parole, ammette sì ampie deleghe di sovranità a beneficio dell’Unione Europea, ma solo nei limiti in cui l’azione dell’Unione resta nei limiti dei principi fondamentali tracciati dalla carta fondamentale tedesca. Dunque la Corte, nell’ispirare la sue giurisprudenza al principio del sovranismo giuridico, non si spinge ultra vires, ma rispetta il dettato della sua carta fondamentale.
In Italia le cose stanno, a prima vista, in modo analogo, anche se poi – approfondendo il discorso – si scoprono differenze tanto interessanti quanto significative rispetto all’esperienza tedesca. La nostra Corte costituzionale ammette infatti che il diritto UE prevalga rispetto al diritto nazionale in applicazione dell’art. 11 Cost.., secondo cui l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Proprio l’applicabilità dell’art. 11 al diritto UE consente alla Corte Costituzionale di creare a favore delle fonti di diritto unionista uno spazio di vigenza da cui l’ordinamento nazionale (analogamente a quando prevede l’art. 23 della costituzione tedesca) si ritrae, per lasciare competenza esclusiva al legislatore unionista: spazio in cui – dunque – la norma unionista si va ad inserire, risultando per l’effetto direttamente vincolante in Italia, senza per questo divenire una norma nazionale (come avviene invece per altre fonti internazionali, secondo la dottrina della cosiddetta “recezione”).
Conseguenza di questo particolare regime di vigenza è che il diritto UE non resta soggetto al “normale” sindacato di legittimità costituzionale che vale per le leggi interne, bensì a un controllo teso a verificare la compatibilità della norma con i “principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale” (così la sentenza n. 183/1973 e – più recentemente – l’ordinanza 454/2006). Anche in Italia, come accade in Germania, per le norme UE la Corte costituzionale applica un regime di verifica di costituzionalità “attenuata”. Simili norme infatti – a differenza di quelle nazionali – possono essere dichiarate incostituzionali (mediante l’impugnazione della legge nazionale di ratifica dei trattati che le hanno approvate o che hanno approvato le norme in forza della quali sono state adottate le norme comunitarie della cui legittimità costituzionale si discute) solo se sono contrarie ai “principi fondamentali” della nostra carta fondamentale.
E’ tuttavia nei criteri da adottare per l’individuazione dei principi costituzionali da considerarsi “fondamentali” che Italia e Germania adottano prospettive piuttosto differenti. In Italia, infatti, i principi fondamentali vengono per lo più identificati nei diritti umani inalienabili cui fa riferimento la prima parte della costituzione ma che sono riconosciuti anche nelle convenzioni multilaterali sui diritti umani. Questo consente di sostenere che – rispetto all’impostazione tedesca – il primato dell’ordinamento costituzionale sul diritto UE viene declinato in modo meno identitario e più universalista (quasi, verrebbe da dire, secondo criteri pseudo-giusnaturalistici). In sintesi: mentre la Germania adotta – nei confronti del diritto UE – un metro di verifica costituzionale colorato in senso nazionalista (adottando un sistema che potremmo pertanto definire “sovranismo giuridico forte”), l’Italia applica criteri di prevalenza costituzionale meno identitari e più universalisti (e dunque esercita quello che potremmo definire un “sovranismo giuridico debole”). Questo consente di spiegare piuttosto bene perché la Corte di Karlsruhe è assai più propensa – rispetto alla nostra Consulta – a valutare la legittimità costituzionale delle norme unioniste sindacando il merito delle scelte politiche che stanno dietro all’adozione delle norme europee: propensione che emerge proprio nella sentenza in tema di quantitative easing in cui la Corte giunge alla conclusione di incostituzionalità del programma di acquisti della BCE dopo aver spese decine di pagine nell’illustrazione di argomenti e principi di politica economica e monetaria.
Il fatto di poter contare su una corte costituzionale che esprime un “sovranismo forte” nel sindacare il contenuto del diritto unionista consente peraltro agli altri poteri dello stato tedesco di ritagliarsi, nelle diverse sedi istituzionali dell’UE, un maggiore spazio di manovra a tutela dei propri interessi nazionali rispetto a stati che (come l’Italia) – nella verifica costituzionale del diritto UE – si limitano ad esercitare un sovranismo debole. Il fatto insomma che la corte costituzionale di un stato dell’UE scelga di interpretare “alla tedesca” (ossia in senso più identitario e nazionalista) piuttosto che non “all’italiana” (ossia in senso più universalista) i criteri da usare per individuare i principi inviolabili dell’ordinamento costituzionale nazionale che devono sempre prevalere nei confronti del diritto UE; tale fatto – dicevamo – si riflette anche sul maggiore o minore potere contrattuale che quello stesso stato ha all’interno delle istituzioni europee.
Stando così le cose, e risultando piuttosto evidente che l’Italia ben di rado riesce a far valere i propri interessi in sede UE, è dunque lecito interrogarsi sui limiti in cui il riferimento all’art. 11 Cost. (dalla cui applicazione deriva il fatto che l’Italia sia un paese in grado di esercitare solo un sovranismo giuridico “debole” in sede di verifica costituazionale del diritto UE) sia correttamente utilizzato dalla nostra Consulta quando si tratta di valutare la tenuta costituzionale di norme di fonte unionista. Il tema è ovviamente molto complesso e dunque non può essere esaurito in questa sede, in cui mi limiterò a indicare un paio di spunti, fondati entrambi sulla considerazione che il regime di sindacato “attenuato” – sostanziandosi in una eccezionale limitazione di sovranità dello stato – pare giustificato solo nella misura in cui si può sostenere che i trattati UE beneficiano di una sicura copertura da parte dell’art. 11 Cost., dunque solo nella misura in cui è possibile considerare quei trattati come altrettanti strumenti “necessari” (non dunque semplicemente “utili”) per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni.
La prima considerazione che mi sento di svolgere a riguardo è che vi sono alcuni principi del diritto primario UE (come ad esempio il principio di conferimento, così come quello che subordina ogni aiuto dell’UE a rigide condizioni così come quelli che vincolano gli organi UE a modellare la propria azione di politica economica intorno alla dottrina della cosiddetta “austerity”) che – escludendo a priori ogni possibile aspetto solidaristico o mutualistico dei rapporti tra gli stati membri – potrebbero non esprimere un concetto di “giustizia” compatibile con quello che ispira – per un verso – la nostra carta costituzionale e – per altro verso, ma direi soprattutto – il complesso delle grandi convenzioni multilaterali come la CEDU e le convenzioni ONU. Se così fosse, infatti, si potrebbe mettere in dubbio che quelle parti dei trattati dell’unione siano davvero “necessarie” per assicurare (oltre alla pace, anche) la giustizia tra le nazioni. Il tema, certamente molto stimolante, è altrettanto certamente delicato (e scivoloso), dal momento che su simili questioni gli argomenti giuridici confinano con (fino a sfumarsi inevitabilmente in) valutazioni politiche. Per questa ragione non mi spingo oltre, limitandomi a segnalare la questione a chi vorrà esplorarla, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello politico.
Ma anche ammettendo che l’art. 11 Cost. si applichi ai trattati costitutivi dell’UE e a quelli generali sul suo funzionamento, siamo sicuri che lo stesso valga per le fonti europee secondarie, ossia per qualunque norma emanata dagli organi UE costituiti sulla base di quei trattati? Pare infatti azzardato sostenere che una qualunque norma contenuta in un regolamento UE (o in altro provvedimento normativo di secondo grado direttamente efficace in Italia) sia, automaticamente e dunque del tutto a prescindere dal suo oggetto e contenuto, sempre necessaria per assicurare la pace e la prosperità tra le nazioni, dunque meritando una possibilità di verifica di tenuta costituzionale attenuata. Il che impone di chiedersi se abbia davvero molto senso attribuire a qualunque norma derivata di fonte europea un potere di limitare la sovranità nazionale del tutto analogo alle fonti primarie, per il solo fatto che si tratti di norma che deriva da queste ultime fonti. Per dirla ancora più chiaramente: siamo così sicuri che la norma costituzionale su cui la corte costituzionale italiana fonda tradizionalmente la sua scelta di esercitare un sovranismo debole nei confronti dell’UE valga anche per le fonti UE secondarie? O magari anche in Italia esiste uno spazio per esprimere una posizione più articolata, nel senso che – anche qualora restasse ferma la posizione della Consulta nel senso di esercitare solo un sovranismo debole nei confronti del diritto primario dell’UE – almeno le norme secondarie restino soggette (non ad una semplice verifica di conformità ai principi fondamentali della nostra costituzione, ma) al medesimo rigoroso sindacato di costituzionalità cui sono soggette le leggi nazionali?