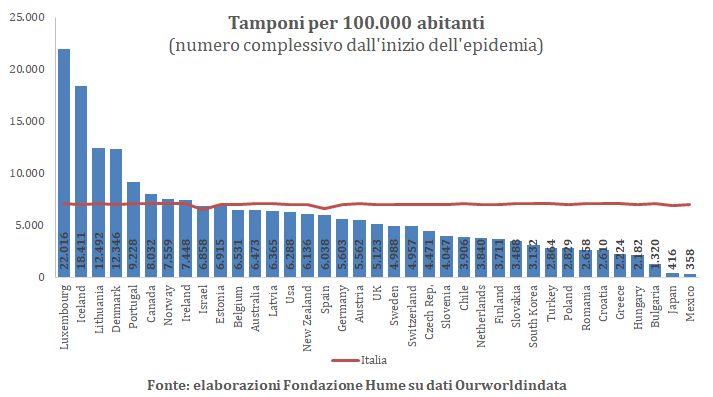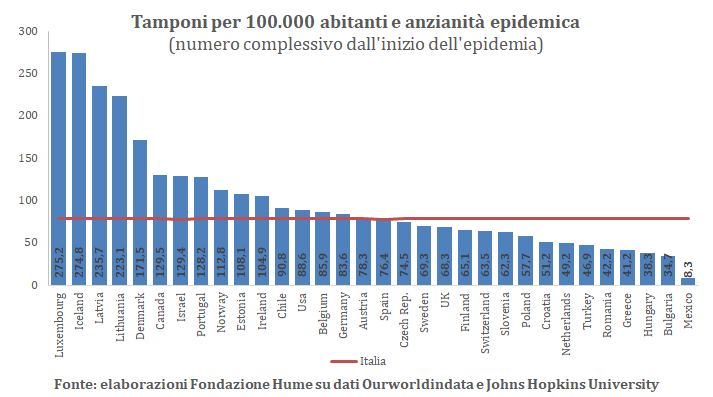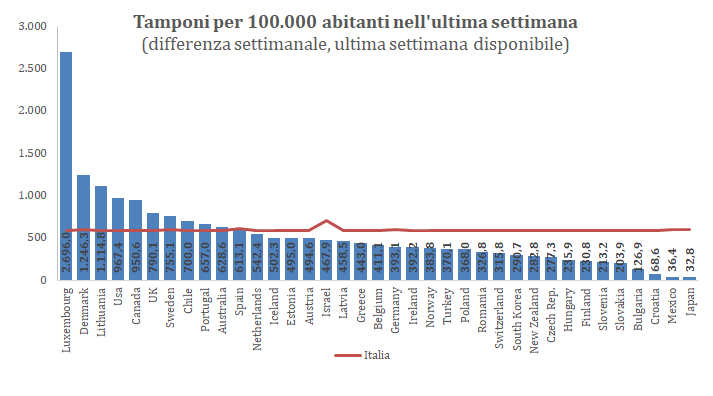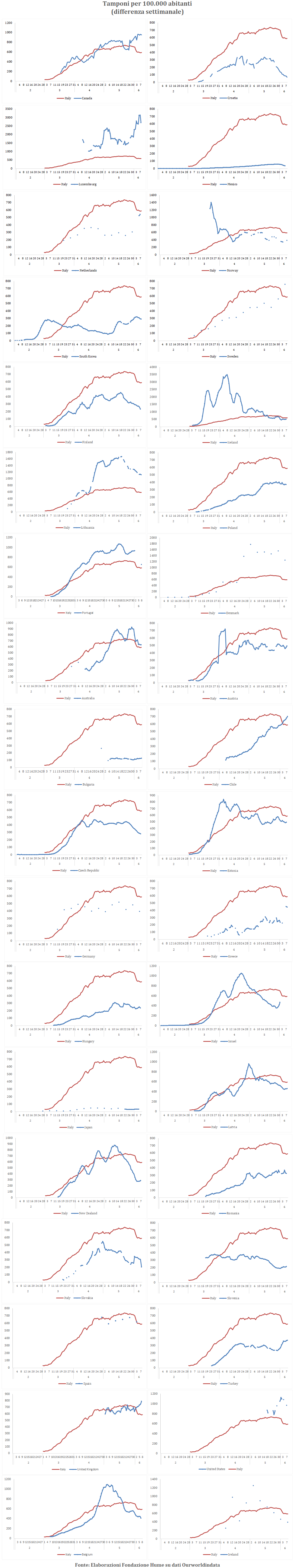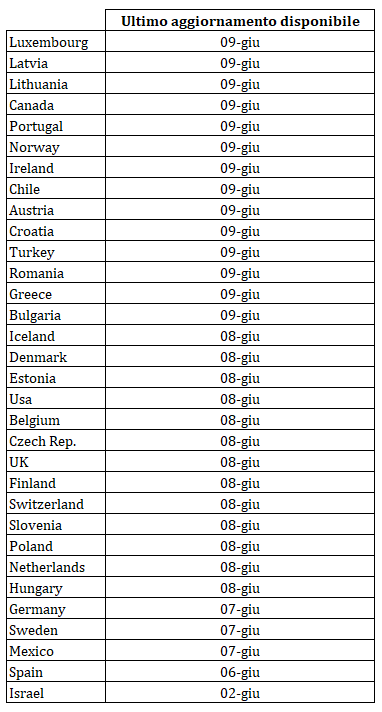Non ci resta che il tampone
Ultimamente siamo tutti quanti presi da uno spasmodico, smodato e paradossale desiderio di tampone.
Non siamo diventati di colpo stupidi o masochisti: è che il tampone è l’unica cosa che ci resta, il solo desiderio che abbia, in questa desolazione, una qualche chance di essere esaudito. Nel nostro immaginario, è diventato la manna che scende nel deserto. Il salvagente lanciato al naufrago. L’oracolo che ci dà un responso. L’amico immaginario.
È anche, bisogna dirlo meno poeticamente, il nostro scarica-coscienza. Lo è stato soprattutto quando siamo tornati dalle vacanze e, dopo bagordi, discoteche, cene, aperitivi, feste affollate, molti di noi, quelli che si erano sfrenati di più, si sono precipitati a farsi un tampone: per togliersi il pensiero, e magari andare più sereni ad altre feste. Da settembre in poi il tampone è diventato l’acqua che lava via i peccati, il gesto che ci libera dai sensi di colpa. Tampone-lavacro, tampone-panacea.
Ma ora è di più: il tampone è l’unica cosa che il cittadino ha a disposizione (seppur con enormi difficoltà) per sapere almeno se si è preso il virus o no, in uno Stato che si nega, si nasconde, fa pasticci, confonde, non risolve, non appronta nulla, non ci difende, non ci protegge!
Dove il potere abdica, regna il tampone.
Con enormi difficoltà, però! Difficilissimo avere il dono di un tampone. L’oracolo di Delfi era di gran lunga più accessibile, meno affollato: forse più oscuro, ma sicuramente più disponibile. L’immagine più dolorosa, drammatica, devastante di questi giorni, quella che non mi tolgo dagli occhi, è la gente in coda nella notte, in auto o a piedi, dalle quattro di mattina. Gente che accompagna i suoi bambini, i suoi anziani, magari febbricitanti. Scene intollerabili che non dimenticheremo.
L’aspetto per me più stupefacente è la pazienza. L’infinita sopportazione, venata di rassegnazione. La gente intervistata nella notte, chiusa nella propria auto, non si lamenta, non protesta. Non lancia sassi, non divelle alberi, non incendia palazzi, dice soltanto: Eh sì, sono qui da 7 ore, dormo un po’, mi sono portato da leggere, aspetto, e spero di arrivare a farmelo, il tampone, che mi prendano ancora, che non chiudano, altrimenti dovrò tornare domani.
Come hanno potuto i nostri governanti assistere impassibili a questo supplizio senza vergognarsi? E come abbiamo potuto noi essere così pazienti, e indulgenti?
Ma il tampone è soprattutto ciò che “tampona” la ferita più grande, che sostituisce il Grande Assente, colui che ora più che mai ci manca: il nostro medico curante. La corsa ai tamponi è la risposta, patetica, alla latitanza dei nostri medici. Latitanza non colpevole, intendiamoci, non voluta, anch’essa in qualche modo imposta: il medico di base non può visitarci e non può curarci. Noi lo chiamiamo, gli elenchiamo i sintomi al telefono, e lui ci dice che né potremo noi andare da lui in ambulatorio, né potrà lui venire a visitare noi. Logico, correrebbe il rischio di infettarsi e di infettare tutti i pazienti successivi; si dovrebbe proteggere, ma non gli è stato fornito nessun mezzo di protezione. Quindi ci dice gentilmente di prendere una tachipirina e di aspettare; oppure, se ritiene che i sintomi siano chiari, trasmette una segnalazione alla ASL.
Cioè, ci abbandona! Il nostro medico amato, il medico che ci cura da trent’anni, che conosce ogni nostro minimo acciacco, che è corso al nostro capezzale a ogni nostra febbre o mal di pancia, ora non può che negarsi e abbandonarci: trasmette la segnalazione all’Asl! Aiuto, nulla potrebbe farci più orrore, nulla gettarci di più nello sconforto totale! Di colpo, al suono ASL, abbiamo la percezione netta del tritacarne burocratico in cui finiremo, noi e i nostri poveri sintomi, semplici nomi buttati nella rete, dispersi, maciullati… Di colpo ci sentiamo soli. Forse malati, e irrimediabilmente soli. Perduti nel vuoto.
Mi viene in mente Major Tom. La splendida e tragica canzone di David Bowie dove l’astronauta si perde nello spazio, vi ricordate? Ground Control to Major Tom… Can you hear me, Major Tom…? No, nessuno ci ascolta. La nostra astronave è rotta e non sa da che parte andare. Questa insensata corsa al tampone è il segno della confusione e solitudine in cui ci hanno lasciati. Noi andiamo dal tampone perché è l’unica entità esistente da cui andare! È “lui” il nostro nuovo medico. Un medico impalpabile e impotente, un medico che non ci cura e non si cura di noi. Ma almeno ci solleva l’anima per un po’, ci placa l’ansia.
C’è qualcosa di sinistramente assurdo in tutto ciò, qualcosa di (inconsapevolmente?) perverso e anche un po’ sadico. Possibile che, proprio in epoca di pandemia, la gente perda i suoi medici?
Per questo adesso siamo tutti idealmente dentro quelle auto in coda. Uniti, partecipi, addolorati, sconcertati: siamo lì in piena notte, pieni di freddo e ansia, preoccupati e confusi. In fila al buio per ore.
È l’abbandono, che più ci tormenta. L’essere lasciati in un mare immenso carico di nubi tempestose, senza nemmeno il miraggio di una barchetta, le luci di un elicottero che si avvicina, una corda che ci viene lanciata, una torcia, una coperta di lana…
La legge del mare impone di salvare i naufraghi. Quale legge salverà noi, naufraghi nel mare dell’inefficienza e della cieca, impietosa disorganizzazione?
Pubblicato su La Stampa del 27 ottobre 2020