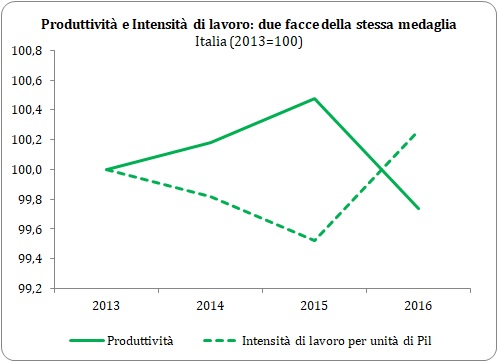Il compleanno della Costituzione: le promesse tradite
La Costituzione italiana sta per compiere 70 anni. Li compirà esattamente il 22 dicembre, anniversario del 22 dicembre 1947, quando la Carta fondamentale fu approvata dall’Assemblea Costituente. Settanta anni non sono pochi, nella vita delle persone non meno come in quella delle istituzioni. E un compleanno a cifra tonda è un’ottima occasione per tentare un bilancio.
Una parte del bilancio, quella strutturale, o puramente descrittiva, è presto fatta. La Costituzione in parte è rimasta monca (non si è mai avuto il coraggio di specificare gli articoli 39 e 49, per non limitare lo strapotere di sindacati e partiti); in parte è stata completata da interventi successivi, come quello sulla Corte Costituzionale (1953), quelli su composizione e durata di Camera e Senato (1963), quello sulle Regioni (1970); in parte, infine, è stata manomessa con più o meno successo, come quando il centro-sinistra è intervenuto sul Titolo V introducendo il federalismo (2001), o quando il centro-destra ha tentato invano di cambiare la forma di governo (2006), o ancora quando, sotto la pressione della crisi e delle autorità europee, il Parlamento ha rafforzato l’articolo 81 rendendo più rigide le norme sui conti pubblici (2012).
Più difficile, molto più difficile, è fare un bilancio valutativo. Perché un vero bilancio dovrebbe rispondere ad almeno due domande strettamente intrecciate. La prima: in questi 70 anni la Costituzione è stata tradita? La seconda: la Costituzione, così com’è diventata, è ancora all’altezza dei tempi?
Sulla prima domanda personalmente non ho molti dubbi. Comunque la si pensi sulla bontà della Carta originaria (un punto su cui gli osservatori sono divisi), è difficile occultare che almeno una decina dei 54 articoli iniziali (“Princìpi fondamentali” e “Diritti e doveri dei cittadini”) sono stati largamente ignorati e talvolta sostanzialmente traditi. Fra di essi, i più calpestati sono probabilmente quelli concernenti il lavoro (1, 4, 36) e lo studio (34).
I primi stabiliscono il diritto ad avere un lavoro (1, 4) e una retribuzione adeguata (36), nonché l’impegno della Repubblica a rendere effettivo tale diritto. Basta una breve occhiata alla traiettoria storica dei tassi di occupazione e di disoccupazione per rendersi conto che questo diritto, solennemente enunciato all’articolo 1 (“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”), non è mai stato garantito, e negli ultimi due decenni è stato addirittura umiliato: oggi l’Italia non solo non è in un regime di piena occupazione (come la Germania e alcuni paesi del Nord) ma ha il tasso di occupazione giovanile più basso d’Europa.
Le cose vanno ancora peggio per quanto riguarda l’articolo 34, che nel secondo e terzo comma recita: “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
Anche questo diritto è negato e calpestato, come sa chiunque sia semplicemente “capace e meritevole”, senza essere anche povero. Oggi le pochissime borse di studio sopravvissute sono assegnate esclusivamente a coloro le cui famiglie, almeno sulla carta (attestazione Isee) versano in condizioni di disagio estremo. E uno dei drammi cui assisto all’università è che i pochi studenti davvero “capaci e meritevoli”, sono spesso costretti a lavorare per mantenersi agli studi, perché le loro famiglie sono modeste, ma non abbastanza povere da avere diritto alle limitatissime risorse disponibili. Così la concorrenza con i figli di papà diventa sleale, alla faccia dei principi egualitari e meritocratici proclamati in tanti articolo della Carta fondamentale.
Resterebbe la questione dell’attualità della Costituzione. Su questo, lo confesso, le mie sensazioni sono contrastanti. Da un lato ho molti dubbi sul fatto che il federalismo introdotto nel 2001, ma anche il regionalismo introdotto nel 1970, siano stati un progresso: il loro effetto è stato soprattutto di rendere più facile ad amministratori e politici dilapidare denaro pubblico. E ancora più dubbi ho sulla funzionalità del bicameralismo, che il referendum renziano del 2016 sciaguratamente non intendeva affatto eliminare, ma solo annacquare e imbastardire (con i senatori eletti dai consigli regionali). Dall’altro lato, però, mi assale anche un dubbio di segno opposto, e cioè che la maggior parte delle cose che non vanno, in Italia, non dipendano affatto dalla Costituzione, bensì dalla scarsa qualità degli uomini che dovrebbero rispettarla, attuarla, tradurla in norme e regolamenti: la lentezza del processo legislativo, ad esempio, dipende tantissimo dai regolamenti parlamentari e dalla irresponsabilità dei partiti, più che dal bicameralismo.
Sicché, alla fine, più che chiedermi se la Costituzione sia attuale oppure no, mi viene da farmi un’altra e più radicale domanda: e se il vero problema non fosse la Costituzione, ma fossimo noi stessi, cittadini italiani, con le nostre cattive abitudini, la nostra indifferenza, e in definitiva la nostra incapacità di sceglierci una classe politica decente?
Pubblicato su Panorama il 14 dicembre 2017