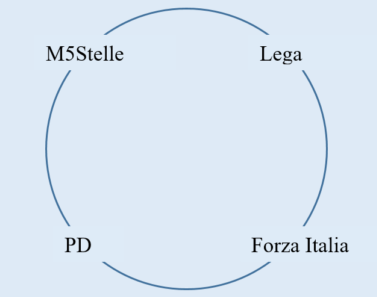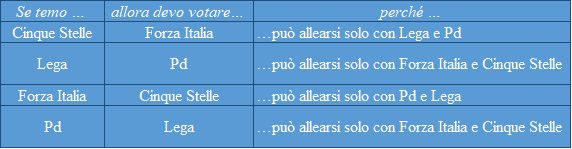Lo scivolamento a Sud delle Marche. Prima l’economia, adesso la politica
La mappa per regione dei risultati della recente consultazione elettorale divide l’Italia in due – fra centro-destra e movimento Cinque Stelle– sbiadendo o indebolendo l’idea di un’Italia divisa in tre: il nord-ovest, il nord-est centro e il mezzogiorno. Questa suddivisione era stata proposta nel 1977 dal sociologo Arnaldo Bagnasco, all’epoca all’Università di Firenze, in un libro che si intitolava appunto ‘Le tre Italie’. La tesi dello studio ribaltava l’idea, fino ad allora consolidata, di un’Italia divisa in due fra un nord sviluppato e un sud arretrato. Secondo Arnaldo Bagnasco, l’Italia era divisa in tre: da una parte il nord-ovest, area di prima industrializzazione dominata dalla grande impresa; dall’altra il sud, economicamente arretrato e con basso tasso di industrializzazione; in mezzo le regioni del nord-est e del centro. Che non erano semplicemente in una situazione intermedia fra le due ma erano caratterizzate da un peculiare modello economico, frutto di una più recente industrializzazione e basato su imprese di piccola e media dimensione.
L’idea non era del tutto nuova. Già nel 1974, in un convegno organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni ad Ascoli Piceno si era parlato di ‘via Adriatica allo sviluppo’ notando le similitudini nell’organizzazione delle imprese e delle attività industriali nelle regioni che si affacciavano sull’Adriatico; a partire da quelle del Nord-est fino alle Marche. Queste prime intuizioni trovarono una più robusta sistemazione teorica nei primi anni ’80 con la stilizzazione del ‘modello NEC’ (Nord-est centro) da parte di Giorgio Fuà (fondatore della Facoltà di Economia ad Ancona) e con la riscoperta e rivitalizzazione della categoria del distretto industriale da parte di Giacomo Becattini (economista dell’Università di Firenze). In tutti questi autori era ben salda la convinzione che a caratterizzare la ‘terza Italia’ (come veniva definita nel libro di Bagnasco) non fosse solo l’economia, e in particolare la struttura industriale, ma anche l’organizzazione sociale e i valori fondanti le comunità locali. Non è un caso che tutti questi autori fanno risalire le peculiarità della terza Italia a caratteri strutturali di lungo periodo; in particolare l’organizzazione agricola preesistente all’espansione industriale, fondata sul sistema mezzadrile e sulla piccola proprietà coltivatrice. La famiglia colonica, diffusa in queste regioni, avrebbe fatto da incubatore del sistema di industrializzazione diffusa affermatosi nel secondo dopoguerra. Queste peculiarità dell’organizzazione economica e sociale si traducevano anche in specifici orientamenti politici, significativamente diversi nelle regioni della terza Italia rispetto a quelle delle altre due aree. Le differenze, come noto, erano particolarmente evidenti nelle regioni cosiddette ‘rosse’: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche.
Non mancavano e non mancano, ovviamente, le differenze fra le regioni della terza Italia, sia sul piano dello sviluppo industriale sia sul piano sociale. Tuttavia, gli elementi di similitudine sembravano prevalenti. Fra questi anche la rilevanza delle istituzioni ‘intermedie’, dai partiti alle associazioni e alle istituzioni locali, che hanno svolto un ruolo rilevante di indirizzo e rappresentanza soprattutto nelle regioni, come le Marche, dove lo sviluppo industriale è avvenuto in assenza di significativi interventi da parte dello stato centrale.
I confini di questa ‘terza Italia’ sembrano del tutto cancellati dalla distribuzione delle quote fra i principali schieramenti nelle ultime elezioni politiche; se si eccettua la tenuta del centro- sinistra in alcuni collegi della Toscana e della Romagna. Per il resto prevale una spaccatura del paese fra centro destra al centro-nord e movimento cinque stelle al sud. Il taglio, però, non è lungo la linea est-ovest poiché la prevalenza del Movimento Cinque Stelle risale lungo la linea adriatica fino a Pesaro. Nella generale prevalenza della volontà di cambiamento le Marche sono accomunate alle regioni del sud nell’espressione del disagio sociale ed economico piuttosto che alle istanze delle regioni più sviluppate del nord.
Negli scorsi mesi alcuni commentatori su questo giornale (‘Corriere Adriatico’ ndr) hanno evidenziato il rischio di un progressivo ‘scivolamento’ delle Marche verso le regioni del sud Italia, per effetto delle difficoltà indotte dalla lunga crisi. I risultati elettorali sembrano fornire conforto a questa tesi. Non del tutto fondata se si considerano i livelli dei principali indicatori economici e sociali, che rimangono ancora decisamente superiori rispetto alle regioni del mezzogiorno. I risultati elettorali dimostrano però che non sono tanto i livelli degli indicatori a contare quanto piuttosto la loro variazione, che negli ultimi anni è stata quasi sempre in negativo. È mia convinzione che la situazione di disagio, sociale ed economico, è accentuata non solo dall’andamento recente dell’economia ma anche dalla mancanza di prospettive per il futuro. Alla crisi del ‘modello marchigiano’ non si è ancora sostituita una visione delle nuove prospettive di sviluppo; e, di conseguenza, di una strategia capace di indicare obiettivi e mobilitare risorse. È la principale sfida che attende le nuove élite politiche, al governo come all’opposizione.