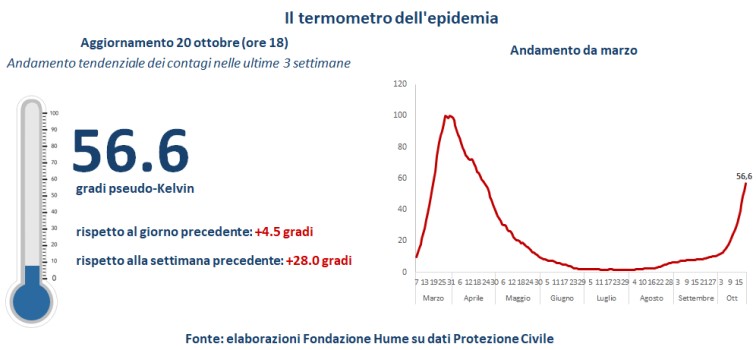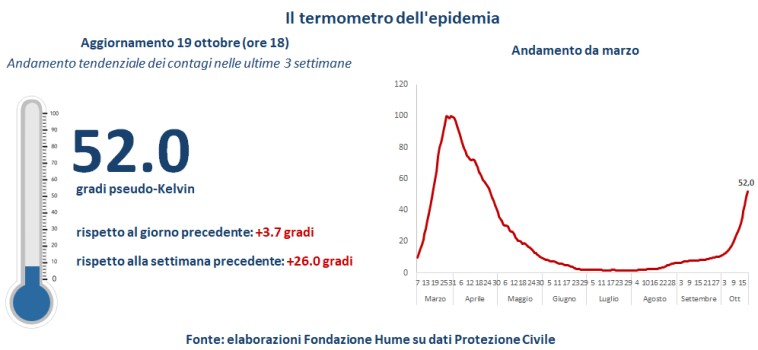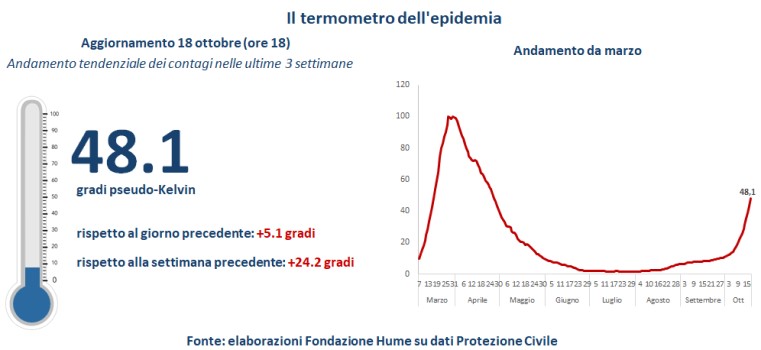Panoramica globale. La maggior parte dei paesi europei sta riportando un’accelerazione esponenziale nel numero di casi. Mentre i Paesi in cima alla lista sono relativamente piccoli (per es., Andorra, Montenegro), numerosi altri Paesi (per es., Francia, Spagna, Italia, Olanda, Belgio, Regno Unito) più popolosi figurano anch’essi in cima alla lista. Il trend bisettimanale sia in termini di numero di casi che mortalità è positivo per quasi tutti i Paesi in Europa, e molti di questi stanno riportando un aumento superiore al 100% nelle ultime due settimane (Italia: 205%, Germania: 125%, Regno Unito: 151%, Svizzera: 292%, Polonia: 249%, Repubblica Ceca: 173%, Croazia: 175%). Un elevato numero di Paesi europei sta anche riportando trend preoccupanti relativi alla positività dei test (+10% negli ultimi 7 giorni), dato che suggerisce che la capacità di testing potrebbe non essere sufficientemente accurata per catturare la reale diffusione del virus.
Le cose non stanno andando meglio negli Stati Uniti, dove il numero di casi confermati ha superato gli 8 milioni di casi e i 218mila decessi (i decessi per un milione di abitanti nel Paese sono 668.84—peggio, al momento, stanno facendo solo Perù, Belgio, Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador, Spagna e Messico). Il trend nel numero di nuovi casi continua a crescere. Sono almeno metà gli Stati del Paese che hanno riportato almeno 100mila casi, inclusi California e Texas con più di 800mila, la Florida con più di 700mila, New York con più di 400mila, Georgia e Illinois con più di 300mila e Arizona, New Jersey, Nord Carolina e Tennessee con più di 200mila.
In America Centrale, i trend sono abbastanza stabili o addirittura decrescenti: Messico e Panama—intensi focolai fino a pochi mesi fa—stanno riportando cali rispettivi del 38% e del 40% rispetto ai loro picchi. Il Messico rimane in cima alla lista in termini di nuovi casi giornalieri, ma il dato non è particolarmente sorprendente visto che il Paese include il 70% della popolazione totale della regione. A livello per capita, il Costa Rica è in cima alla lista con 233 casi giornalieri per un milione di persone. Il Belize sta riportando un aumento drammatico nel numero di casi, passati da 1.3 a inizio agosto ai 49 di questi giorni.
Un numero significativo di Paesi in America Latina sta riportando un calo nei trend del numero di nuovi casi giornalieri, inclusi Brasile, Colombia, Perù e Suriname. Il Brasile rimane in cima alla lista in termini di nuovi casi giornalieri, ma la media è calata del 56% rispetto al picco di luglio (il Paese ha però riportato più di 5 milioni di casi totali). L’eccezione in America Latina è l’Argentina, primo paese dell’area per numero di nuovi casi per capita (293 casi giornalieri per un milione di persone), con trend nel numero di nuovi casi in salita. Anche il Guyana sta riportando un aumento significativo nel numero di nuovi casi, ma rimane un numero relativamente basso rispetto alla media dei Paesi dell’area. Il trend nel numero di decessi segue quello del numero di nuovi casi.
L’incidenza nel numero di nuovi casi a Israele è decresciuta del 50% rispetto al picco di inizio ottobre (in relazione al numero di nuovi casi giornalieri per capita, Israele era numero uno al mondo a inizio ottobre, ora non rientra nella top 10)—il drammatico primato è di Andorra, che sta riportando più di 1.000 casi giornalieri per un milione di persone (è il primo Paese al mondo a riportare questo numero). L’Andorra ha una popolazione di 77mila persone, per cui la crescita corrisponde a circa 80-85 nuovi casi giornalieri. L’incidenza nel numero di nuovi casi in India continua a decrescere rispetto al picco di metà settembre, ma il Paese ha superato i 7 milioni di casi cumulativi. E’ probabile che, continuando con questo trend, l’India sorpassi presto gli Stati Uniti per numero totale di casi.
Per la maggior parte della pandemia, l’incidenza di Coronavirus in Africa è stata ampiamente trainata dall’epidemia in Sud Africa, che ha superato il suo picco di metà giugno (12.500 casi al giorno) e da allora è progressivamente calata. Al momento, solo 5 Paesi africani stanno riportando più di 500 nuovi casi giornalieri: Marocco, Sud Africa, Tunisia, Libia ed Etiopia (da soli, questi Paesi rappresentano il 75% dei casi totali del continente). Tutti gli altri Paesi africani stanno riportando meno di 250 nuovi casi al giorno. Se guardiamo ai dati per capita, Capo Verde è in cima alla lista, con 157 casi giornalieri per un milione di persone. Nessun altro Paese africano sta riportando più di 100 casi giornalieri per un milione di persone; solo 3 ne stanno riportando più di 50: Libia, Tunisia e Marocco. Tutti i Paesi rimanenti stanno riportando un’incidenza per capita inferiore alla media globale (37.5 casi giornalieri per un milione di persone), e tutti tranne 8 stanno riportando meno di 10 casi giornalieri per un milione di persone. A inizio pandemia si temeva che la capacità di testing della maggior parte dei Paesi del continente, nonché la mancanza di sistemi di tracciamento e segnalazione adeguati, influissero negativamente sulla capacità di comprendere l’estensione dell’epidemia. Tuttavia, durante gli ultimi mesi, la maggior parte dei Paesi africani ha continuato a ripotare un’incidenza abbastanza bassa (simile a quella dell’Oceania, per intenderci). L’incidenza globale, al momento, è 6 volte quella africana, e quelle europee, del Nord America e del Sud America sono rispettivamente 14, 16 e 23 volte più alte rispetto a quelle dell’Africa.
La Nuova Zelanda ha riportato il primo caso di Coronavirus in più di tre settimane. Nella regione di Victoria, in Australia (la regione colpita più duramente da inizio pandemia, che negli ultimi mesi è stata soggetta ad uno dei lockdown più severi al mondo), è stato registrato un solo caso nella giornata del 17 ottobre. La regione, che include la città di Melbourne, si sta preparando ad allentare alcune restrizioni.
Pattern stagionale. Come riportato in un commentario su Nature a fine agosto, il clima influenza la trasmissione del virus in tre modi: (i) la persistenza di SARS-CoV-2 sulle superfici o nell’aria è sensibile a temperatura, umidità e luci ultraviolette (ci sono dati sperimentali a sostegno di questa ipotesi); (ii) altri virus respiratori seguono pattern stagionali, e sono più comuni in autunno e inverno e pertanto (iii) gli effetti climatici pesano sia a livello spaziale (posti caldi e asciutti = meno trasmissione) che a livello temporale (estate < inverno). Questo aiuterebbe a spiegare il fatto che l’epidemia sia ripartita nei paesi del Nord appena comincia la stagione fredda, e si sia attenuata in molti paesi sub-equatoriali all’arrivo della stagione calda.
Gli autori del commentario sostengono anche che queste evidenze, spesso basate su studi parziali o con risultati marginalmente significativi, inducano spesso ad adottare conclusioni errate e potenzialmente dannose. Per esempio, studi che dimostrano che la luce ultravioletta germicida usata negli ospedali e nei laboratori uccida il virus sono stati presentati come evidenza del fatto che il sole neutralizzi il virus negli spazi esterni. È vero che studi recenti sembrano dimostrare l’effetto della luce del sole su SARS-CoV-2, ma è vero anche che uno studio globale ha trovato che l’effetto della riduzione dovuto ai raggi ultravioletti è dell’1%.
L’ondata estiva degli Stati Uniti, che tra fine giugno e inizio luglio ha raggiunto picchi comparabili a quelli primaverili, suggerisce che il virus non smetta di trasmettersi nelle stagioni calde. Questo non significa che si trasmetta meno nelle stagioni calde che nelle stagioni fredde, come indicano i trend di queste settimane. In un articolo pubblicato a maggio su Science, un gruppo di scienziati ha previsto, relativamente al nuovo Coronavirus, il seguente pattern stagionale: nel caso in cui il virus diventi endemico (cioè nel caso in cui non si riesca a controllarlo sul lungo periodo), potrebbero svilupparsi alcune oscillazioni stagionali simile a quelle dei virus influenzali. Tuttavia, la suscettibilità attuale a SARS-CoV-2 è alta abbastanza per suggerire che il clima estivo non basti a limitare i rischi di trasmissione.
(Il fatto che gli Stati Uniti, a differenza dell’Europa, abbiano avuto una seconda ondata estiva molto significativa potrebbe spiegarsi perlopiù in relazione al seguente dato: secondo alcune analisi pubblicate dal New York Times sulle celle telefoniche, al picco del loro lockdown gli americani hanno, in media, limitato i loro spostamenti del 34%. Gli europei dell’85%).
Conseguenze generali a lungo termine dell’infezione. Un commentario pubblicato a inizio ottobre su JAMA descrive alcune delle conseguenze a lungo termine del nuovo Coronavirus, a nove mesi da inizio pandemia. Nonostante gli effetti a lungo termine siano più severi per persone che hanno avuto un’infezione più grave (per es., le persone finite in terapia intensiva), alcuni effetti a lungo termine si sono osservati anche in persone che hanno avuto sintomi meno gravi. I più riportati sono fatica, dispnea, dolori alle articolazioni generalizzati e dolori al petto.
Gli autori del commentario descrivono anche disturbi specifici emersi prevalentemente in tre sistemi di organi: cardiovascolari, polmonari e neurologici. Nel sistema cardiovascolare sono stati riportati, a diversi livelli di gravità dell’infezione (inclusi pazienti con sintomi lievi e pazienti giovani e senza comorbidità, tra cui atleti sportivi), miocarditi e danni miocardici. Nei polmoni, uno studio riportato nel commentario ha trovato che più del 60% dei pazienti ha sintomi persistenti di disfunzioni polmonari tre mesi dopo essere stati dimessi dall’ospedale. Un altro studio ha trovato diminuzione della forza muscolare polmonare in almeno il 50% dei pazienti 30 giorni dopo le dimissioni dall’ospedale. Comuni, anche se meno frequenti, sono anche le conseguenze neurologiche a lungo termine, che includono anosmia (perdita dell’olfatto) e ageusia (perdita del gusto), ma anche encefaliti, convulsioni, sbalzi d’umore, “annebbiamento cerebrale” (guarda sotto: “Conseguenze sul sistema nervoso”).
A conseguenza dell’infezione sono stati osservati anche sintomi clinici come perdite permanenti dell’udito, perdita dei capelli, ed eruzioni cutanee.
Conseguenze dell’infezione a lungo termine su popolazioni a basso rischio. Per il momento, la ricerca sulle conseguenze del nuovo Coronavirus si è concentrata su persone relativamente anziane con comorbidità e sugli effetti che il virus ha su singoli organi. Una nuova ricerca ha studiato l’impatto che ha il long-COVID (= sintomi persistenti fino a tre mesi dall’infezione) su diversi organi in popolazioni a basso rischio.
Tra aprile e settembre, 201 persone (età media = 44 anni; 70% donne, 87% caucasici, 31% lavoratori nel sistema sanitario) hanno partecipato allo studio—la durata media della loro infezione è stata 140 giorni. Prevalenza di condizioni pre-esistenti: bassa (20% obesità, 6% ipertensione, 2% diabete, 4% problemi di cuore). Nessuno di questi individui è stato ospedalizzato. I sintomi a lungo termine più riportati sono stati: fatica (98%), dolore muscolare (88%), fiato corto (87%), mal di testa (83%). Al momento dello studio, il 92% dei partecipanti stava ancora riportando sintomi cardiorespiratori (92%) e/o gastrointestinali (73%). Il 42% degli individui stava riportando ancora almeno dieci sintomi. Per determinare gli effetti su diversi organi dell’infezione a lungo termine, i ricercatori si sono avvalsi di: questionari standardizzati, analisi del sangue, risonanze magnetiche, consenso tra esperti.
Risultati: La maggior parte dei partecipanti ha riportato danni ad uno (66% dei partecipanti) o più (25% dei partecipanti) organi: cuore (32%), polmoni (33%), reni (12%), fegato (10%), pancreas (17%), milza (6%). Inoltre, la presenza di questi danni si correlava positivamente con il rischio di ospedalizzazione.
Implicazioni: In una popolazione giovane e a basso rischio con sintomi persistenti, circa il 70% degli individui ha riportato danni ad uno o più organi circa quattro mesi dopo l’infezione. Questi risultati hanno implicazioni sulla salute pubblica, e sugli effetti che l’infezione ha su popolazioni a basso rischio senza comorbidità.
Conseguenze sul sistema nervoso. Il New York Times ha pubblicato di recente un’analisi delle conseguenze che l’infezione di Coronavirus può avere sul sistema nervoso. La condizione a lungo termine, a cui gli esperti si riferiscono come “annebbiamento cerebrale”, sta affliggendo migliaia di pazienti, e include i seguenti sintomi persistenti: perdita di memoria, confusione, difficoltà di concentrazione, vertigine e afasia. Gli scienziati non hanno ancora identificato le cause di questa condizione, che si presenta anche in pazienti con sintomi da COVID lievi e senza comorbidità. Secondo la teoria più in voga, questa condizione si presenta quando la risposta immunitaria del corpo all’infezione non si “spegne”, o a causa di un’infiammazione dei vasi sanguini che portano al cervello.
Uno studio condotto in Francia ad Agosto su 120 pazienti ospedalizzati ha riportato che, mesi dopo l’infezione, il 34% di loro ha avuto perdita di memoria e il 27% problemi di concentrazione. In uno studio che verrà pubblicato a breve dei Survivor Corps—un gruppo di persone che hanno creato una rete per discutere le conseguenze sulla vita dopo il COVID—più di metà dei quasi 4.000 pazienti sotto analisi ha riportato difficoltà a concentrarsi (quarto sintomo più comune riportato, inclusi i sintomi fisici), mentre più di un terzo ha riportato problemi di memoria, vertigini o confusione.
La condizione rimane un mistero per gli scienziati, anche perché risonanze magnetiche funzionali non hanno indicato la presenza di aree del cervello danneggiate. Tuttavia, la condizione ha effetti misurabili reali e sta affliggendo la vita di migliaia di persone. “Mi sento come se avessi una demenza”, ha detto una persona intervistata al New York Times.
Dinamiche di trasmissione. Un nuovo studio pubblicato dal Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie statunitense ha esaminato le dinamiche di trasmissione del nuovo Coronavirus tra diversi gruppi di età in alcuni dei posti più colpiti del Paese durante l’ondata estiva. Nello specifico, lo studio si è focalizzato su 767 contee che hanno registrato focolai a giugno e luglio—definizione operativa di focolaio: più di 100 casi riportati in un periodo di 7 giorni e aumento nel trend rispetto ai 3-7 giorni precedenti. In questo criterio rientravano il 24% di tutte le contee degli Stati Uniti e il 63% della popolazione generale.
Risultati: la positività dei test tra individui nelle fasce di età 0-17 e 18-24 ha iniziato ad aumentare circa 1 mese prima che la contea rientrasse nella definizione operativa di focolaio. A seguire, la positività nei test è aumentata progressivamente nei gruppi di età più anziani. In media, la positività nei test al momento in cui la contea rientrava nella definizione operativa di focolaio era più alta nella fascia 18-24 (14%), seguita dalla fascia 0-17 (11%). Da qui in poi, la positività mostrava un trend decrescente in relazione all’età: 25-44 (10%), 45-62 (8%), +65 (6%). Nel periodo preso in analisi, le regioni a Sud e Ovest degli Stati Uniti hanno riportato il più alto numero di positività tra tutti i gruppi di età; pertanto, queste sono state anche le regioni più colpite durante l’estate.
Implicazioni: i risultati supportano l’idea che la trasmissione tra segmenti più giovani della popolazione precedono l’aumento di trasmissione tra segmenti più anziani della popolazione.
Fatica da pandemia. Sempre il New York Times riporta come esaurimenti nervosi (lievi e non) e fatica stiano creando le condizioni che permettono al virus di riemergere anche dove si era riuscito a controllare. Nessuno è ancora in grado di determinare per quanto avremo a che fare con il virus o con l’assenza di terapie efficaci applicabili su larga scala, e senza una linea del traguardo in vista molte persone si stanno lasciando andare, finendo per affollare bar e feste familiari. In uno studio recente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che circa metà delle popolazioni nei Paesi colpiti stia provando una “fatica da pandemia”.
I segnali dello stress si stanno registrando sui comportamenti della popolazione: negli Stati Uniti per esempio, secondo Nielsen, le vendite di alcolici sono aumentate del 23% durante l’epidemia. Sempre negli Stati Uniti, anche le morti per overdose causate dalla crisi di oppiacei sono aumentate significativamente negli ultimi mesi. Il NYT riporta come nella contea di Cuyahoga, in Ohio (che include la città di Cleveland), ci sono state recentemente 19 morti per overdose in una settimana—molte più della norma. Il dottore della contea ha affermato che “Come molte persone, sarò contento di vedere il 2020 finire”. Ma la pandemia, con ottime probabilità, non sparirà magicamente nel 2021.
L’OMS suggerisce quattro strategie per fronteggiare la fatica da pandemia: (i) capire le persone e disegnare interventi targettizzati; (ii) coinvolgere le persone come parte della soluzione; (iii) aiutare le persone a ridurre il rischio mentre le si coinvolge a fare cose che le fanno star bene; (iv) riconoscere ed affrontare la natura delle difficoltà che le persone sperimentano.
Relativamente facile a dirsi; tutt’altro che facile a farsi. E’ fondamentale evitare di lasciarsi andare e continuare ad operare responsabilmente secondo le proprie capacità individuali, nella speranza che nella tarda primavera del 2021 un vaccino sicuro ed efficace diventi disponibile su larga scala (qualche giorno fa Anthony Fauci ha dato segnali incoraggianti in questo senso, ma è importante rimanere ancorati alla realtà, per quanto dura, e farsi poche illusioni). Da ogni individuo passa la capacità di reggere il tessuto sociale per come lo conosciamo; l’alternativa è il gregge, che senza garanzie d’immunità (questa settimana, 12mila esperti hanno condannato la strategia d’immunità di gregge come possibile soluzione al problema) rischia di degenerare in un caos collettivo che ha il potenziale di ridisegnare la civiltà per come la conosciamo.