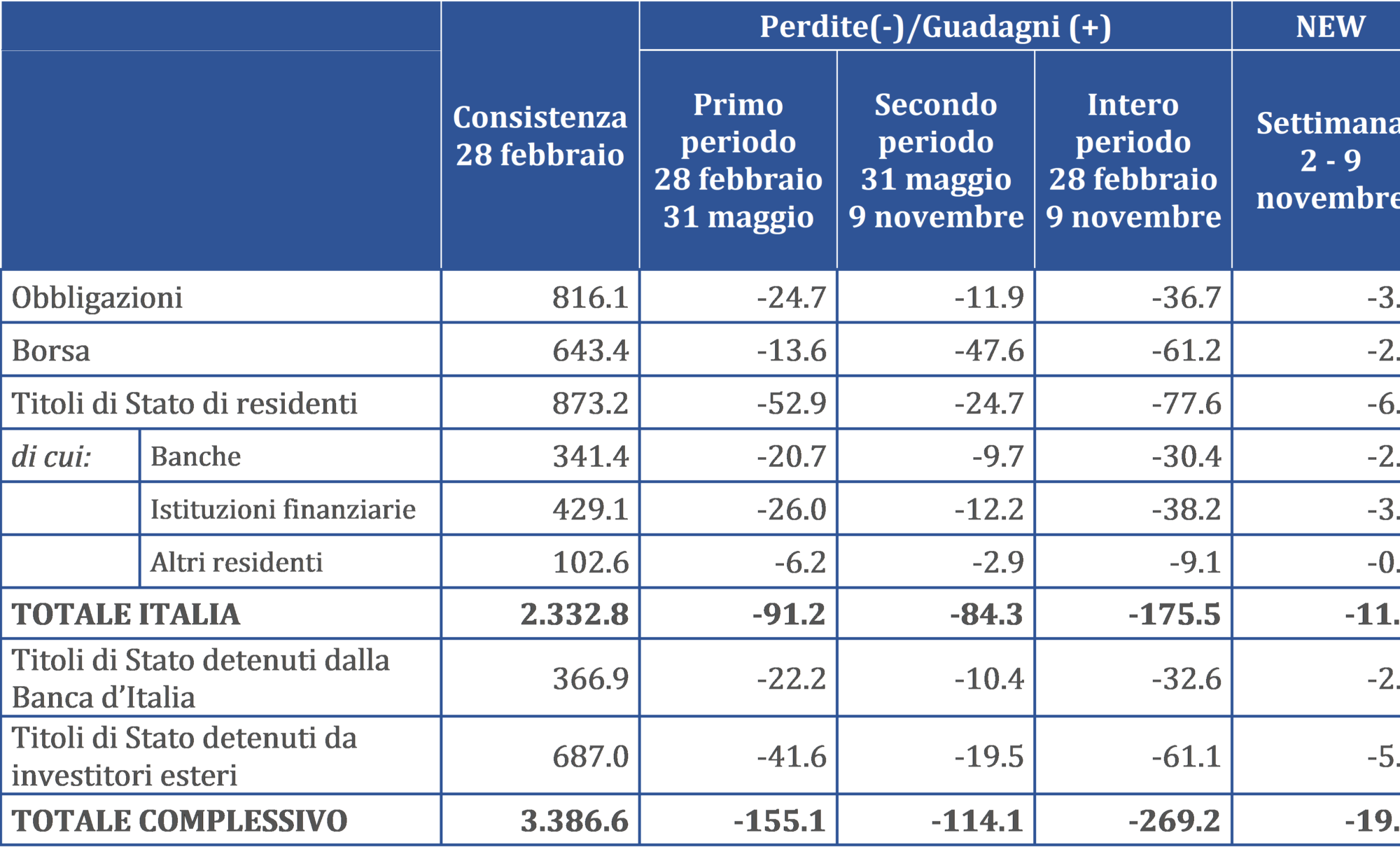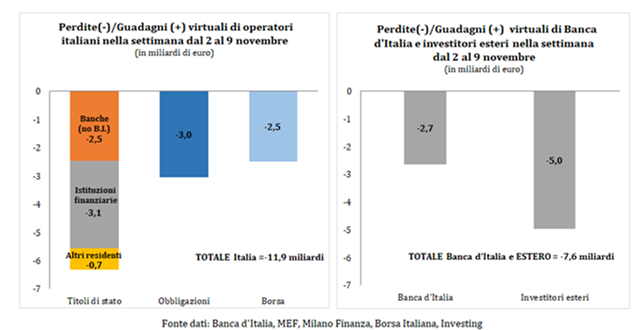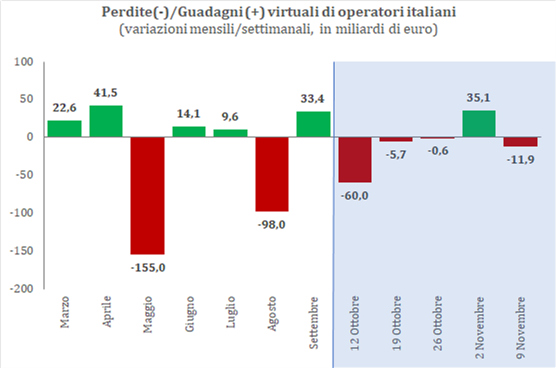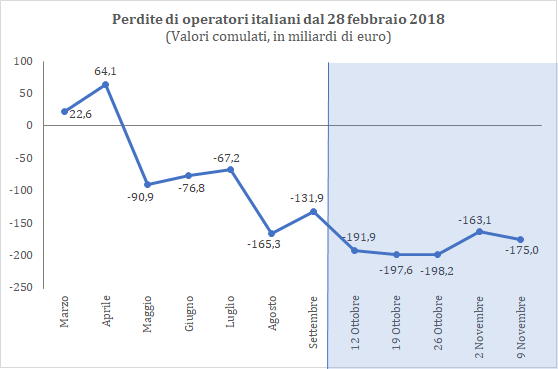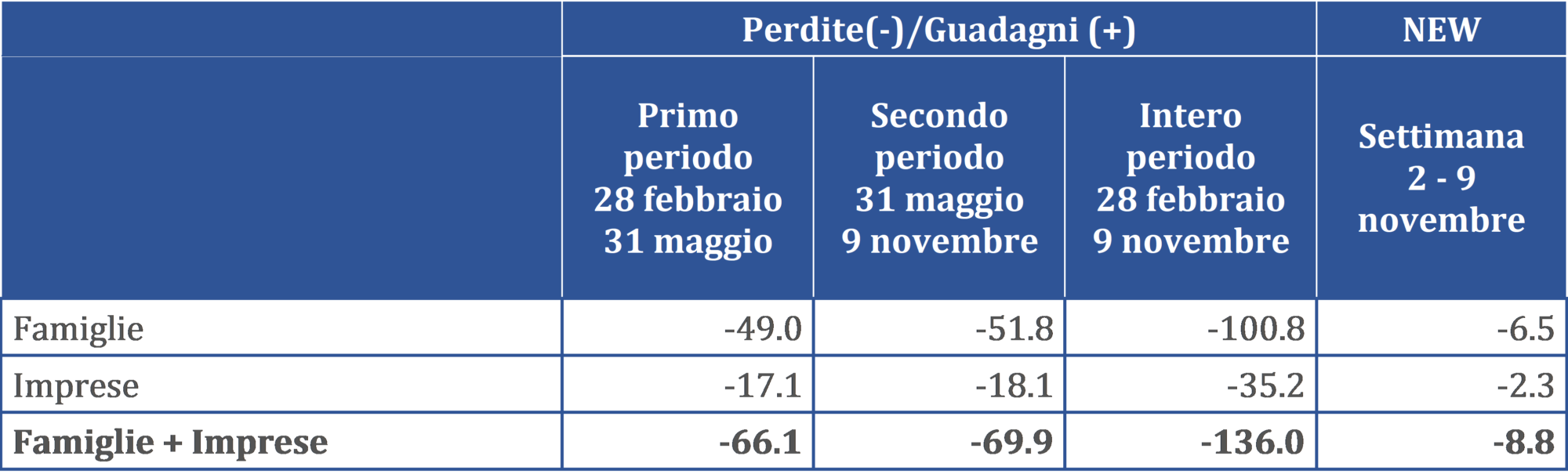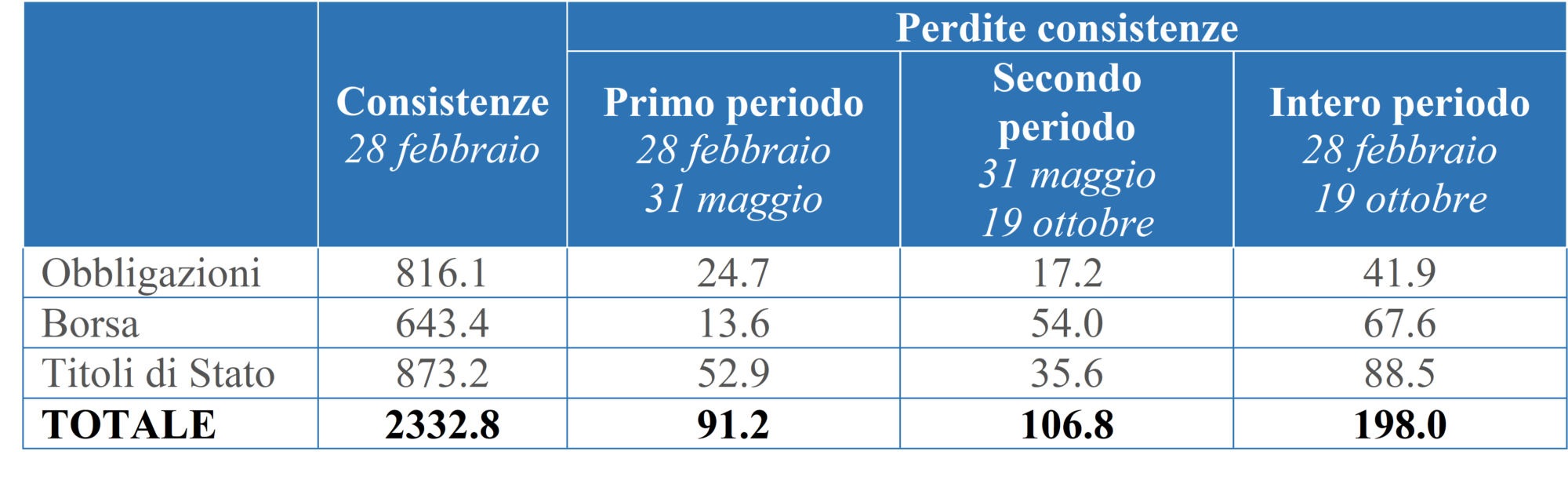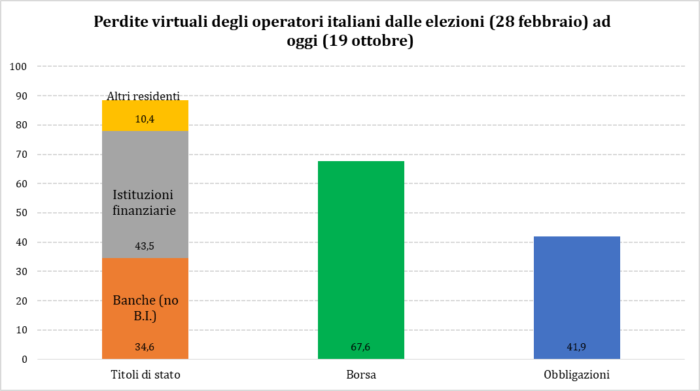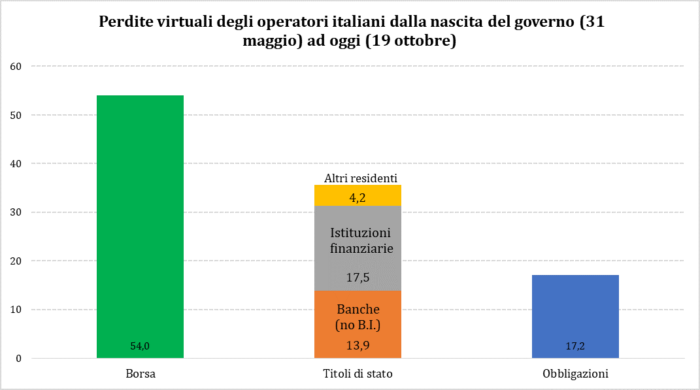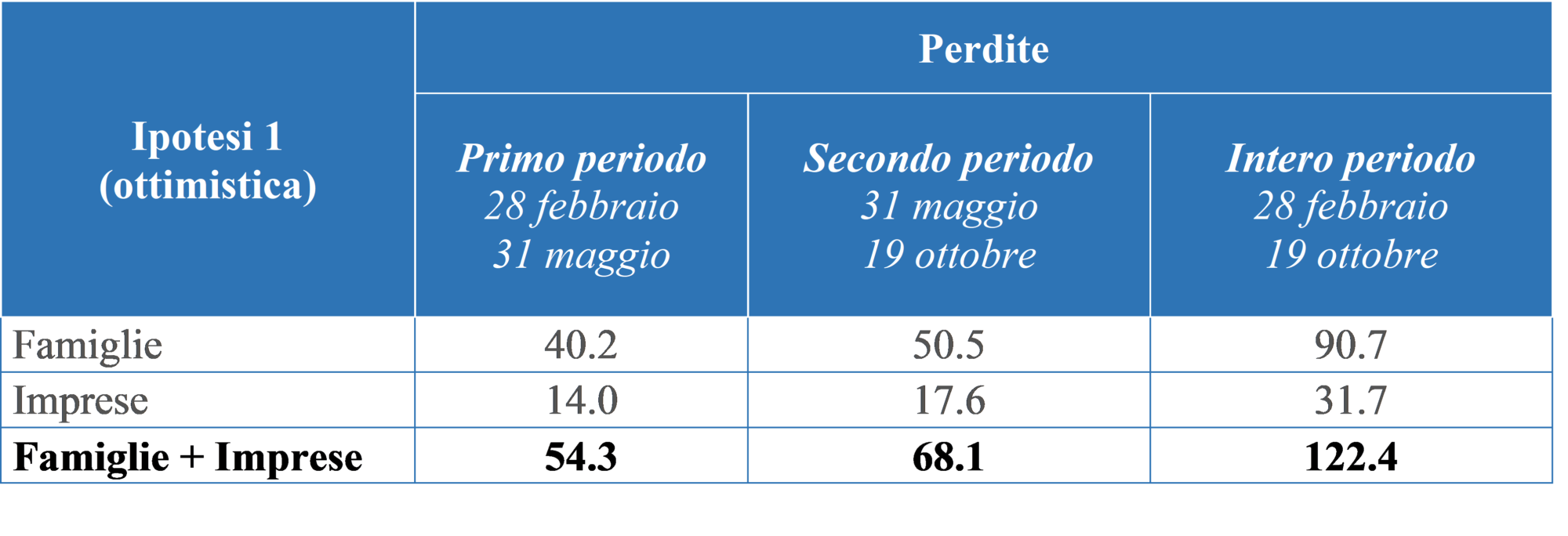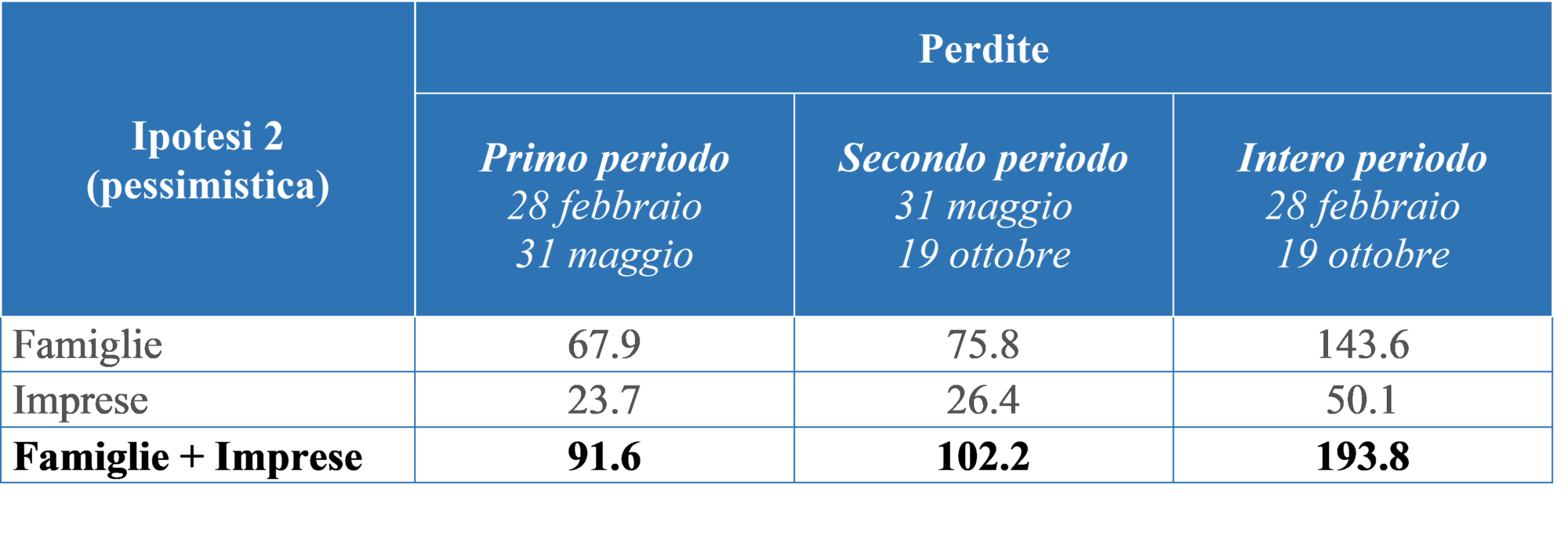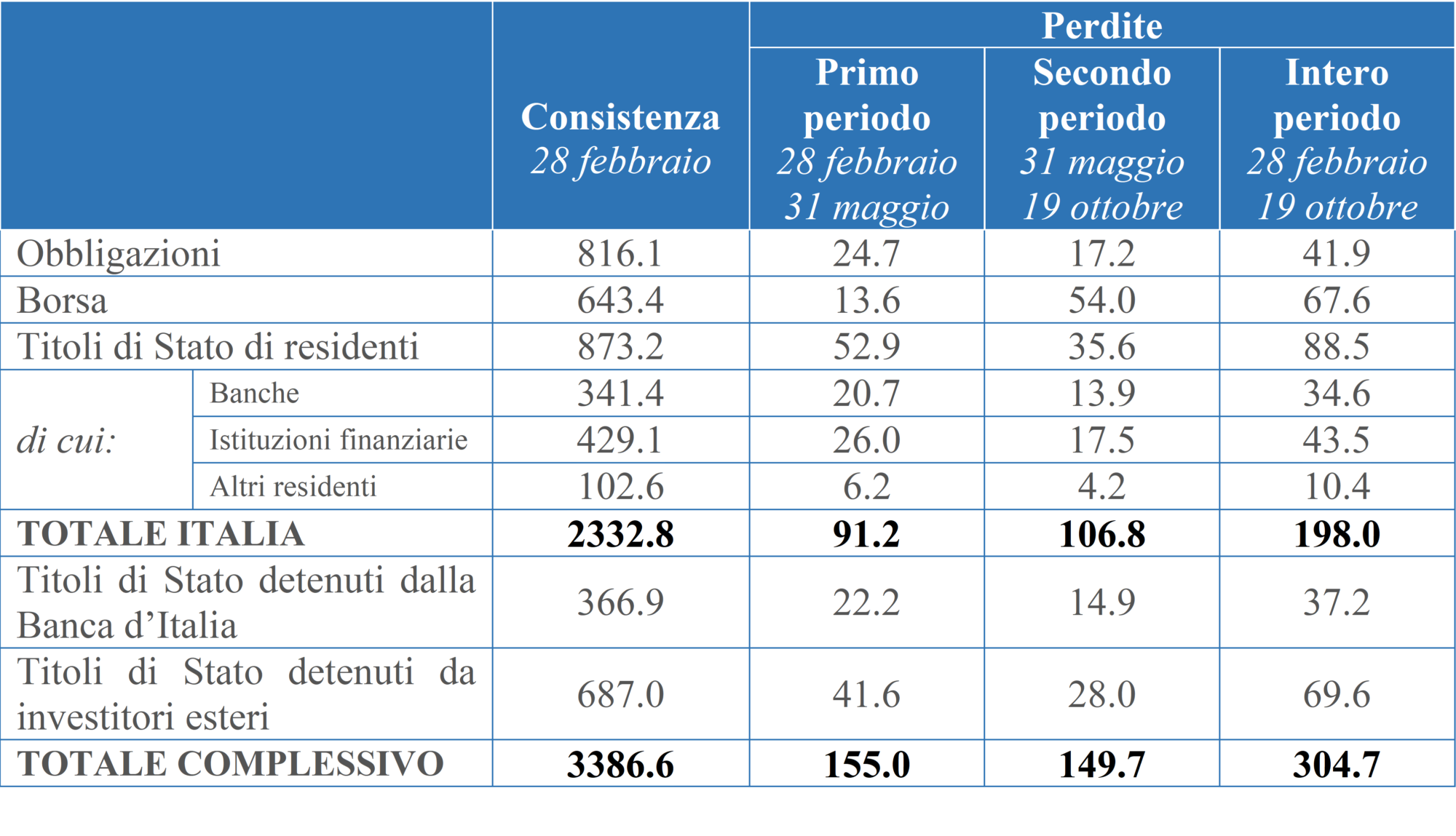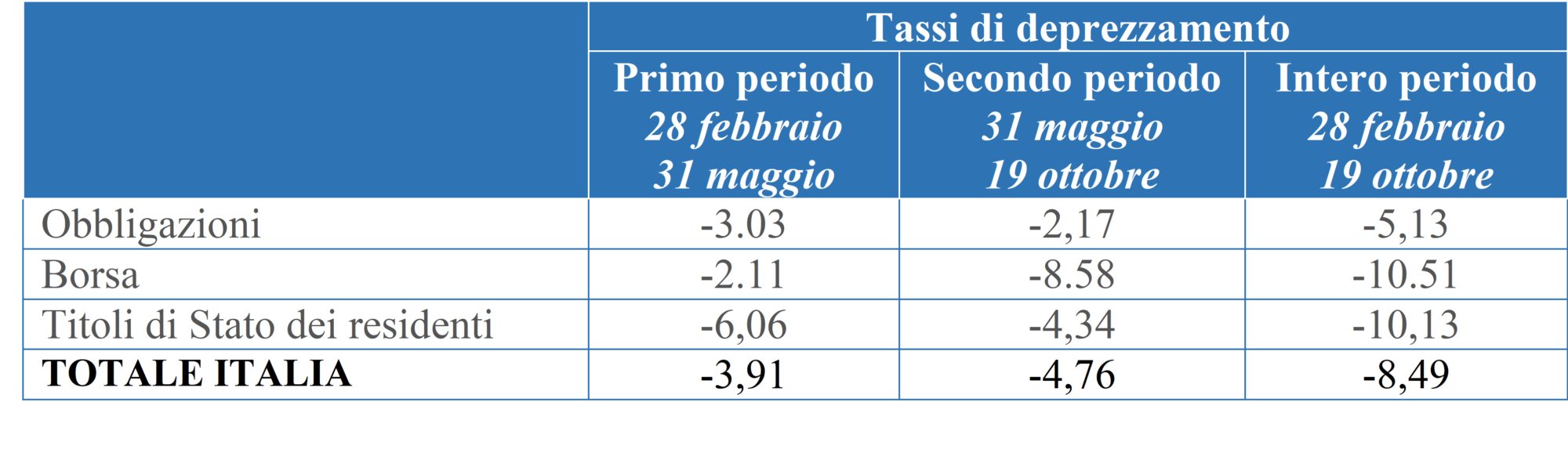Nel 1998, l’allora direttore della London School of Economics, Antony Giddens, scriveva The Third Way: The Renewal of Social Democracy, un saggio in cui parlava di una visione del mondo alternativa sia alle politiche liberiste di ampia fede nelle leggi del mercato, sia alle politiche stataliste di intervento esteso dello stato sui mercati. Giddens delineava appunto una terza via lungo la quale i partiti potessero proporre riforme pragmatiche dall’area politica del centro.
Soluzioni pratiche ai bisogni della gente, come la riforma del welfare introdotta da Bill Clinton nel 1996, con l’obbiettivo di ridurre la povertà e la disoccupazione; o l’espansione del settore privato nel National Health System del Regno Unito, riforma promossa da Tony Blair a partire dal 1997; oppure il programma di riforme sociali, fiscali e del lavoro introdotte da Gerhard Schröder nel 2003 in Germania, a cui molti hanno accreditato almeno in parte la resilienza dell’economia tedesca dopo la Grande Recessione del 2007-2011.
Negli anni Novanta, sembrava che questi leader avessero trovato la ricetta magica per coniugare protezione sociale e crescita economica, diritti dei lavoratori e interessi imprenditoriali, libertà civili ed eguaglianza sociale. Poi nel 2007 è arrivata la recessione, durante la quale i redditi sono caduti e le diseguaglianze sociali sono aumentate. Nel 2017 in Italia, il reddito medio pro-capite rimaneva del 10% inferiore a quello di dieci anni prima.[1] Negli Stati Uniti, la classe medio-bassa ha perso oltre il 40% di ricchezza nel periodo 2007-2010, mentre la classe medio-alta ha perso oltre il 20% di ricchezza nello stesso periodo, riuscendo entrambe a recuperare solo il 5% nei 6 anni successivi.[2] Poco sorprende se, oggi, pochi parlano ancora di una terza via socialdemocratica.
Cosa non ha funzionato a dovere? Tra il 1990 e il 2007, pochi hanno messo in luce gli aspetti negativi, soprattutto per alcune fasce sociali, della rapida globalizzazione di merci, servizi, capitali e persone. Così, mentre nel 2000 Bill Clinton diceva: “La globalizzazione non è qualcosa che possiamo interrompere o da cui possiamo astenerci. È l’equivalente in economia di forze della natura come il vento o l’acqua”,[3] e pochi anni dopo, nel 2005, Tony Blair ribadiva: “Sento persone dire che dobbiamo fermare la globalizzazione e discuterne. Sarebbe come discutere se l’autunno deve seguire l’estate”,[4] la globalizzazione creava distorsioni nel mercato del lavoro di tanti paesi occidentali, aumentando diseguaglianze sociali e, almeno nel breve periodo, creando nuovi disoccupati.
Uno dei pochi “cantori del dubbio” era Dani Rodrik, economista di Harvard, che nel 1997 scriveva un libro premonitore, Has globalization gone too far?, in cui parlava apertamente delle problematiche insite in un mondo globalizzato che coesiste con dinamiche sociali, economiche e culturali necessariamente nazionali. La globalizzazione ha creato da almeno vent’anni una divisione tra fasce sociali con alti livelli di formazione e capacità tecniche, che ne traggono vantaggio, e fasce sociali senza la formazione e le capacità per trarne vantaggio. Una divisione tra vincenti e perdenti, dove i primi non si sono preoccupati del malessere generalizzato dei secondi, né tantomeno di mettere in atto quegli ammortizzatori necessari affinché il contratto sociale reggesse il peso di questo rapido cambiamento epocale. I vincitori non si sono resi conto che avrebbero risentito, ancor di più dei perdenti, dell’instabilità sociale causata dalla globalizzazione.
In un mondo sempre più globalizzato, ma allo stesso tempo basato geo-politicamente su stati-nazione che non vogliono abbandonare le proprie prerogative politiche interne, come si coniugano crescita economica e protezione sociale? Come si rinnova il contratto sociale interno e allo stesso tempo si promuove la pace tra le nazioni? Serve una nuova narrativa politica, che prenda il meglio della radicale offerta riformista, pragmatica e post-ideologica, che sia supportata da rigorosa evidenza empirica e sappia renderla rilevante ai valori e ai bisogni della gente. Serve una nuova visione del mondo semplice, chiara, puntuale e soprattutto una visione che colleghi efficacemente le riforme proposte con le sensazioni fisiche ed emotive della gente, spesso determinanti a formarne la percezione degli eventi ancor più dei fatti.[5] Questa narrativa deve articolare un nuovo modo di stare assieme, che metta al centro l’individuo immerso nelle proprie relazioni sociali locali, ma allo stesso tempo anche parte di un mondo sempre più interconnesso.
Negli ultimi dieci anni, le forze liberal-democratiche e progressiste delle democrazie occidentali sono state incapaci di offrire una narrativa politica che rispondesse in modo efficace e puntuale alle problematiche socioeconomiche sollevate dalla globalizzazione. E anche quando hanno offerto le migliori risposte riformiste ai mutamenti in corso, queste forze hanno peccato di mancanza di umiltà nel connettersi con un mondo che stava velocemente cambiando, e soprattutto nell’elaborare una visione del futuro che recepisse i bisogni e le emozioni della gente. Come si spiega, altrimenti, la mancata rielezione di un democratico alla Casa Bianca nel 2016? Risultato atteso, visto come Barack Obama aveva gestito il recupero dell’economia americana. Sull’orlo del collasso nel 2007, il governo di Obama ha offerto prestiti pubblici per oltre 830 miliardi di dollari a banche, imprese e società di assicurazioni, quando non era scontato che questi prestiti avrebbero aiutato l’economia a risollevarsi, salvando così interi settori industriali e gli annessi posti di lavoro.[6] Il suo successore alla Casa Bianca, Donald Trump, nel suo discorso di inaugurazione del gennaio 2017, ha promesso invece di mettere fine al “massacro degli americani” conseguenza della recessione. Una catastrofica lettura della situazione socioeconomica americana, diametralmente opposta a quella offerta da Obama alla fine del suo mandato, tutta incentrata sullo straordinario salvataggio dell’economia intrapreso con successo dal suo governo.
A partire dal 2000 e sempre di più dopo la grande recessione, sono stati i movimenti populisti che hanno invece saputo offrire una risposta forte e convincente ai problemi della gente, elaborando narrative politiche efficaci e facilmente comprensibili.[7] Nati negli Stati Uniti con la creazione del People’s Party nel 1891, inizialmente mobilitarono contadini e piccoli imprenditori contro le élite che dominavano le grandi aziende e la politica. Nel secolo scorso si diffusero in America Latina, nelle accezioni sia di sinistra che di destra, e in Europa, soprattutto nell’incarnazione fascista. Dal 2000 in poi, in Europa i movimenti populisti hanno promosso e ottenuto la Brexit nel Regno Unito, introdotto la cosiddetta democrazia illiberale in Ungheria, cooptato e accompagnato al governo la destra in Austria e Italia, governato stabilmente in Polonia. Negli Stati Uniti, Trump è al potere, contro ogni aspettativa, da quasi due anni. Fino ad oggi, le fondamenta liberal-democratiche di questi paesi hanno tenuto, incluso in Ungheria e Polonia, anche grazie all’Unione Europea e al forte sistema di checks and balances della democrazia americana. In futuro non sappiamo come e quanto queste fondamenta dureranno. Come si rinnoverà la fiducia nel liberalismo occidentale del XXI secolo?
Il minimo comune denominatore della narrativa politica messa in campo dai movimenti populisti si basa sull’ostilità verso l’immigrazione, su una palese avversione verso lo stato di diritto interno e il sistema globale di relazioni politiche e commerciali, sull’assistenzialismo verso cittadini e imprese, su una buona dose di autoritarismo, e su un utilizzo poco ortodosso del debito pubblico come strumento finanziario per realizzare le proprie proposte. Quasi sempre a ciò si unisce un nemico esterno che assume varie forme tra cui quella dell’Unione Europea, della Cina, delle élite liberal-democratiche, inclusi i tecnici, i professori, gli esperti e i media. Questa narrativa si basa su uno stato di continua tensione durante la quale i cittadini vengono mobilitati per difendersi da un nemico che li ha quasi sempre derubati di ciò che spettava loro “naturalmente”, allontanandoli da uno stato di natura perso da tempo al quale si aspira invece a ritornare. Uno stato di natura che quasi sempre include società e culture omogenee, poco dissenso, poco dibattito su proposte politiche alternative, un’economia tendenzialmente autarchica (“America First!”, “Prima gli Italiani!”) e l’uso della forza reale o figurata come strumento per prevalere politicamente. Questa narrativa si è rivelata efficace perché ha saputo dare una risposta specifica e diretta ai bisogni concreti della gente, ad ambo i lati dello spettro politico, ed è in particolare riuscita ad incoraggiarne la radicalizzazione.
Negli Stati Uniti, durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2016, Donald Trump ha proposto di costruire un muro con il Messico per arginare il flusso fuori controllo di immigrati, aumentare la sicurezza e dare quindi più lavoro agli americani. Una narrativa chiara, semplice, che risponde al sistema di valori di quella parte della società americana che chiede più sicurezza e più lavoro e teme che l’esistenza della propria cultura sia messa in pericolo dall’apertura degli Stati Uniti al Messico come al resto del mondo. Poco importa se questa narrativa non è supportata da una chiara evidenza empirica.[8] Allo stesso modo, in politica commerciale, Trump ha proposto di alzare le tariffe doganali per proteggere il lavoro e le imprese americane. Anche in questo caso, il messaggio è semplice, diretto, ben collegato ai valori statunitensi di equità e patriottismo. E anche in questo caso, la narrativa non è supportata dai dati.[9]
In Italia la coalizione Lega-M5S oggi al governo, con oltre il 57% del consenso degli italiani a inizio novembre 2018,[10] porta avanti una simile narrativa politica, precisa e costantemente ripetuta nei media. Tra i messaggi chiave, per esempio, la Lega si è focalizzata su “meno immigrazione, perché l’immigrazione porta insicurezza e toglie lavoro agli italiani”. Messaggio semplice e diretto, che dà una risposta concreta al bisogno di maggiore sicurezza e più lavoro. E anche in questo caso la narrativa non è supportata dall’evidenza empirica: oggi l’ingresso di immigrati regolari e irregolari in Italia è drasticamente diminuito rispetto al 2017, la loro presenza non è necessariamente collegata a un incremento della criminalità e gli immigrati non tolgono lavoro agli italiani.[11] Allo stesso modo, il M5S invoca “meno casta e lotta alla povertà”. Il messaggio “meno casta” risponde all’insofferenza popolare verso gli abusi di potere dei politici, ben documentati negli anni da ripetuti scandali. Eppure, la promozione di un approccio pauperistico alla politica è tanto efficace al ritorno d’immagine quanto poco effettivo nello sradicare la corruzione legata alla politica, se non bloccare tanti investimenti in infrastrutture e grandi opere. “Lotta alla povertà” invece risponde al bisogno dei cittadini meno abbienti di protezione sociale. Dalla recessione del 2007-11 in poi, varie fasce di italiani hanno visto il proprio reddito pro-capite stagnare o, al peggio, calare.[12] Ciononostante, la proposta del reddito di cittadinanza non aiuta la classe media, vero motore dello slancio produttivo di cui l’Italia ha bisogno, mentre offre solo un palliativo ai cittadini più poveri che oggi sono aiutati, almeno in parte, dal reddito di inclusione e da altre misure di contrasto alla povertà. Poco importa quindi se le risposte date alla domanda di “meno casta e lotta alla povertà” siano controproducenti o inadeguate.
Quale narrativa è stata proposta sull’altro versante dello spettro politico? Come hanno risposto i democratici americani ed italiani alla visione del mondo proposta dai movimenti populisti su ambo i lati dell’Atlantico? Come hanno saputo leggere gli scompensi socioeconomici provocati dalla globalizzazione e utilizzato le numerose ricette di riformismo radicale a loro disposizione per raccontare un nuovo mondo possibile? Tentennando, nel migliore dei casi, e opponendosi alle narrative populiste, nel peggiore. Fornendo numeri, dati, statistiche, elenchi di cose fatte e da fare, articolando in maniera poco efficace le proprie proposte di soluzione ai bisogni della gente se non addirittura ignorando o negando questi bisogni, come spesso è avvenuto. Al messaggio trumpiano “Costruiamo un muro con il Messico”, che veniva incontro in modo primordiale alle insicurezze e paure della gente rispetto all’immigrazione, Hillary Clinton, nella sua campagna presidenziale del 2016, ha risposto criticando quelle stesse persone proprio per quelle insicurezze, fino a definirle “un cumulo di miserabili”.[13] In Italia, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del marzo 2018, il Partito Democratico ha proposto un programma articolato in 100 punti. Ma che cosa rimaneva alla gente di una proposta politica articolata in 100 punti? Quale visione del mondo sottintendevano questi 100 punti? Quanto facevano sognare e sperare in un mondo migliore?
La visione del mondo proposta dall’area liberal-democratica e progressista è stata carente di spessore narrativo, fatto di storie, aneddoti, metafore, messaggi chiari, semplici e ripetuti, che offrissero alla gente una lettura delle proprie insicurezze economiche reali o percepite, e delle conseguenti riforme necessarie. Decenni di studi e ricerche offrono una lunga lista di soluzioni tecniche, supportate da evidenza empirica, per favorire lo sviluppo economico, combattere la povertà, lottare contro le diseguaglianze, e sostenere le pari opportunità. Ciò nonostante, questo mix di risposte ai bisogni di determinati gruppi sociali, affiorati in particolare durante il rapidizzarsi della globalizzazione, acquista valore solo quando viene costantemente adattato al contesto storico e geografico, e proposto attraverso una narrativa politica che lo metta in relazione ai bisogni, le aspirazioni e le emozioni della gente.
I democratici americani e quelli italiani hanno lasciato l’iniziativa di una nuova narrativa politica, necessaria in un mondo globalizzato, agli avversari, limitandosi a negarne la solidità empirica e implicitamente avvalorandone il costrutto logico-deduttivo. La neurolinguistica ci spiega che opporsi al messaggio dell’avversario politico ne valida la costruzione logica iniziale e, come conseguenza, finisce per rafforzarlo.[14] Per esempio, nel 2015 il M5S ha creato una narrativa politica negativa sul presunto conflitto di interessi del ministro per i Rapporti con il Parlamento Boschi nell’ambito della pubblicazione del “Decreto Salva Banche”.[15] L’obbiettivo era di creare una narrativa secondo la quale il Governo Renzi era amico di banchieri, ne supportava gli interessi e ne nascondeva le malefatte, con la complicità di un proprio Ministro. Sia Renzi che Boschi hanno risposto a questi attacchi negandoli, senza preoccuparsi di smontare nella sostanza quella narrativa per proporne un’altra. Allo stesso modo, i repubblicani americani erano riusciti a infangare il nome di John Kerry, candidato nel 2004 alla presidenza degli Stati Uniti, attraverso l’appoggio indiretto a un gruppo di veterani della guerra del Vietnam, Swift Boat Veterans for Truth, che aveva trasformato efficacemente la percezione di cui godeva Kerry come veterano decorato in quella di un quasi disertore senza coraggio. Donald Trump conosce istintivamente queste dinamiche narrative, dichiarando spesso che “any news is good news”.
Le forze liberal-democratiche e progressiste devono elaborare una nuova narrativa politica che metta esplicitamente in relazione soluzioni tecniche, riforme, politiche pubbliche radicali, efficaci e pragmatiche, basate su evidenza empirica, con i bisogni e le emozioni di persone che vivono in un mondo globalizzato. Mentre Tony Blair e Bill Clinton hanno saputo raccontare un’entusiasmante visione del mondo ai vincitori della globalizzazione, una nuova narrativa politica, che chiameremo Quarta Via, deve narrare una visione del mondo altrettanto entusiasmante dove ci sia spazio sia per i vincitori che per i vinti, alternativa a quella dei populisti ma altrettanto agguerrita, e che utilizzi un proprio linguaggio.
La Quarta Via si collega ai valori universali di compassione, fratellanza, libertà, e uguaglianza, come sono stati declinati tradizionalmente dall’area liberal-democratica e progressista a partire dalla Rivoluzione francese. La Quarta Via si fonda su una esplicita ispirazione morale liberale, sul conseguente stato di diritto (rule of law) e bisogno di sicurezza (public order) e per definizione prende posizione sul tipo di soluzioni tecniche che affrontano e risolvono le necessità della gente. Allo stesso tempo, si interroga costantemente sull’evoluzione del concetto di giusto e sbagliato, sull’adeguatezza del contratto sociale esistente e pragmaticamente offre soluzioni tecniche che migliorano la vita dei cittadini. Elemento chiave di questa narrativa è la riduzione di problemi complessi in termini semplici, spesso attraverso una storia o l’uso di metafore che uniscono i fatti e li intrecciano trascendendo le riforme tecniche offerte in partenza, offrendo ai cittadini un contesto dove possano elaborare autonomamente un significato per le proprie azioni e uno scopo per la loro vita.[16] Questo significato aiuta la gente a formare il proprio senso d’identità e appartenenza, e di conseguenza ad interpretare la vita di tutti i giorni.[17]
Per avere successo, la Quarta Via deve vincere i cuori e le menti della gente offrendo speranza in un mondo migliore di quello odierno. Un sentimento di speranza che, quando efficacemente articolato, ha buone probabilità di prevalere sui sentimenti di paura e rabbia sui quali si basa la narrativa politica populista. La Quarta Via non è una nuova forma di comunicazione, in quanto si preoccupa di creare una storia potente ed efficace che cattura l’immaginario collettivo della gente, e non si limita alla ricerca di un modo di comunicare questa storia visivamente e testualmente per attrarre quante più persone possibile. La narrativa, o story-making, interpreta la realtà attuale, offrendo uno o più contesti di interpretazione e propone una visione futura del mondo. La comunicazione, o story-telling, racconta questa realtà attraverso un video o un post, un documentario o un editoriale, un discorso o una chat.
La notte del 4 novembre 2008 le strade di Washington, DC, erano completamente inondate di gente che celebrava l’improbabile vittoria di Barack Hussein Obama alla presidenza degli Stati Uniti. Quando ancora i movimenti populisti stavano crescendo nei consensi ma, almeno nei paesi occidentali, non avevano ancora raggiunto le leve del potere, Obama vinceva le elezioni con una narrativa politica che entusiasmava il popolo americano come non succedeva dai tempi della vittoria elettorale di John F. Kennedy del 1960. Obama si proponeva come l’incarnazione di una società americana post-razziale e post-ideologica, dove le divisioni dettate dal colore della pelle e dalle ideologie di destra o di sinistra non offrivano più le adeguate chiavi di lettura del presente. La sua narrativa politica includeva la riforma del sistema sanitario e quella del sistema finanziario, collegandola ai valori di solidarietà, equità, uguaglianza e libertà, e articolava in modo costante e ripetitivo questi valori adducendo la propria storia personale ad esempio tanto improbabile quanto straordinario: il cambiamento, nell’America del 2008, era possibile, e un uomo nero che fino a meno di centocinquant’anni prima avrebbe potuto essere legalmente schiavizzato, adesso poteva diventare presidente di quello stesso paese. Un mondo migliore era possibile.
Nel 2012, un politico canadese inesperto ma in ascesa, Justin Trudeau, reinterpretava le necessità del popolo canadese elaborando una narrativa politica che offriva soluzioni tecniche imperniate sui valori di tolleranza e apertura. Figlio a sua volta di un Primo Ministro, quel Pierre Trudeau che negli anni Sessanta aveva lottato per tenere il Canada unito quando le forze politiche secessioniste del suo Québec ne minacciavano la disintegrazione, Justin Trudeau va alla ricerca dei valori fondamentali che tengono unito il Canada. Nel suo manifesto politico Common Ground elabora le fondamenta della sua narrativa politica progressista, poi lanciata durante la campagna elettorale vinta nel 2015. Questa narrativa collega quei valori di tolleranza e apertura, a suo dire intrinsecamente canadesi, con politiche pubbliche progressiste tra le quali l’apertura del Canada ai rifugiati e agli immigrati, ingenti aiuti economici a famiglie e studenti, il matrimonio gay, e la liberalizzazione della marijuana.[18] Trudeau elabora una narrativa politica basata sul senso di un destino comune di cui i canadesi contemporanei hanno bisogno data la loro natura di popolo per la stragrande maggioranza composto da immigrati.
Emmanuel Macron rilancia l’idea, nell’agosto 2016, dell’Europa come unico contesto immaginabile entro il quale la Francia possa risolvere i propri problemi e soddisfare i propri bisogni. Non solo vince le elezioni presidenziali dell’anno successivo con oltre il 66% dei voti, a 39 anni e senza il supporto di un partito tradizionale, ma guadagna anche la maggioranza assoluta dei seggi nelle successive elezioni parlamentari con il movimento politico da lui fondato solo un anno prima, la Republique en Marche. Questo successo si basa su una narrativa politica visionaria, imperniata su una Francia che ha tutto da guadagnare dall’apertura al mondo esterno, dove l’Europa è vista come pilastro insostituibile per il progetto francese di un mondo più giusto, sicuro e pacifico. Le politiche pubbliche concrete che propone si ricollegano a questa visione del mondo e vengono pragmaticamente rilette e inquadrate in questo contesto, senza paure dettate dalle gabbie ideologiche che soffocano i partiti tradizionali. Macron risponde alle domande di appartenenza (da dove veniamo?) e destino (dove andiamo?) che i francesi, come tutti i popoli della terra, condividono, e si prende il rischio di interpretarle con successo in chiave europea, in un contesto politico dove la destra populista del Front National aveva invece proposto una visione identitaria e di chiusura.
In un recente saggio sul liberalismo, l’Economist afferma che “il contratto sociale e le norme geopolitiche alla base delle democrazie liberali, e l’ordine mondiale che le tiene in piedi, non sono state pensate per questo secolo”.[19] La Quarta Via allo sviluppo umano, sociale ed economico offre una visione del mondo contemporaneo che include soluzioni tecniche dettagliate che variano da paese a paese, ma che presentano alcuni tratti comuni. Primo, le riforme proposte si basano su evidenza empirica e, qualora questa non esista, includono una misurazione della propria efficacia mentre le riforme sono in corso d’opera. Secondo, queste riforme si preoccupano in primis di dare una risposta agli effetti negativi della globalizzazione di merci, servizi, capitali e persone, con particolare attenzione ai gruppi sociali più disagiati. Terzo, le riforme si collegano efficacemente ai bisogni e alle emozioni della gente. Questa nuova narrativa politica elabora una visione ispirata a valori liberal-democratici e progressisti, riaffermando la speranza di un mondo dove i figli potranno nuovamente vivere in un mondo migliore di quello in cui vivevano i loro genitori.
________________________________________________________________________________
[1] UNU-WIDER, “World Income Inequality Database (WIID3.4)”, Gennaio 2017.
[2] Dettling, Lisa J., Joanne W. Hsu, and Elizabeth Llanes, “A Wealthless Recovery? Asset Ownership and the Uneven Recovery from the Great Recession ”, FEDS Notes. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, Settembre 2018.
[3] http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=1038
[4] https://www.theguardian.com/uk/2005/sep/27/labourconference.speeches
[5] William Davies, “How feelings took over the world”, The Guardian, Settembre 2018.
[6] “Estimated Impact of the American Recovery and Reinvestment Act on Employment and Economic Output from October 2011 Through December 2011”, Congressional Budget Office, Febbraio 2012.
[7] Dani Rodrik, “Populism and the economics of globalization,” Journal of International Business Policy, 2018, p. 13.
[8] “Statistical Portrait of the Foreign-born Population in the Unites States, 1960-2016”, Pew Research Center.
[9] Joseph Francois and Laura M. Baughman, “Does Import Protection Save Jobs? The Estimated Impacts of Proposed Tariffs on Imports of U.S. Steel and Aluminum”, Policy Brief, Trade Partnership, Marzo 2018.
[10] Demos&Pi e Demetra, “Atlante Politico”, commissionato da La Repubblica, 2 Novembre 2018. Campione: 1.001, livello di rappresentatività: 95%, margine di errore: +/- 3.1%.
[11] XXVII Rapporto Immigrazione, Caritas e Migrantes (RICM) 2017-2018, “Un Nuovo Linguaggio per le Migrazioni”, Settembre 2018. Cfr. anche Paolo Segatti e Federico Vegetti, “Rapporto sull’accoglienza degli italiani. Fattore sfiducia”, Il Regno – attualità̀, Nr. 18/2018, pag. 557-571.
[12] Massimo Baldini, “Perché aumenta la disuguaglianza in Italia”, Lavoce.info, 27 Aprile 2018.
[13] https://www.youtube.com/watch?v=PCHJVE9trSM
[14] George Lakoff, “Don’t Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame the Debate”, Chelsea Green Publishing, Settembre 2004.
[15] Decreto Legge 183/2015 recante Disposizioni urgenti per il settore creditizio, approvato il 22 Novembre 2015 dal Consiglio dei Ministri del Governo Italiano.
[16] Jeong-Hee Kim, “Understanding Narrative Inquiry”, SAGE Publications, Marzo 2015, p. 190.
[17] Kalypso Nicolaïdis, “Brexit as myth: Exodus, Reckoning, or Sacrifice?”, Standpoint, Luglio/Agosto 2017.
[18] Justin Trudeau, “Common Ground”, HarperCollins, Agosto 2015.
[19] “Reinventing liberalism for the 21st century”, The Economist, Settembre 2018.