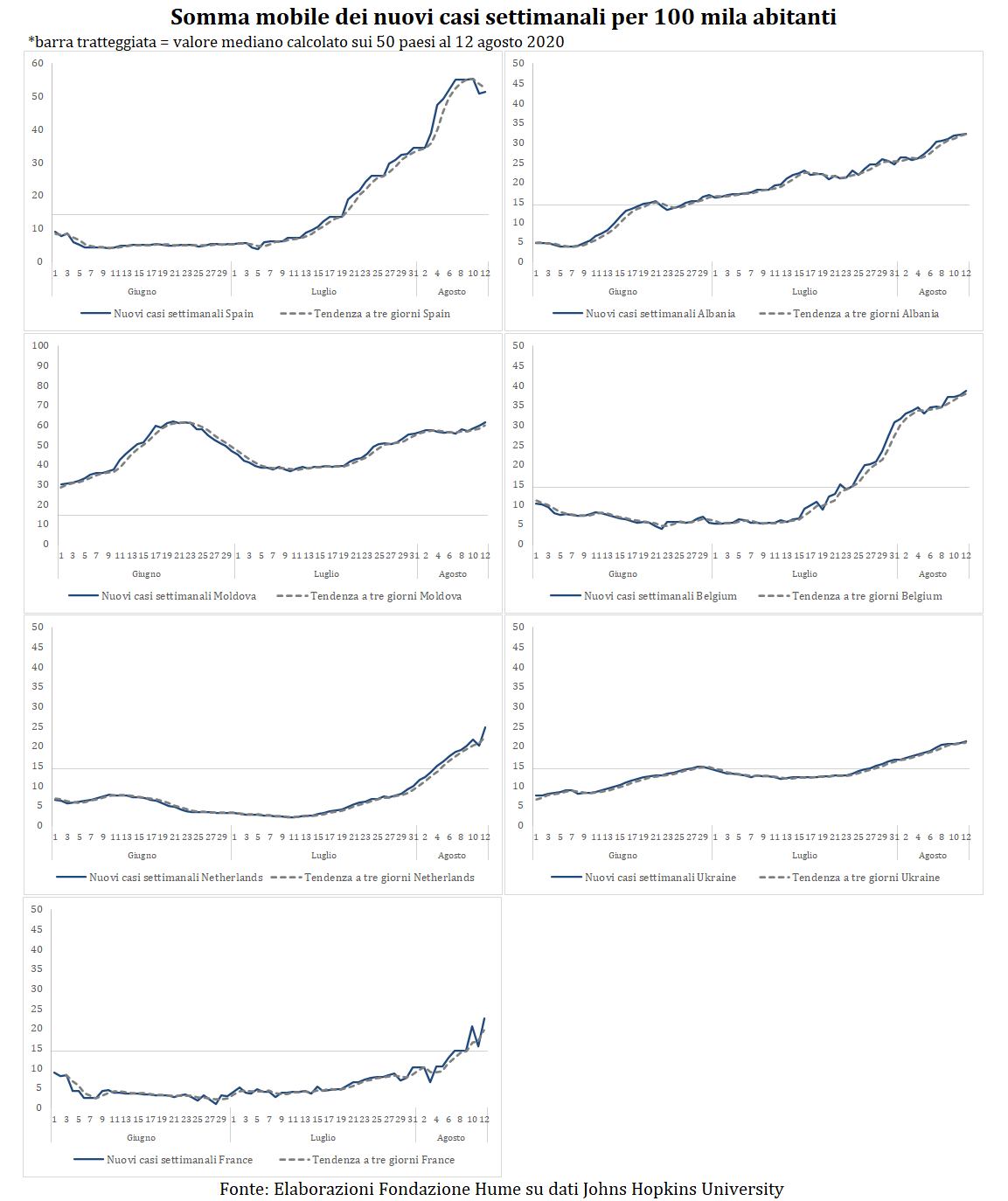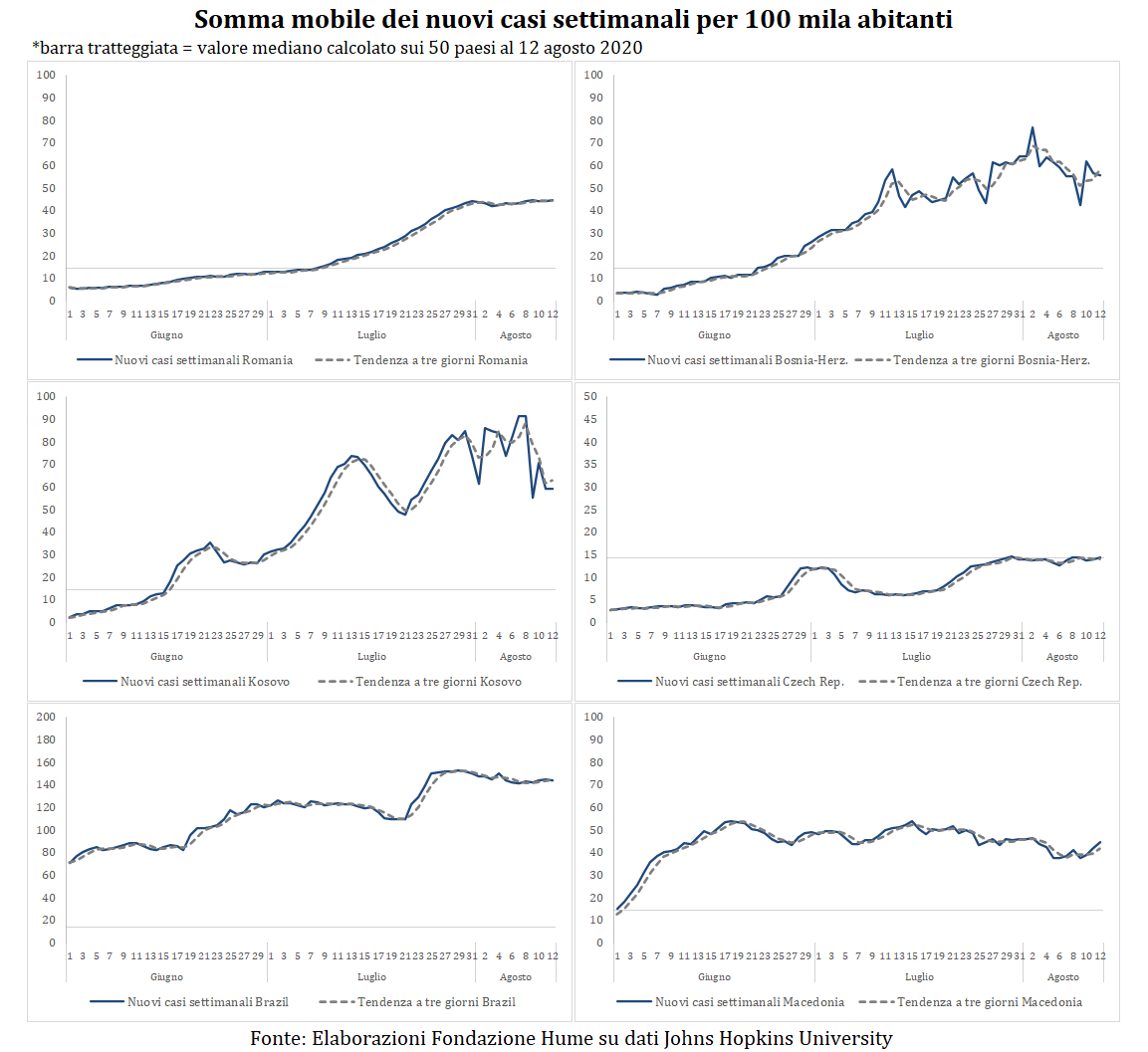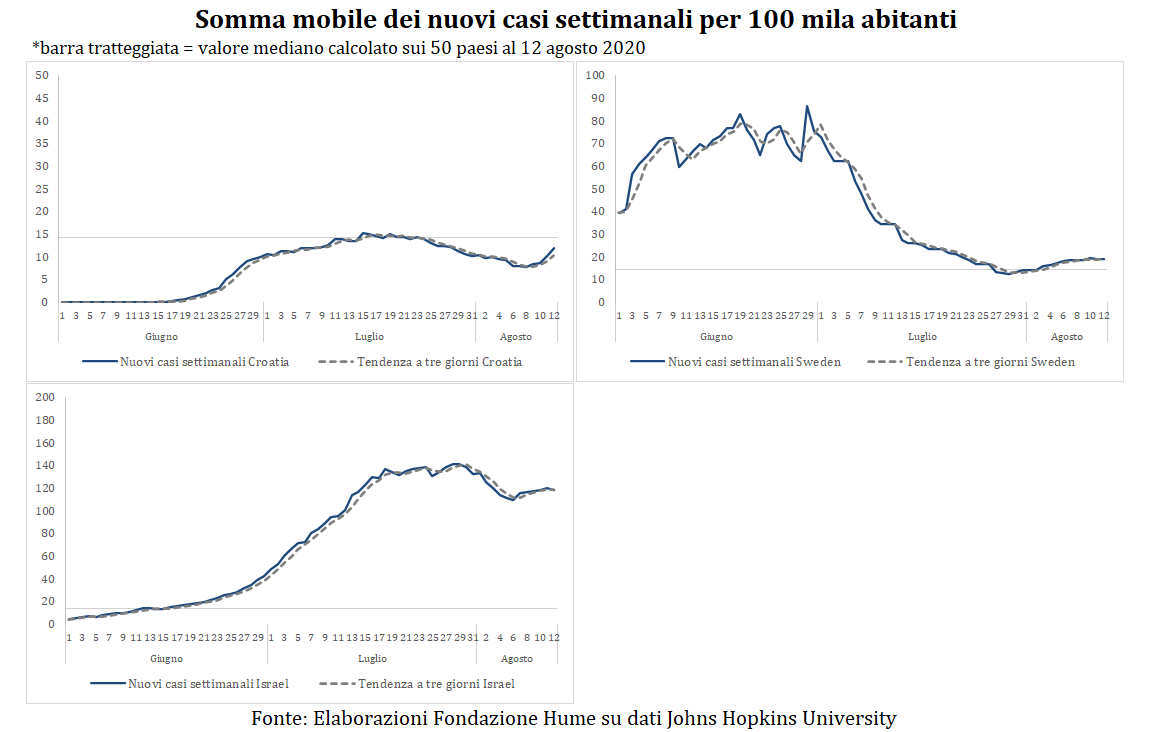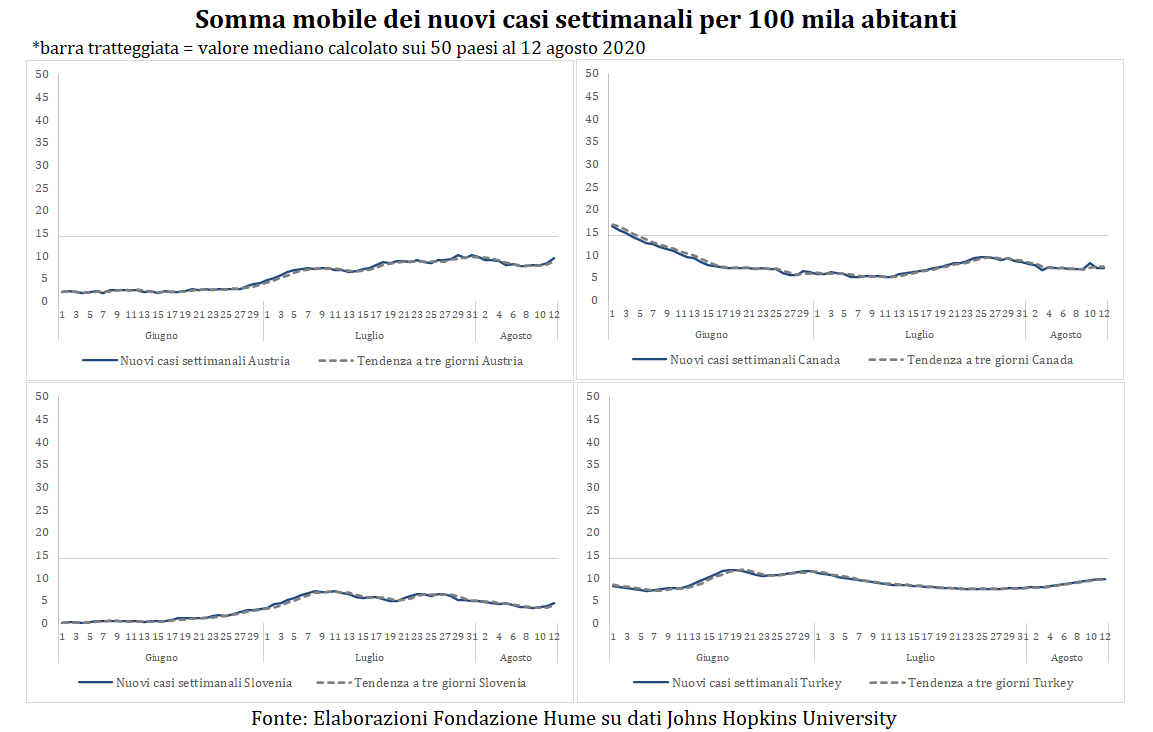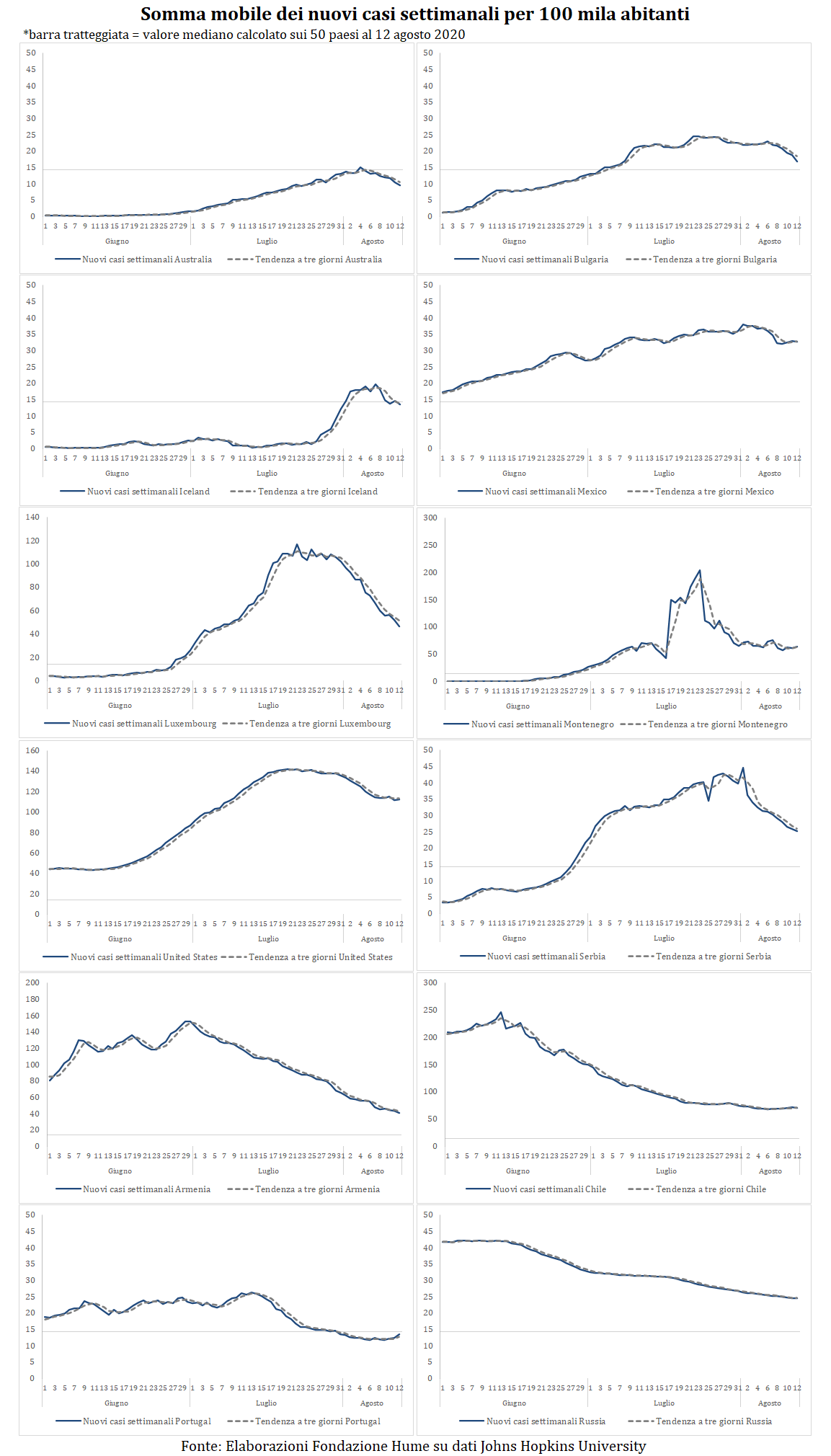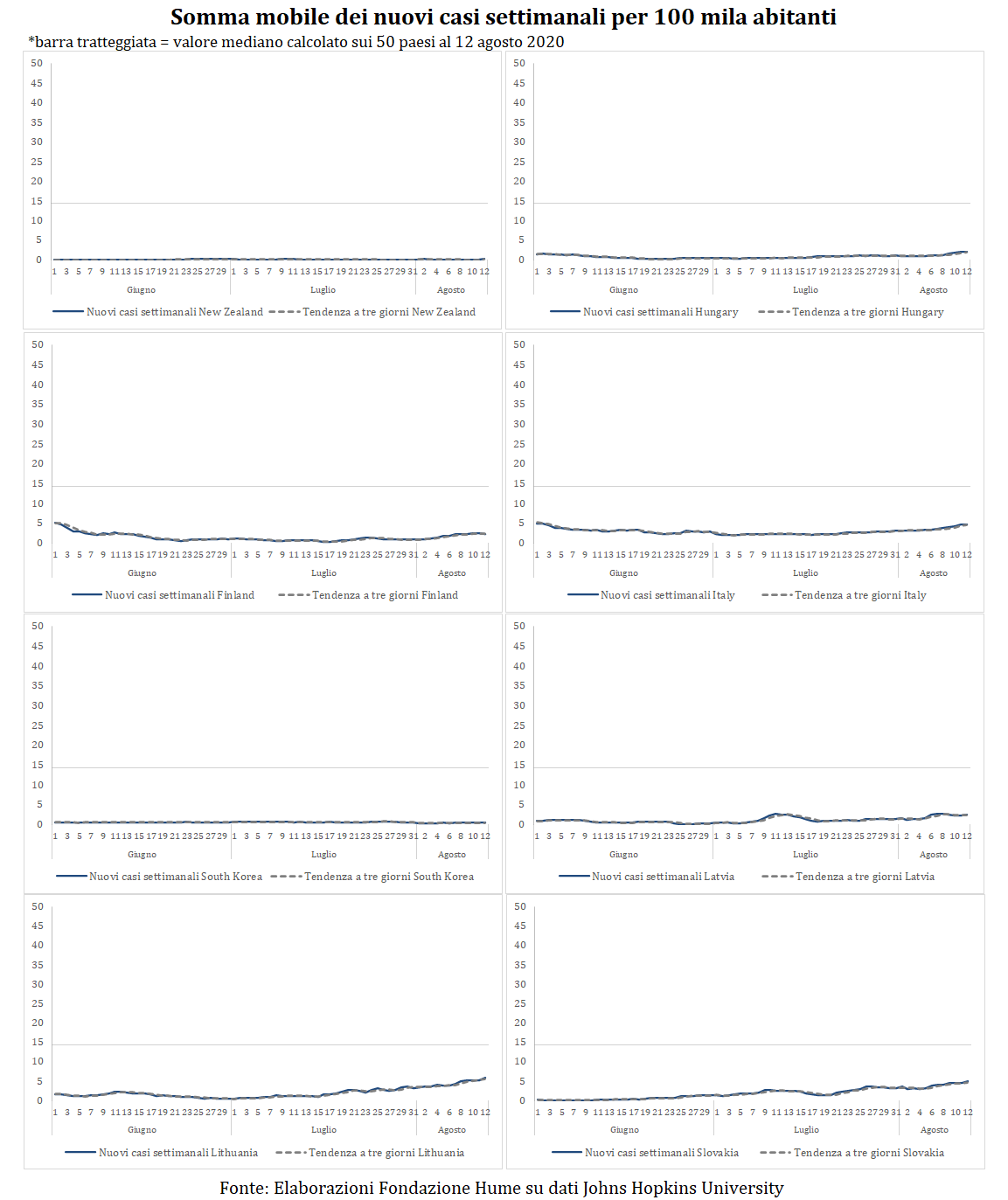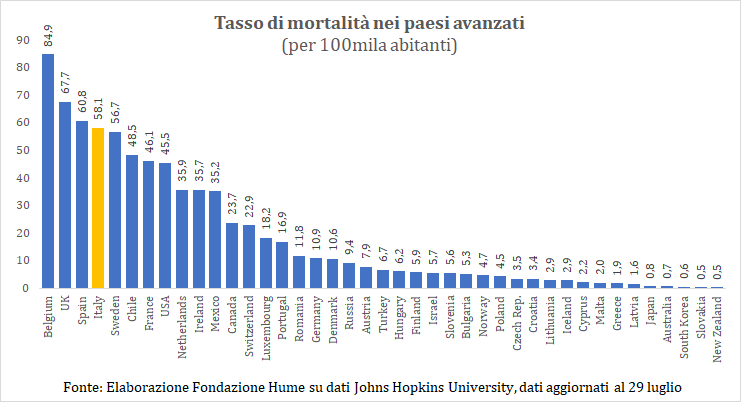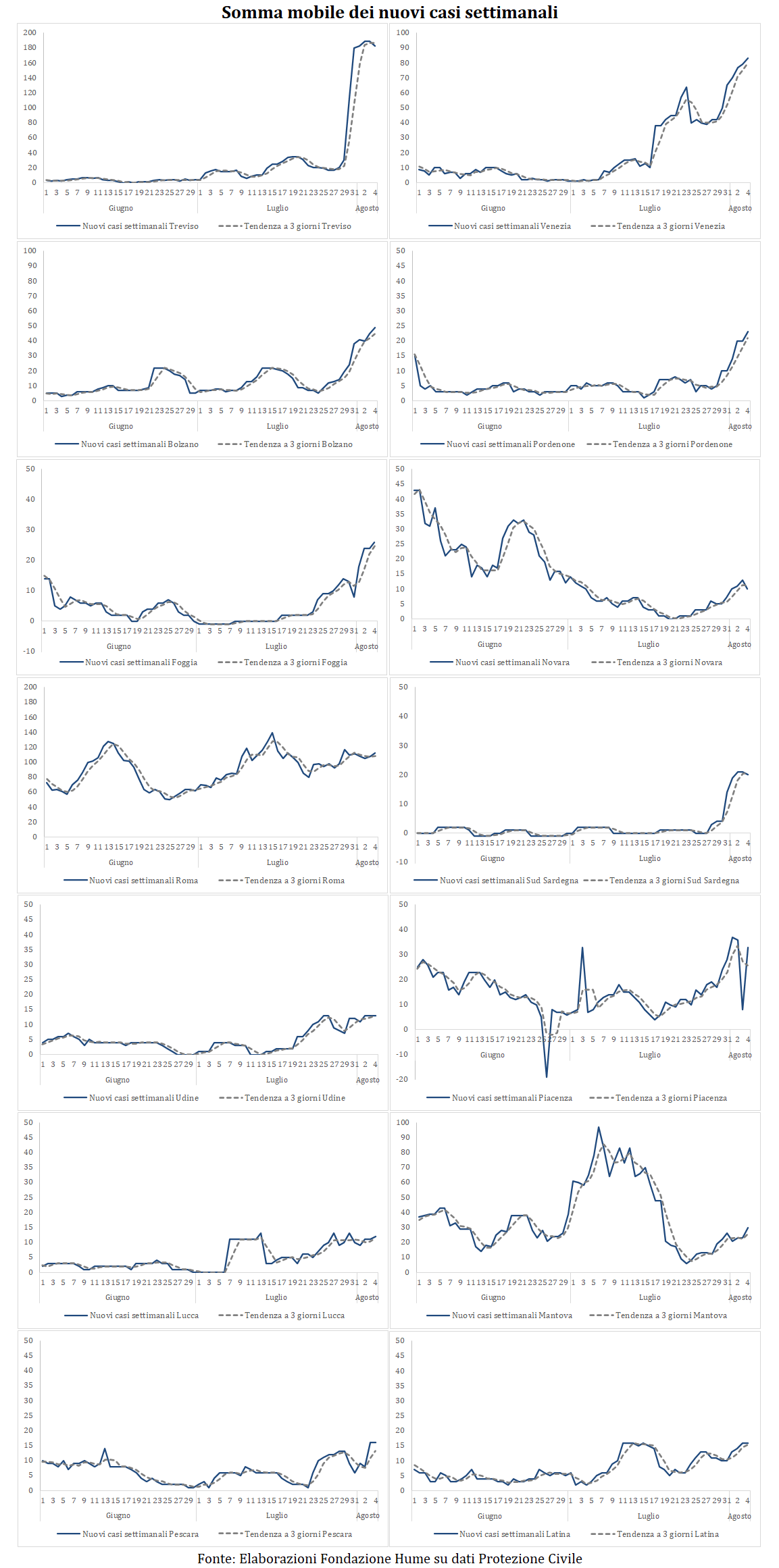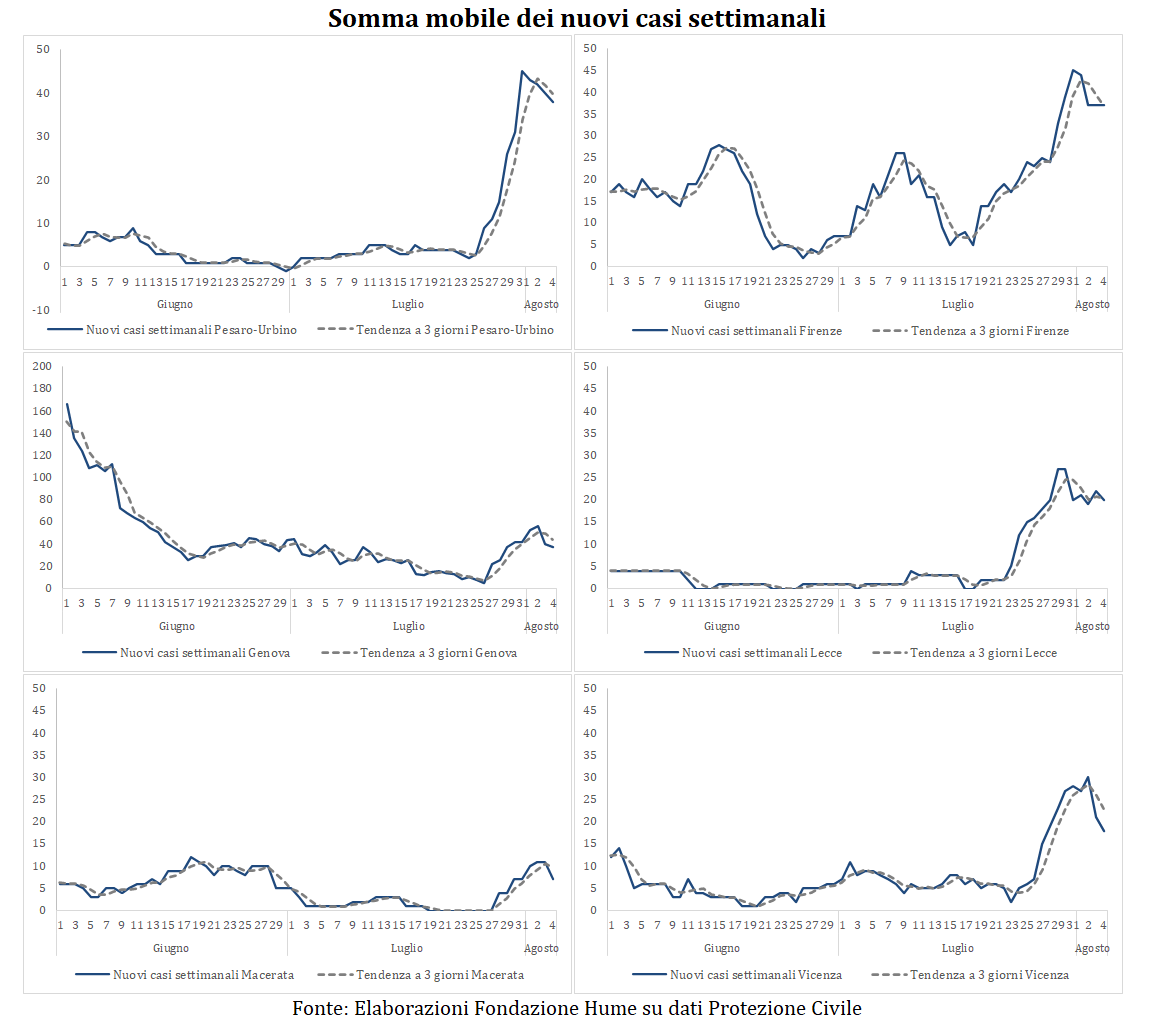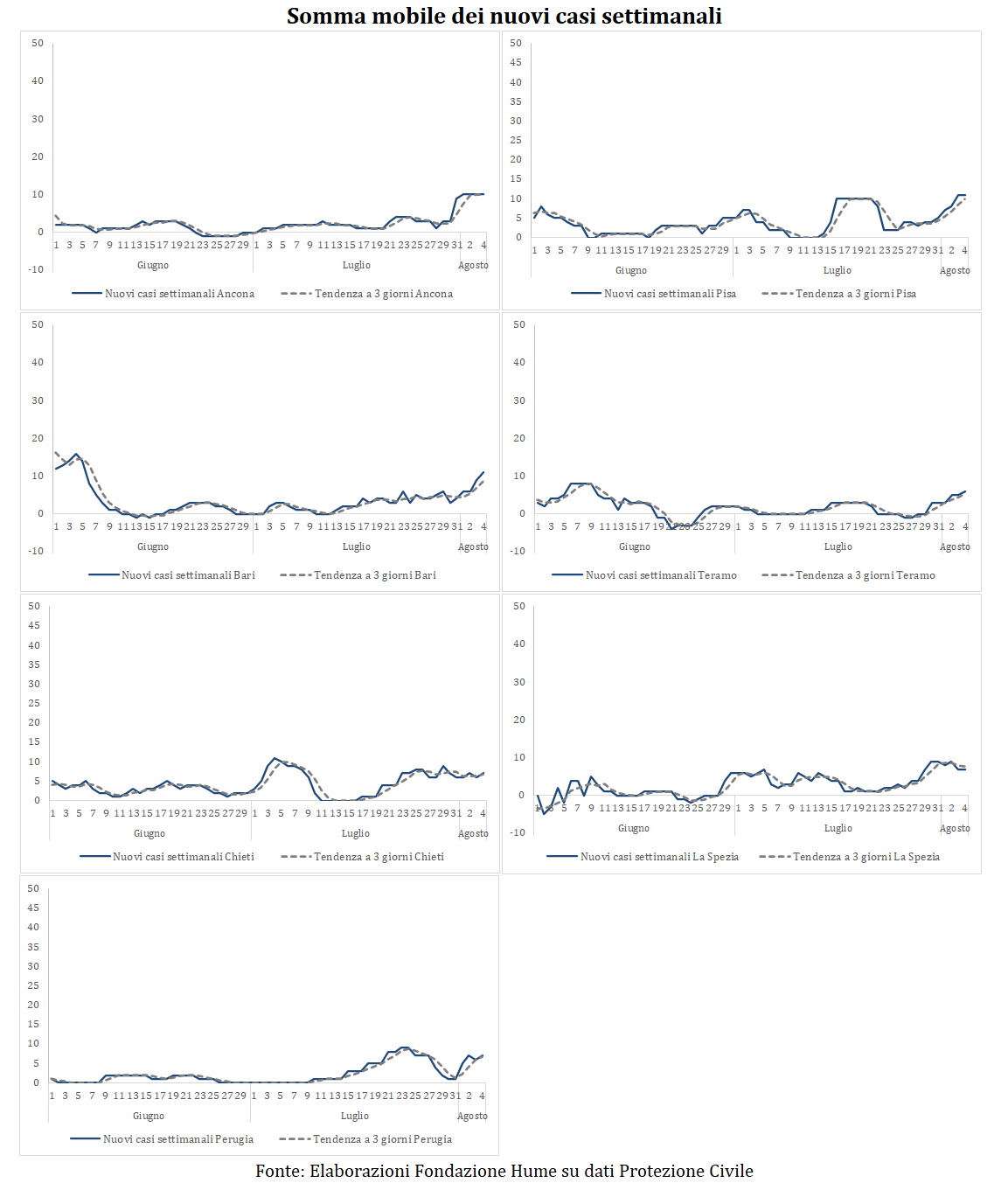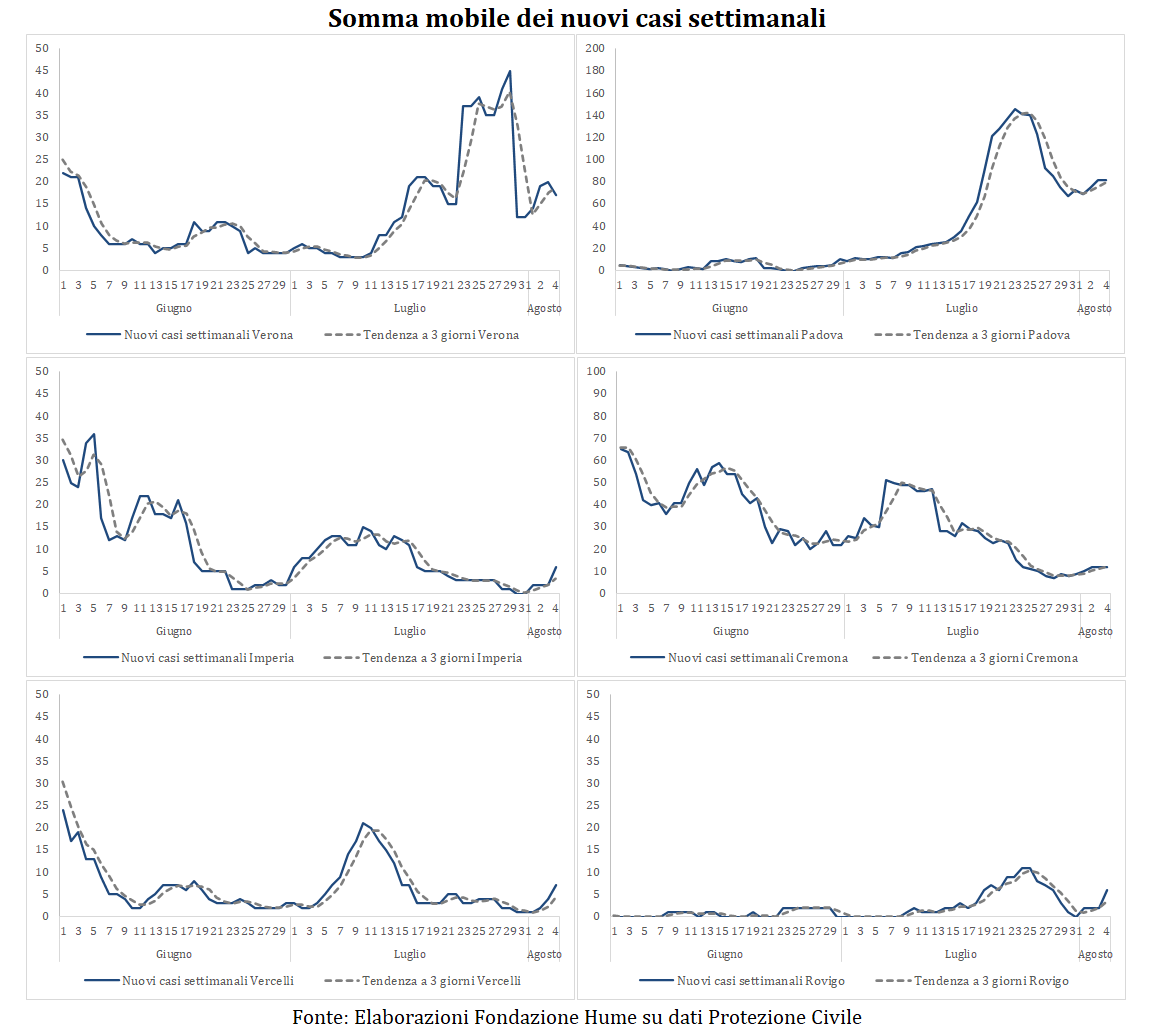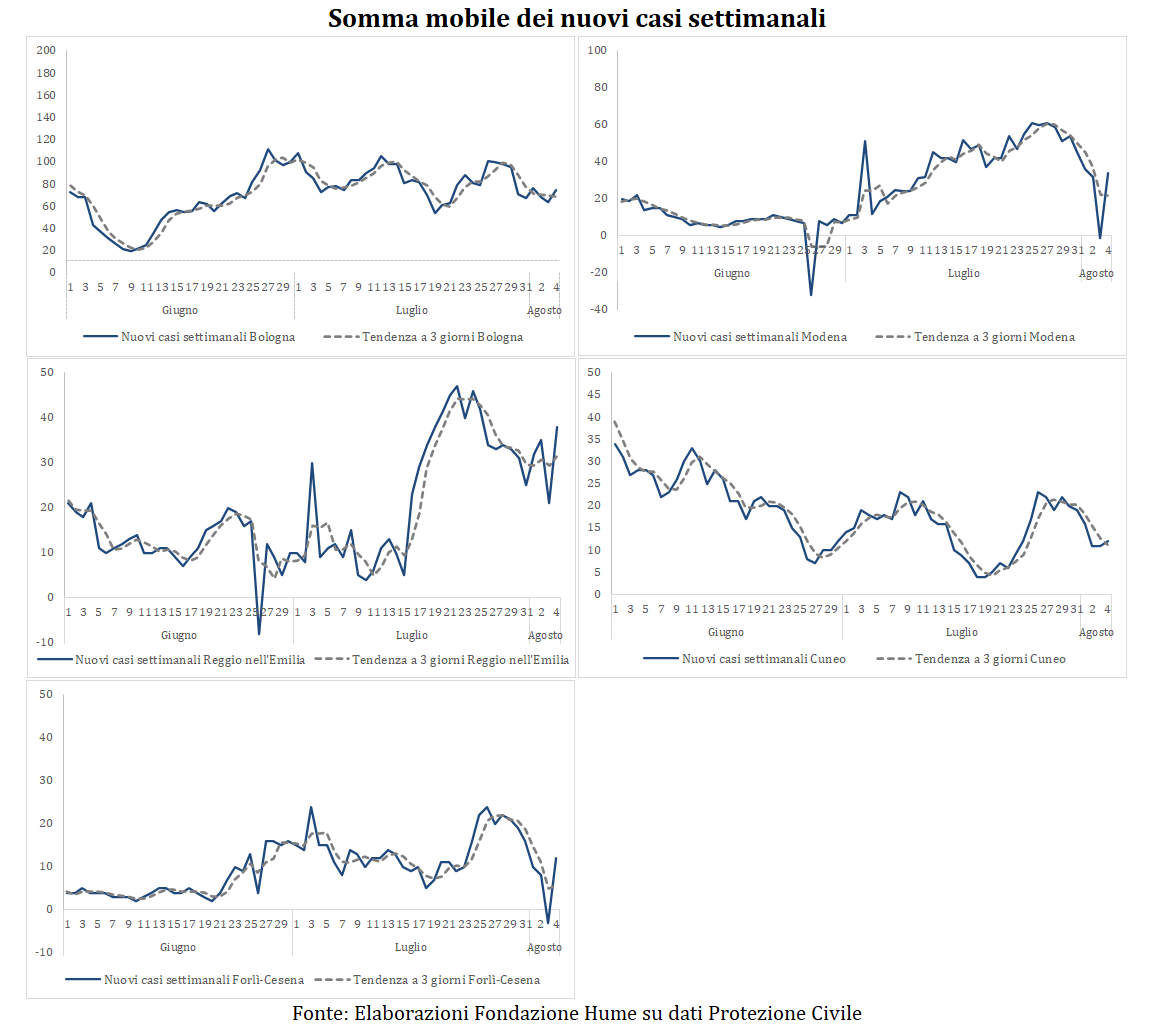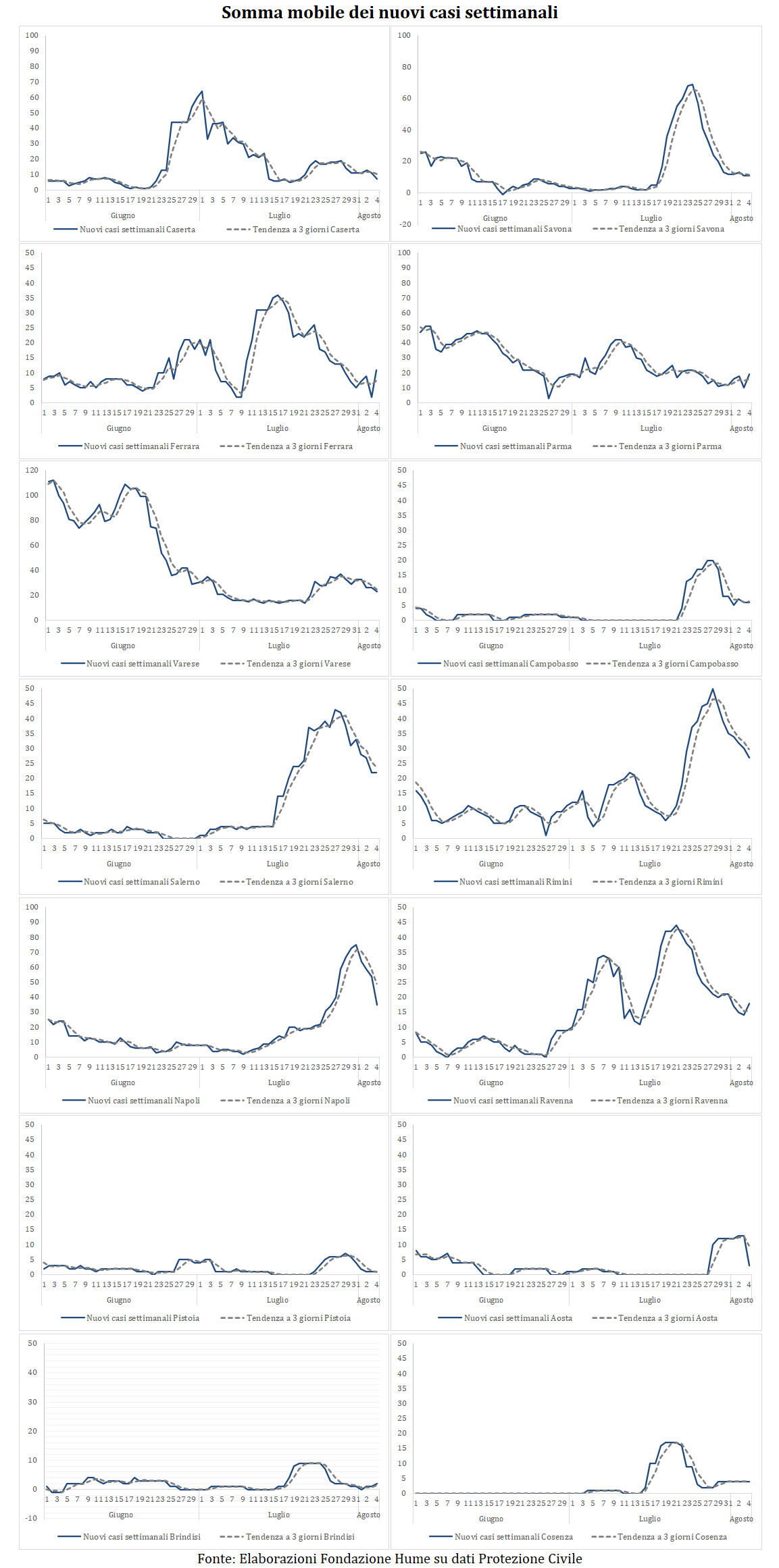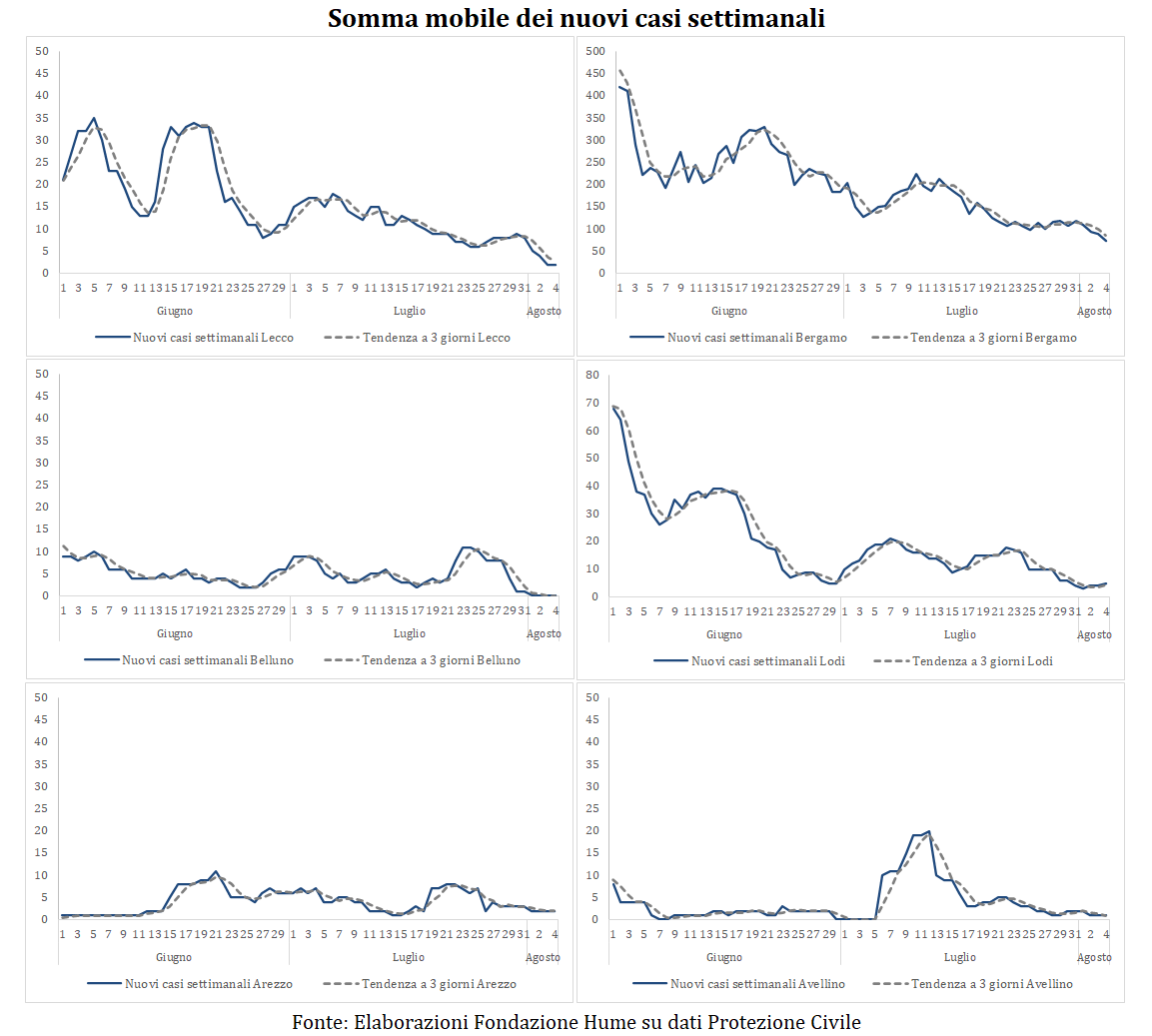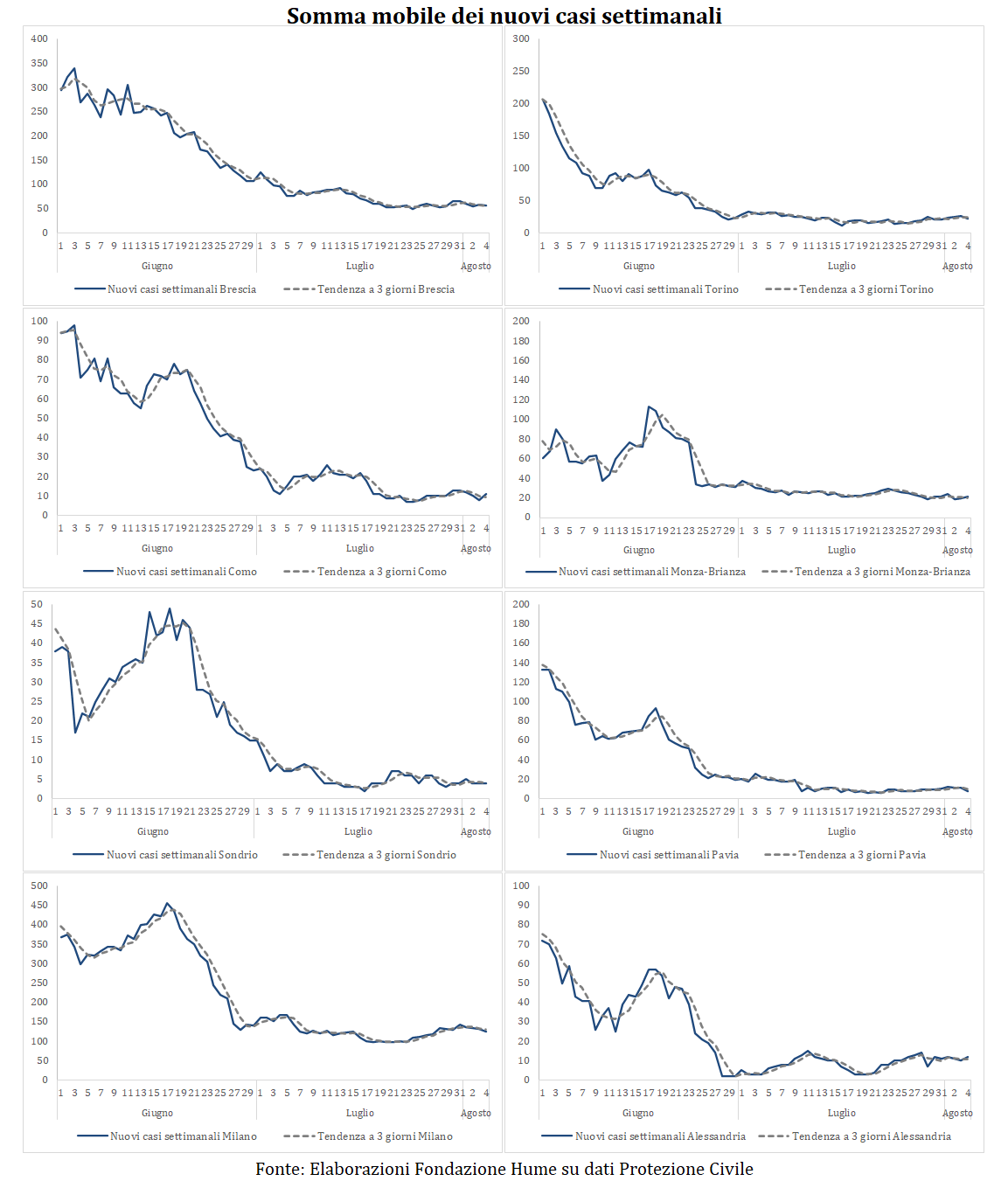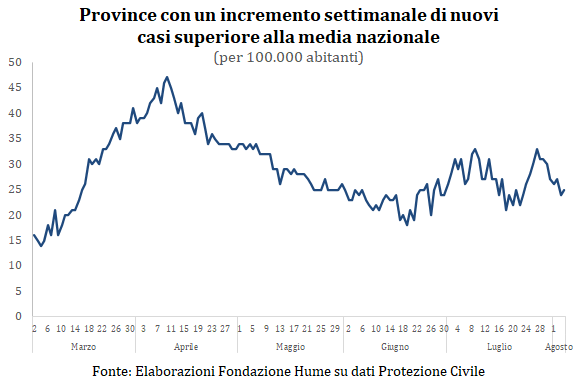1. In un mio precedente contributo pubblicato online sempre sul sito della fondazione Hume avevo trattato per sommi capi il tema dei rapporti gerarchici tra le fonti di diritto UE e le Carte Costituzionali degli Stati Membri, in particolare tedesca e italiana, giungendo a tre conclusioni.
La prima, lapalissiana ma troppo spesso ignorata, è che il diritto di fonte unionista ancora oggi è vigente ed efficace (e dunque esiste) esclusivamente sulla base dei trattati fondativi dell’Unione e, dunque, per effetto del diritto nazionale e della volontà degli stati membri dell’UE, di guisa che – al di là delle dichiarazioni della Corte di Giustizia e degli altri organi UE sull’autonomia e prevalenza del diritto unionista – il diritto in questione – come ha dimostrato la Brexit – vige solo nei limiti in cui (e sino a quando) gli Stati Membri si ritengono vincolati (o, quanto meno, acconsentono) alla sua applicazione nei loro territori. Limiti che – naturalmente – vengono definiti dalle rispettive carte fondamentali nazionali.
La seconda è che è possibile identificare due tendenze di fondo nei rapporti gerarchici tra diritto unionista e ordinamenti costituzionali nazionali: una che abbiamo definito sovranista (adottata ad esempio in Germania) secondo cui il diritto UE non deve porsi in contrasto con i principi fondamentali della costituzione nazionale (secondo il criterio della identity review), dunque facendo prevalere in ogni caso l’identità (giuridica) nazionale rispetto ad eventuali difformi principi di diritto dell’unione. L’altra, più universalista (e seguita nella maggior parte delle decisioni dalla Corte Costituzionale italiana), secondo cui il diritto UE dovrebbe invece cedere il passo alla costituzione nazionale solo nella misura in cui le norme di quest’ultima esprimono principi riconosciuti anche universalmente, ad esempio perché codificati nelle convenzioni multilaterali sui diritti umani.
La terza conclusione è che il diverso atteggiamento delle corti costituzionali nazionali in tema di rapporti tra costituzione e diritto unionista (ossia il fatto che adottino un’impostazione sovranista o universalista nel decidere dei rapporti tra costituzione e diritto di fonte UE) si riflette in una maggiore o minore forza negoziale dei rispettivi stati quando si tratta di decidere – in sede unionista – norme, regole e interventi di sostegno all’economia.
In questo secondo scritto – che rappresenta la continuazione ideale del primo – mi propongo di approfondire il tema con specifico riferimento al rapporto tra i principi della Carta Costituzionale italiana che definiscono la costituzione economica del nostro paese e le fonti di diritto unionista che disciplinano l’adesione del nostro paese al sistema della moneta unica europea.
2. Per trattare correttamente della questione occorre ricordare anzitutto che la vigenza del diritto UE in Italia (e, di conseguenza, i suoi rapporti gerarchici col diritto costituzionale nazionale) è disciplinata dall’art. 11 Cost., a norma del quale l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Vi è poi l’art. 117 Cost., secondo cui la potestà legislativa degli organi (centrali e regionali) nazionali deve svolgersi nel rispetto non solo della costituzione ma anche dei vincoli comunitari. Le due norme hanno peraltro scopo e oggetto differente. Laddove l’art. 117 ha infatti la funzione di vincolare il legislatore nazionale, nei settori di competenza concorrente, al rispetto del diritto UE, l’art. 11 Cost. indica invece i limiti in cui l’ordinamento italiano consente la vigenza sul nostro territorio delle norme di fonte unionista. Proprio l’applicabilità dell’art. 11 Cost alle fonti primarie del diritto UE consente infatti al diritto unionista di godere di uno status privilegiato rispetto ad altre norme di fonte internazionale pattizia: nelle materie che – secondo i trattati unionisti – rientrano nella competenza dell’UE la sovranità dello stato italiano “si ritira”, per lasciare spazio, appunto, al legislatore unionista. In questo spazio giuridico la norma unionista si viene dunque a inserire, risultando direttamente vincolante in Italia come le norme nazionali, ma senza mai divenire a sua volta una vera e propria norma interna (come avviene invece per altre norme di fonte internazionale, secondo la dottrina della cosiddetta “recezione”).
La conseguenza più rilevante di questa particolare ricostruzione dei rapporti tra diritto UE e diritto nazionale è che – secondo la nostra Corte Costituzionale – il diritto di fonte unionista non è soggetto al medesimo sindacato di legittimità che vale per le leggi nazionali (e – di conseguenza – anche per le norme dei trattati che si considerano “recepite” nel nostro ordinamento interno), bensì a un controllo più limitato che si riduce (secondo una dottrina definita dei “contro limiti”) alla sua compatibilità con i “principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale” (così la sentenza n. 183/1973 e – più recentemente – l’ordinanza 454/2006). Principi che sono stati per lo più identificati dalla Corte nei diritti tutelati nella prima parte della Costituzione che – al contempo – siano anche riconosciuti nelle maggiori convenzioni multilaterali sui diritti umani. Vediamo tuttavia di passare in rassegna le decisioni più importanti della Corte sul tema, per capire meglio quale genere di “diritti” la Consulta ha in passato considerato tanto importanti da rilevare – ai sensi dell’art. 11 Cost. – come “contro limite” per la vigenza del diritto unionista.
La sentenza 399/1987 è quella in cui la Corte ha ammesso che il diritto unionista possa derogare anche a norme costituzionali, a patto che non violi i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana. In quella decisione è stato dunque enunciato il principio cardine del sistema dei “contro limiti”, secondo cui – come si diceva poc’anzi – non ogni precetto contenuto nella nostra costituzione limita il diritto unionista, ma solo alcuni, ossia quelli fondamentali, in quanto posti a tutela di diritti inalienabili della persona universalmente riconosciuti. Seguendo la medesima linea interpretativa, nella successiva sentenza n. 132/1990 la Consulta ha ribadito che “[…] per giurisprudenza consolidata di questa Corte (si vedano, in particolare, le sentenze n. 183/73 e n. 170/84), il settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno è sottratto alla competenza della Corte Costituzionale, con le eccezioni rappresentate dalla sindacabilità della legge di esecuzione del Trattato di Roma in riferimento ai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana”. In questo precedente la Corte ha sostenuto che il sindacato di legittimità costituzionale (a presidio dei diritti fondamentali) deve ritenersi eccezionale quando viene esercitato nei confronti del diritto UE e – di conseguenza – che l’individuazione dei principi “fondamentali” che valgono come possibili “contro limiti” alla vigenza del diritto unionista dovrebbe essere ispirata a criteri restrittivi, che si traducono in un favor per il legislatore unionista.
Va però segnalata la sentenza 232/1989, in cui la Corte ha manifestato un’opinione in controtendenza rispetto alle decisioni citate in precedenza, affermando che – per quanto improbabile – non è impossibile che alcune norme dei trattati dell’Unione possano ispirarsi a principi giudici che non risultano in accordo con quelli fondamentali della nostra costituzione nazionale. Questo perché, come osserva la Corte in motivazione, non tutti i principi fondamentali che ispirano la nostra Costituzione si ritrovano anche nelle carte fondamentali degli altri stati aderenti all’UE, con la conseguenza che è ben possibile che l’UE adotti uno standard di tutela di certi diritti e valori che si pone a livello inferiore rispetto a quello considerato inderogabile dal nostro ordinamento costituzionale. Questa sentenza della Corte è interessante (e importante ai fini delle tesi che si sosterranno in questo lavoro) in quanto ammette che anche nel nostro ordinamento costituzionale possa trovare applicazione una versione “tedesca” (vale a dire fondata sul criterio della “identy review”) della dottrina dei “contro limiti”, in forza della quale dunque il diritto UE non potrebbe porsi in contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti che contribuiscono a definire la specifica identità costituzionale nazionale, anche se si tratta di diritti che non si ritrovano tutelati in egual misura in altre costituzioni nazionali di stati dell’UE o nelle grandi convenzioni internazionali sui diritti umani.
Si noti a tale riguardo che – sempre nel caso oggetto della decisione 232/1989 – uno di questi principi è stato individuato dalla Corte nel diritto di difesa in giudizio sancito dall’art. 24 Cost., che è stato ritenuto (in astratto, giacché poi la norma in concreto impugnata è stata ritenuta rispettosa di quel diritto) il possibile fondamento di una declaratoria di illegittimità costituzionale della legge di esecuzione del trattato di Roma – vigente all’epoca – che aveva legittimato l’adozione da parte degli organi comunitari di norme che potevano dar luogo ad una eccessiva compressione del diritto di contraddire in giudizio. Non sono invece state ritenute tali da poter definire dei “contro limiti” alla vigenza del diritto UE le norme costituzionali riguardanti la struttura dei poteri dello stato e le forme del loro esercizio (in questo senso si è ad esempio espressa la sentenza n. 183/1973).
Dalle decisioni della Consulta si possono trarre alcuni principi fondamentali. Anzitutto è evidente che il solo possibile fondamento di eventuali limiti alla vigenza del diritto UE nel nostro ordinamento è rappresentato dall’art. 11 Cost.. In tal senso depone soprattutto la sentenza 183/1973, che – oltre a menzionare espressamente l’art. 11 – ha specificato anche che la limitazione di sovranità dello stato italiano a favore dell’UE può avvenire solo “a parità di condizioni con altri stati” ed esclusivamente “per le finalità ivi (ossia in quella stessa norma n.d.r.) precisate”. Altro principio importante – questa volta desumibile, come si è visto qui sopra, dalla decisione n. 232/1989 – è che i principi fondamentali rilevanti ai sensi dell’art. 11 Cost (e su cui dunque possono dunque essere fondati i “contro limiti” alla vigenza delle norme UE) non sono solamente quelli che trovano riscontro nelle convenzioni internazionali sui diritti umani, ma neppure sono solo quelli enunciati negli articoli da 1 a 12 Cost, estendendosi viceversa anche a tutti i principi che possono essere desunti dagli artt. da 13 a 54 della nostra Carta fondamentale.
Quanto sopra consente di sostenere che, in ultima analisi, tre sono i criteri per verificare se una norma di fonte unionista (o l’insieme delle norme che disciplina un certo istituto giuridico di diritto unionista) è stata resa efficace nel nostro ordinamento rispettando i limiti posti dall’art. 11 Cost. e – di conseguenza – se quella norma o quell’istituto possono trovare applicazione nel nostro ordinamento.
- La normativa in questione deve rispettare – almeno in via di principio – il principio di reciprocità con gli altri stati dell’UE (nel senso che l’Italia non deve assumere obblighi che, formalmente, non assumono anche altri stati);
- Deve trattarsi di normativa “necessaria” per contribuire a un ordinamento internazionale che miri ad assicurare la “pace” e la “giustizia” tra le nazioni;
- Si deve trattare di una normativa che non si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. da 1 a 54 della Costituzione, anche se si tratta di principi che esprimono un livello di tutela (sia quanto al diritto che ne forma oggetto sia quanto al livello di tutela che a quel diritto viene assicurato) che non trova un riscontro nelle convenzioni internazionali sui diritti umani.
Se manca anche uno solo dei tre requisiti di cui si è detto, la normativa di fonte unionista può essere dichiarata inefficace erga omnes dalla Consulta, con sentenza che procederà alla declaratoria di illegittimità della legge di ratifica dei trattati istitutivi dell’UE (dunque, oggi, del TUE e del TFUE) nella parte in cui ha consentito agli organi unionisti l’adozione della normativa di diritto secondario unionista che viola il precetto costituzionale nazionale. L’illegittimità parziale della norma di ratifica si tradurrà in una illegittimità parziale della norma unionista di fonte primaria che travolgerà automaticamente la norma unionista di fonte secondaria, rendendola inefficace sul nostro territorio.
3. L’Euro, com’è noto, è la moneta con valore legale comune agli Stati Membri dell’Unione Europea (o, per meglio dire, dovrebbe esserlo, nel senso che ad alcuni Stati che ne hanno fatto a suo tempo espressa richiesta è stata concesso di mantenere in corso legale le vecchie valute nazionali). L’Euro è stato introdotto formalmente in Italia con il regolamento UE n. 974/98 del 3 maggio 1998 (adottato a seguito del precedente regolamento UE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, che riguardava la moneta scritturale definita come ECU e che era stata adottata come strumento interlocutorio per la preparazione dell’entrata in vigore della moneta unica). Il fondamento giuridico di diritto primario di questi regolamenti si trova a sua volta nelle norme del titolo VIII della versione attuale del testo consolidato TUE/TFUE. L’emissione di Euro resta affidata in via esclusiva alla Banca Centrale Europea, soggetto indipendente di diritto unionista che, tuttavia, non funge – come accade per le normali banche centrali nazionali – da prestatore di ultima istanza, non potendo la BCE (quanto meno in teoria) emettere moneta per acquistare (sul mercato primario) titoli del tesoro emesso dagli Stati Membri.
La ragione politica ufficiale che veniva indicata al tempo della sua entrata in vigore al fine di sostenere l’opportunità dell’adozione della moneta unica consisteva nella supposizione che l’introduzione – nella zona di libero scambio esistente tra i paesi unionisti – di un’unione monetaria precedente all’unificazione delle rispettive politiche fiscali ed economiche, avrebbe reso più facile una “naturale convergenza” dei sistemi economici degli stati, agevolando il processo di integrazione europea e favorendo di conseguenza la futura adozione di politiche fiscali ed economiche comuni. Come vedremo si tratta di una idea che – alla luce di quel che è accaduto dopo – si sarebbe rivelata largamente illusoria. Tutto questo per ragioni che – in verità – potevano essere facilmente già intuite (e che alcuni economisti, come vedremo, avevano intuito) già al momento della sua adozione.
Passando in rassegna le norme del TFUE che compongono l’impalcatura fondamentale della politica monetaria unionista emerge infatti con una certa chiarezza come lo scopo primario (se non esclusivo, quanto meno al momento della sua adozione) del sistema della moneta unica sia il perseguimento della stabilità dei prezzi. Questa è del resto la ragione per cui l’economista (e premio Nobel) Paul Krugman – già prima dell’adozione della moneta unica – aveva osservato che l’Unione monetaria europea non era stata progettata per soddisfare le esigenze di politica economica comuni a tutti gli stati dell’unione, bensì per soddisfare la Germania, estendendo a tutta l’eurozona la severa disciplina antinflazionistica che da sempre ispirava la politica economica tedesca e alla quale la stessa Germania – per ragioni di politica interna – non sarebbe mai stata disposta a rinunciare neppure in nome dell’integrazione europea. Secondo questo economista, dunque, l’Euro nasceva in sostanza con il (non dichiarato) intento di estendere a tutta l’Eurozona una ricetta monetaria – ma che, come vedremo, implica una serie di conseguenze in termini di politica economica – sostenuta da (e che conveniva soprattutto a) uno stato in particolare.
Lo scopo istituzionale del sistema Euro è infatti in sostanza quello di mantenere l’inflazione media nei paesi dell’eurozona entro un livello ritenuto ottimale, che viene da sempre individuato dalla BCE intorno al tasso del 2% su base annua. Si noti che – nella prima fase di vita della moneta unica, che potremmo dunque definire come “ortodossa” – il 2% era indicato solo come limite da non superare, dunque rendendo evidentissima la natura antinflazionistica dell’Euro. Più di recente (essenzialmente quando le ripetute crisi economiche hanno convinto un po’ tutti quanti che il vero problema dell’economia europea è semmai la deflazione e non certo l’inflazione) si è iniziato a sostenere – in particolare a partire dalla presidenza Draghi alla BCE – che l’inflazione nell’eurozona, oltre che non oltrepassare quella soglia, non doveva mai scendere troppo al di sotto di essa. Questo significa che l’Euro viene concepito oggi (quanto meno dalla BCE, la cui Presidente ha di recente avuto un vivace scambio di opinioni niente meno che con la Corte Costituzionale tedesca) come uno strumento di politica monetaria che serve sia per evitare l’inflazione che per scongiurare una eccessiva deflazione. Questo significa allora che – come dimostrerebbero anche i recenti mal di pancia registrati dalle parti di Karlsruhe – siamo di fonte ad una svolta epocale, nel senso di ammettere che il sistema Euro potrebbe risultare funzionale anche all’adozione di politiche economiche espansive nell’eurozona? Non esattamente, giacché – come spesso accade – sono i piccoli dettagli a fare le grandi differenze.
Anche nella versione attuale del sito internet istituzionale della BCE la giustificazione delle politiche di stimolo monetario per evitare il calo dei prezzi di beni e servizi è che “non è positiva una riduzione dei prezzi continua e diffusa nell’economia che non sia connessa a miglioramenti della produzione”. Con queste parole la BCE conferma infatti che, in realtà, l’Euro resta essenzialmente lo strumento con cui l’UE mira a moderare l’inflazione (e dunque, fra l’altro, a ridurre il costo del danaro) al fine di creare la situazione ideale per consentire l’attuazione di una ben precisa ricetta di politica economica: quella che ha come scopo ultimo il calo dei prezzi di beni e servizi per effetto del miglioramento della produzione. Per capire dunque a cosa davvero serve l’Euro oggi occorre capire cosa intende la BCE quando parla di miglioramento produttivo.
Ebbene: per miglioramento della produzione si intende quello che gli economisti definiscono come “maggiore produttività” a livello di offerta. Le principali strade note per conseguirla sono in sostanza tre: miglioramento tecnologico (che aumenta la resa a parità di costo di altri fattori produttivi), riduzione del costo delle materie prime e taglio del costo del lavoro. Nell’economia globalizzata di oggi, in cui la domanda aggregata di risorse è in crescita costante (specie negli stati emergenti come Cina, India e Brasile), la riduzione del costo per materie prime è difficilmente pensabile. Quanto all’innovazione tecnologica, è invece quasi impossibile prevedere quali e quante soluzioni innovative verranno individuate per effetto di un certo volume di investimenti in ricerca e sviluppo e, di conseguenza, è difficile prevedere quale potrebbe essere l’impatto che il capitale investito in innovazione tecnologica o di processo potrebbe avere in termini di calo di costi complessivi dal lato dell’offerta.
Tutto questo spiega perché, nell’attuale contesto economico, lo strumento più sicuro ed efficace con cui gli stati possono perseguire un aumento di produttività è il taglio del costo del lavoro, misura che – a differenza dell’investimento in ricerca tecnologica – non richiede cospicui investimenti e soprattutto garantisce risultati immediati in termini di risparmio di costi e dunque di calo di prezzi. D’altro canto, è nozione pacifica dell’economia politica quella secondo cui se la disoccupazione è bassa, l’inflazione tende a salire, mentre quando la disoccupazione è alta, l’inflazione diminuisce. Ed ecco infine spiegato perché l’adozione di politiche volte alla compressione dei salari (in questo si sostanzia infatti il taglio del costo del lavoro) è una delle conseguenze inevitabili dell’adozione della moneta unica (anche in epoca di quantitative easing), dal momento che si tratta della misura che consente più facilmente di giungere a quel calo generalizzato dei prezzi di beni e servizi che – secondo la BCE – sarebbe “buono” in quanto non deriva da una fase di prolungata debolezza della domanda. Altrettanto noto è tuttavia che lo strumento necessario per comprimere le pretese salariali dei dipendenti è ridurre la stabilità del posto del lavoro. Questo significa che il sistema dell’Euro – per soddisfare il suo scopo istituzionale (ridurre i prezzi di beni e servizi in un contesto di inflazione bassa ma stabile) – implica il mantenimento in tutti gli stati dell’eurozona di un certo tasso di disoccupazione.
Sennonché, quando calano sia il numero degli occupati che i salari dei lavoratori, cala di conseguenza anche il rispettivo potere d’acquisto e, dunque, si genera un potenziale effetto depressivo sulla domanda interna, col rischio dell’innesco di fenomeni di deflazione “cattiva” secondo la BCE. Questo calo potrebbe in teoria essere in parte compensato dal calo di prezzo dei prodotti e dei servizi (indotto dal taglio del costo del lavoro), che dovrebbe far crescere il potere d’acquisto reale dei salari, anche a fronte di una discesa di questi ultimi. Il problema è che questa dinamica “virtuosa” – in una situazione di domanda interna debole e tenendo conto della naturale tendenza delle imprese a trasformare in maggiori utili i tagli di costo – ben difficilmente può venire a innescarsi. Quale è stata dunque la ricetta che consente – a fronte di una sostanziale crescita degli utili d’impresa – di comprimere i salari e mantenere un certo tasso di disoccupazione senza al contempo innescare fenomeni di deflazione sufficientemente intensi da innescare una spirale recessiva?
Questo risultato può essere ottenuto in due modi. Anzitutto destinando una quota maggiore della produzione – quella che non può essere assorbita dalla domanda interna indebolita dai salari bassi e dalla disoccupazione – all’esportazione, in sostanza prelevando dagli stati di esportazione la ricchezza liquida che non può provenire da una domanda interna depressa dal taglio dei salari e dalla disoccupazione. In seconda battuta mediante misure pubbliche di sostegno al reddito dei lavoratori che hanno salari più bassi e di assistenza agli inoccupati (i quali, in sostanza, si vedono restituire dall’assistenza pubblica una quota di quel che hanno perso per effetto della compressione dei salari o della impossibilità di trovare una occupazione). Si tratta – di nuovo – del modello adottato da un paio di decenni in Germania, secondo quella che è stata definita “dottrina Hartz”: compressione dei diritti dei lavoratori (specie sotto il profilo della stabilità dell’occupazione) con riduzione progressiva dei salari nominali, compensate da misure di sostegno pubblico per i lavoratori a basso reddito e per gli inoccupati e da un forte incentivo statale all’export. Una simile politica di stampo mercantilista (in cui cioè lo stato favorisce l’impresa, incentivando le esportazioni e sostenendo il reddito di lavoratori a basso reddito e inoccupati invece che sostenerne le rivendicazioni salariali) consente infatti l’aumento della produttività delle imprese (e dunque degli utili di chi vi investe capitale di rischio) fondato sulla riduzione delle dinamiche salariali senza implicare eccessivi problemi di deflazione, anche in situazioni di domanda interna debole.
Ecco spiegato perché l’Euro – per come definito dai trattati e per come “amministrato” dalla BCE anche all’epoca del quantitative easing – rappresenta uno strumento di politica monetaria che in realtà induce gli stati ad adottare politiche economiche di riduzione dei salari mediante la precarizzazione del lavoro, compensando l’indebolimento della domanda interna mediante incentivi all’export (sia verso altri stati aderenti all’eurozona sia verso stati extra UE) e misure pubbliche di assistenza per i lavoratori a basso reddito e/o per gli inoccupati. Tutto questo consente di sostenere che il sistema Euro – per sua stessa struttura e anche dopo l’inizio degli stimoli monetari – resta uno strumento studiato per contribuire a generare una crescita economica moderata (dunque per impedire – fra l’altro – fasi espansive quando pure servirebbero per superare una stagnazione economica), i cui frutti restano per la maggior parte nelle mani di chi controlla e finanzia le imprese, mentre – attraverso la riduzione dei salari e la precarizzazione del lavoro – viene ridotta la quota di ricchezza che viene assegnata dal sistema economico ai lavoratori.
Si tratta di un sistema – si badi – che favorisce non solo chi controlla il capitale delle imprese (che vede crescere gli utili a fronte dell’assunzione da parte dello stato di una quota dei costi sociali ed economici causati da disoccupazione e riduzione dei salari) ma che conferisce dei vantaggi alla stessa classe politica. Questo modello – implicando la necessità di sussidi pubblici per un maggior numero di lavoratori e inoccupati – consente infatti alle forze politiche più propense all’assistenzialismo di intercettare con grande facilità il voto dei lavoratori (e degli inoccupati) che – per effetto della depressione della domanda interna e dell’aumento della produttività perseguito ai loro danni – si troveranno sempre più costretti a rivolgersi appunto all’assistenza pubblica per poter mantenere un tenore di vita decente. Si tratta infine di un sistema gradito anche al sistema finanziario e creditizio, giacché – oltre a generare maggiori utili d’impresa e dunque maggiori rendimenti per l’investimento in venture capital – aumenta anche la propensione all’indebitamento privato da parte dei lavoratori a basso reddito (agevolato anche dal fatto che una bassa inflazione consente al sistema finanziario e bancario di praticare bassi tassi nel credito al consumo o nel credito bancario). Sin qui, dunque, l’esame della politica economica al cui perseguimento l’Euro – anche in epoca attuale – contribuisce.
Sennonché nessuna ricetta di politica economica – quando viene applicata all’interno di uno stato sovrano – può sottrarsi al confronto con i principi costituzionali che, in quello stesso stato, definiscono il perimetro in cui i poteri pubblici sono liberi di muoversi nel definire la politica economica nazionale. All’interno del principio fondamentale del libero mercato e della libertà d’iniziativa economica privata, che ispira ormai tutte le costituzioni dei paesi occidentali, ciascuno stato ha infatti individuato una propria specifica “costituzione economica”, rappresentata – appunto – dall’insieme di principi e limiti ai quali il legislatore soggiace nel regolare l’esercizio delle libertà economiche dei cittadini. Occorre dunque verificare se il modello unionista di politica monetaria ed economica – che ricalca in sostanza il modello di costituzione economica tedesca – sia conforme anche alla costituzione economica di tutti gli altri paesi dell’UE. Vediamo in partuicolare come stanno le cose in Italia.
4. L’art. 1 della Costituzione – dunque certamente la norma di vertice nella gerarchia costituzionale – recita testualmente che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. La democrazia e il lavoro, dunque, nel nostro ordinamento costituzionale sono ritenuti niente meno che il fondamento stesso della Repubblica. L’art. 4 della Costituzione – sempre collocato nei diritti fondamentali – dispone poi che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Il rispetto dei due principi in questione rappresenta dunque senza alcun dubbio una manifestazione di quella “utilità sociale” che l’art. 41 Cost. indica come limite per il legittimo svolgimento dell’attività d’impresa privata. Il che a sua volta significa che la particolare attenzione al lavoro fa certamente parte di quella che – secondo la dottrina tedesca dell’”identity test“ – potremmo definire come “identità costituzionale” nazionale. Per altro verso, l’art. 47 Cost. dispone che la Repubblica non solamente “tutela” ma anche “incoraggia” il risparmio dei cittadini, di guisa che parrebbe rientrare tra i fondamenti identitari della nostra Costituzione economica anche il principio secondo cui il compenso del lavoro dipendente (ma forse il discorso si può estendere anche ad altre attività lavorative) non può mai ridursi al minimo indispensabile per vivere (o, anche peggio, ad un livello tale da dover richiedere sussidi statali per farlo) .
Tutto questo induce a ritenere che ben potrebbe rappresentare un principio identitario e fondamentale della nostra costituzione quello secondo cui i cittadini hanno diritto a un lavoro compensato in misura tale da consentire loro, non solo di soddisfare le proprie esigenze primarie, ma anche da poter accumulare un margine risparmio privato. Ammettere questo, significherebbe ammettere anche che – qualunque sia il modello di politica economica che il nostro legislatore decide di adottare – la politica economica nazionale non potrebbe in ogni caso, per poter funzionare, fondarsi sull’esigenza che una parte dei cittadini resti disoccupata e tanto meno potrebbe fondarsi sulla necessità che una significativa quota dei lavoratori abbia necessità di integrare il reddito ricorrendo a sussidi pubblici (o – peggio – all’indebitamento privato) per arrivare a fine mese. L’opzione di costituzione economica definita dalla nostra carta fondamentale mi pare infatti piuttosto chiara nel senso la prima forma di welfare che lo stato deve promuovere non è l’assistenza pubblica a chi versa in stato di bisogno (misura residuale e limitata a determinate e circoscritte ipotesi), bensì dalla prevenzione dello stato di bisogno grazie a politiche economiche che consentano alla maggioranza dei cittadini di ottenere un lavoro con cui mantenersi dignitosamente (senza aver bisogno della beneficienza dello stato) e, magari, riuscendo pure a mettere da parte del risparmio personale.
Senza voler dunque arrivare all’estremo di ritenere che la piena occupazione sia il solo scopo che deve perseguire qualunque iniziativa di politica economica (e monetaria) assunta dal nostro stato, mi pare invece possibile sostenere con una certa forza di argomenti che dovrebbe restare preclusa al nostro legislatore l’adozione (e dunque l’accettazione eterodiretta) di politiche economiche o monetarie che in via di fatto implicano necessariamente la creazione e il mantenimento di un certo tasso di disoccupazione. Discorso che dovrebbe valere a maggior ragione nei casi in cui simili politiche – oltre a creare una “disoccupazione fisiologica” – implichino addirittura la necessità di erodere risparmi e compensi dei lavoratori, con conseguente necessità di provvedere all’integrazione del loro reddito da parte dell’assistenza pubblica e spingendoli a un crescente indebitamento privato.
Le considerazioni che precedono mi inducono dunque a mettere in dubbio che l’adesione al sistema Euro – considerando il genere di politica economica che quello stesso sistema induce gli Stati Membri ad adottare – sia stata un decisione rispettosa dei principi definiti dagli art. 1, 4, 41 e 47 Cost., dunque di principi che senza dubbio possono contribuire a definire l’”identità” della nostra Costituzione economica. Per questa ragione – in applicazione della dottrina dei “conto limiti” (in particolare della sua variante “tedesca” dell’identity test, a suo tempo condivisa anche dalla nostra Corte costituzionale nella citata decisione 232/1989) – si può a mio avviso sostenere che la legge di ratifica dei trattati UE, nella parte in cui – per mezzo dell’accettazione delle norme contenute nel titolo VIII del TFUE nel testo consolidato attuale – ha consentito l’adozione della moneta unica, potrebbe aver rappresentato una limitazione di sovranità accettata dal legislatore nazionale al di fuori dei limiti richiesti dall’art. 11 Cost.. Ma non è ancora tutto.
5. La creazione di una moneta unica tra stati con economie non omogenee (all’interno di un’area di libero scambio e in assenza di trasferimenti di risorse da uno stato all’altro da parte di una autorità che possa agire in modo autonomo e indipendente dagli stati stessi) genera un secondo ordine di conseguenze foriere di pesanti ricadute costituzionali.
All’interno di un’area di libera circolazione delle merci e dei servizi, la competizione tra economie degli stati che vi aderiscono è in sostanza una competizione di prezzo. Quando dunque in una zona di libera circolazione viene imposto un sistema di cambi fissi (in cui non è possibile per ciascuno stato svalutare o rivalutare la moneta) per far calare il prezzo di beni e servizi gli stati – per ragioni che abbiamo già indicato in precedenza – devono per forza dar calare i salari. In questo genere di unioni, dunque, alla flessibilità del cambio nominale viene sostituita la flessibilità dei salari nominali. Ma per flessibilizzare i salari nominali lo strumento principale – come pure si è già avuto modo di verificare – è precarizzare i lavoratori. Il tutto – come, di nuovo, si è già visto – compensando la deflazione interna con un incentivo all’export. Questo significa che un sistema di cambi fissi tra stati che aderiscono a un mercato in cui vige il principio di libera circolazione di merci, capitali e servizi inevitabilmente innesca una competizione tra stati fondata sulla corsa al ribasso dei salari e alla precarizzazione dei lavoratori, compensata da un aumento dell’export rispetto al consumo nazionale interno.
Questa situazione induce gli stati che (grazie a una più rapida compressione dei salari e a più efficaci incentivi all’export) hanno raggiunto per primi una migliore produttività (e dunque una grande competitività sui mercati esteri) a esportare sempre più prodotti a basso costo anche verso gli altri stati dell’unione monetaria (ma che si trovano in ritardo in termini di produttività), dunque dirottando a favore degli stati più forti una quota del residuo potere d’acquisto della domanda interna degli stati più deboli, con la conseguenza di sottrarre ulteriori risorse economiche alle imprese di degli stati più deboli. Il tutto con il risultato evidente di aggravare la situazione di debolezza del sistema produttivo dello stato di esportazione. Si noti peraltro che quando un simile modello – come avviene per l’UE – prevede anche la libera circolazione delle persone all’interno dello spazio comune, la deflazione indotta negli stati meno produttivi dall’aggressività dell’export di quelli più produttivi provoca anche una emigrazione di risorse umane (in special modo quelle più qualificate, che non possono più essere adeguatamente remunerate nell’economia stagnante dello stato meno produttivo) dagli stati meno produttivi a quelli più produttivi, contribuendo dunque anche sotto questo profilo all’aggravarsi della situazione economica (e di minore produttività) di questi ultimi.
Tutto questo per dire che il sistema della moneta unica europea – unito alla zona di libero scambio e circolazione unionista e in assenza di politiche indipendenti dalla volontà delle cancellerie degli stati membri – genera inevitabilmente una dinamica economica che incentiva una forma di darwinismo economico per cui gli stati “più efficienti” usano le esportazioni di beni ad alto valore aggiunto per sottrarre risorse economiche e umane agli stati “meno efficienti”, con il risultato di allargare progressivamente il gap di efficienza produttiva tra stati (invece di ridurlo, come dovrebbe accadere in una “unione”). Si tratta insomma – a ben vedere – di una dinamica assai simile a quella, ampiamente studiata in dottrina economica, che al tempo del colonialismo caratterizzava i rapporti tra gli stati colonizzatori (che traevano vantaggi crescenti dagli scambi commerciali con le colonie) e gli stati colonizzati (che invece – in forza di quegli stessi scambi commerciali – venivano poco a poco spogliati delle proprie risorse senza innescare alcun reale sviluppo economico).
Si noti peraltro che, in presenza di simili rapporti di forza economica, l’adesione alla moneta unica – oltre che aver contribuito a creare la dinamica concorrenziale negativa di cui si è detto – ha anche avuto l’effetto negativo ulteriore di sottrare agli stati meno produttivi l’ultima arma che avrebbero potuto utilizzare per rimettersi al passo con quelli più produttivi, rappresentato dalla svalutazione competitiva della moneta nazionale. Dunque gli stati meno competitivi nell’UE si trovano attualmente – rispetto ai paesi più competitivi dell’Unione – in situazione analoga a quella in cui si trovano – rispetto alla Francia – i paesi africani delle ex colonie che hano adottato il franco CFA (ora ribattezzato ECO).
Tracciare un parallelismo tra l’eurozona e i (vecchi e nuovi) sistemi coloniali è tutt’altro che una boutade o un’iperbole ad effetto, quando si consideri che il già citato Paul Krugman – già Nobel per l’Economia nel 2008 proprio per la sua analisi degli andamenti commerciali e del posizionamento dell’attività economica in materia di geografia economica – ha avuto modo di sostenere, nel lontano 1999, che “adottando l’Euro, l’Italia si è ridotta allo stato di una nazione del Terzo Mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera, con tutti i danni che ciò implica” mentre, più di recente, ha affermato che “L’Europa non era adatta alla moneta unica, come invece gli Stati Uniti. Spagna e Florida hanno avuto la stessa bolla immobiliare ma la popolazione della Florida ha cercato lavoro in altri Stati meno colpiti dalla crisi, gli spagnoli non hanno avuto la stessa opportunità. Assistenza sociale, assicurazioni sanitarie, spese federali e garanzie bancarie nazionali sono di competenza unicamente del governo di Washington per tutto il territorio, mentre in Europa non è così. Questo è uno dei principali motivi della fragilità del sistema Europa“.
Insomma, anche sotto questo profilo ce n’è a mio avviso più che abbastanza per dubitare del fatto che le limitazioni di sovranità assunte dall’Italia quando ha aderito al sistema della moneta unica – quanto meno allo stato attuale dell’Unione, ossia in una zona di libero scambio senza una vera unione europea che sappia esprimere politiche economiche e sociali indipendenti dalla volontà dei singoli stati aderenti (e in special modo dalla volontà di quelli “più produttivi”) – siano “necessarie” per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, come invece richiede l’art. 11 Cost. Si tratta infatti di limitazioni che paiono funzionali più che altro ad alimentare una sempre più feroce competizione tra stati, in cui gli stati che – preferendo anteporre il benessere dei propri cittadini alla “produttività” del sistema – finiscono per restare preda dell’aggressività economica dei paesi più produttivi, senza potersi più neppure difendere con lo strumento (la svalutazione monetaria) che in altre epoche gli avrebbe consentito di reagire all’attacco. Più passa il tempo e più – per effetto della moneta unica e degli altri aspetti della costituzione economica definita dai trattati unionisti – gli squilibri tra le economie dei paesi dell’eurozona si aggraveranno, sempre e solo a favore degli stati che mettono la produttività prima del benessere dei cittadini e sempre e solo a danno di quelli che invece mettono il benessere prima della produttività.
L’Euro è dunque un meccanismo monetario che per sua stessa struttura e funzione – lungi dal favorire l’integrazione delle economie degli stati aderenti all’UE – non solo li mette in competizione tra loro, ma addirittura induce gli stati più forti economicamente (che poi sono quelli che hanno scelto di aumentare immediatamente la produttività a scapito del lavoro) a praticare una politica che potremmo definire “neo coloniale” (o comunque predatoria e commercialmente aggressiva) nei confronti dei membri più deboli della stessa unione cui appartengono. Il tutto con due soli possibili esiti finali. O i paesi “forti” integreranno totalmente quelli deboli nei loro sistemi economici (acquistando il controllo del capitale delle imprese di pregio e assegnando al resto del tessuto produttivo del paese il ruolo di fornitori – a basso costo – di manodopera, di materie prime o di beni intermedi e servizi a basso valore aggiunto). Oppure – se questa operazione non sarà possibile o non sarà ritenuto conveniente da quegli stessi paesi “forti” (che magari preferiranno individuare in paesi meno sviluppati al di fuori dell’UE i loro fornitori a basso costo) – i paesi deboli verranno infine espulsi dall’”unione”, dopo averne devastato le rispettive economie nazionali con decenni di depressione della domanda interna e conseguente distruzione dei tessuti produttivi nazionali.
Ecco qui sopra riassunto in poche parole il genere di “pace e giustizia” tra stati che l’Italia ha accettato di perseguire aderendo alla moneta unica europea. Pare insomma aver colto nel segno il monito lanciato – sempre diversi anni orsono – dall’analista economico Martin Feldstein nell’articolo “EMU and international conflict”, Foreign Affairs, vol. 76, n. 6, novembre – dicembre 1997, in cui ha avuto modo di sostenere che “Instead of increasing intra-European harmony and global peace, the shift to EMU and the political integration that would follow it would be more likely to lead to increased conflicts within Europe”. Il tutto, si badi, con l’aggravante (quanto meno in Italia) che – in questa competizione tra stati aderenti – il sistema dell’Euro premia quelli che attuano più rapidamente restrizioni salariali e che agiscono più efficacemente in termini di riduzione della stabilità e dei diritti del lavoro. L’Euro è insomma un sistema congegnato in modo tale (non solo da accentuare invece che attenuare i conflitti tra gli stati aderenti, ma anche) da indurre l’Italia – per divenire “competitiva” in modo da sottrarsi ad all’inevitabile deriva di marginalizzazione economica che la attenderebbe in caso contrario – a perseguire sempre più attivamente politiche economiche nazionali che si pongono in netto contrasto con il valore primario che le norme costituzionali di cui all’art. 1, 4 e 47 Cost. assegnano al lavoro e al risparmio privato.
In sostanza – e per tirare le somme – l’Euro è uno strumento di politica monetaria che (quando viene applicato in una zona di libero scambio priva di meccanismi compensativi affidati ad istituzioni centrali indipendenti rispetto alla volontà delle cancellerie degli stati aderenti) inevitabilmente induce gli Stati Membri ad ingaggiare tra loro una dura competizione commerciale in cui hanno successo quelli che – sul versante interno – riescono meglio a sacrificare, in nome della “produttività”, i salari e i diritti dei lavoratori e – sul versante estero – attuano aggressive politiche di esportazione verso le economie più deboli. Tutto questo induce a ritenere che l’adesione del nostro paese al sistema dell’Euro – sia perché incentiva una gestione pseudo-coloniale (o, quanto meno, competitivo-predatoria) dei rapporti economici tra gli stati aderenti soia perché risulta ostile a qualunque politica economica che implichi una adeguata partecipazione dei lavoratori ai benefici della crescita economica – ben difficilmente si può considerare un caso di limitazione di sovranità “necessaria” per conseguire un ordinamento internazionale che assicurare “pace” e “giustizia” tra gli stati, quanto meno nell’accezione di “pace” e di “giustizia” che si dovrebbe ritenere accolta dall’art. 11 della nostra Costituzione.
Giova infatti ricordare che la norma in questione ripudia la guerra come strumento per la risoluzione dei conflitti tra stati (e che la costituzione ripudia anche il colonialismo come strumento di dominio economico), mentre l’Euro forma parte integrante di un modello economico e monetario che – nella sua versione attuale – non solo induce gli stati membri ad ingaggiare una feroce guerra commerciale tra loro al fine di contendersi i rispettivi mercati, ma li obbliga anche ad utilizzare come sola arma efficace la compressione dei salari medi, la precarizzazione dei lavoratori e l’aggressività commerciale verso gli altri stati.
6. In questo scritto si è cercato di ragionare essenzialmente di diritto, individuando in particolare le possibili ricadute costituzionali di una serie di considerazioni di economia politica ampiamente condivise all’estero – oltre che da Krugman e Feldstein – anche da altri studiosi del calibro ad esempio del Nobel Stiglitz. Si tratta di considerazioni che invece – qui da noi – sono state approfondite da pochi studiosi, quali l’economista Alberto Bagnai e il giurista Luciano Barra Caracciolo. E’ del resto assai probabile che la lettura di questo saggio faccia alzare più di un sopracciglio nel folto drappello degli europeisti ad ogni costo.
Eppure le considerazioni che ho tentato di svolgere in questa sede mirano essenzialmente a dimostrare che il sistema dell’Euro (nel contesto della politica economica unionista definita dal TUE e dal TFUE nei testi attualmente in vigore) non consentirà mai all’Unione Europea di adottare politiche capaci di affrontare prolungate fasi di debolezza economica mondiale, se non favorendo – ancora e di nuovo – gli Stati Membri più forti a danno di quelli più deboli (e oltretutto frustrando i diritti dei lavoratori). Lungi da me dunque l’idea che l’UE sia “cattiva” o che vi sia della particolare malevolenza verso l’Italia da parte di qualche paese europeo. Il problema è infatti ben più semplice (e proprio per questo – purtroppo – assai più grave): l’Unione Europea è una istituzione che è stata creata per “funzionare bene” (seppure in modo non particolarmente equo) in una situazione congiunturale di perduranti vacche grasse, dunque quando la crescita economica è sostenuta e stabile (come avveniva sino agli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso). In quello scenario, infatti, in cui il solo vero problema è, appunto, solo l’inflazione.
Le ricette pro cicliche – a base di dosi massicce (e crescenti) di austerità – che il sistema unionista, anche per mezzo della moneta unica, finisce inevitabilmente per imporre a tutti gli Stati Membri sono invece drammaticamente inadatte (anzi, gravemente dannose) quando la congiuntura economica si deteriora per lungo tempo. E questo, si badi, non tanto perché si tratta di politiche economiche che non funzionano in assoluto, ma perché si tratta di politiche che – anche in tempi di crisi – pretendono di migliorare la situazione con strumenti pro ciclici che hanno il difetto di aiutare sempre quelli che sono già più forti a spese di quelli che sono già deboli, laddove le “vere” unioni tra stati (e in particolare quelle federali) dovrebbero servire a fare l’esatto contrario, consentendo l’adozione di ricette anticicliche con cui i più deboli vengono aiutati grazie ai più forti proprio nelle fasi in cui il mercato in cui competono forti e deboli – nel suo complesso – si trova in una congiuntura economica negativa. Il sistema dell’Euro non è dunque sbagliato perché non funziona, ma perché il suo stesso modo di funzionare – aggravando il gap tra stati invece che compensare squilibri economici – in presenza di situazioni di crisi provoca per definizione crescenti contrasti e divisioni (e non certo convergenze e armonia) tra gli Stati Membri dell’eurozona. Dunque si tratta di un sistema ha portato a risultati esattamente opposti a quelli per cui si è detto in passato che era stato creato.
Forse anche per noi italiani è infine arrivato il momento di guardare le cose con meno passione e più realismo. L’esperienza di un decennio di governi europeisti (Monti, Letta, Renzi e Gentiloni e, ora, anche il Conte due) che – applicando le ricette a base di austerità indicate da Bruxelles – non hanno risolto la crisi economica in cui versa il paese a mio avviso qualcosa ci dovrebbe insegnare. E questo qualcosa è che non è più possibile negare a priori che la moneta unica (insieme all’insistenza tetragona degli organi UE nell’imporre con zelo quasi religioso a tutti gli stati dell’unione ricette coerenti con una politica economica mercantilista ritagliata sul modello germanico) potrebbero anche essere (non la panacea dei nostri mali, bensì) una delle cause per cui la crisi economica nel nostro paese si è protratta e aggravata ben più che altrove. Né sopravvaluterei la pretesa “svolta epocale” dei vari recovery fund, MES, SURE che l’Unione Europea – dopo la crisi del covid 19 – si è sforzata di inventare per tentare di “aiutare” finanziariamente gli stati con problemi economici.
Sin quando infatti non cambierà qualcosa a livello di costituzione economica dell’unione (dunque fino a quando non cambieranno le norme del TUE e del TFUE) qualunque tipo di “aiuto” finanziario unionista – dovendo risultare conforme a principi scritti a chiare lettere nel TFUE in modo da ricalcare un ben definito modello economico, ossia quello tedesco – finirà presto o tardi, in un modo o nell’altro, per presentare il conto agli stati che adottano modelli di sviluppo differente, imponendo ai rispettivi governi – per aumentare la “produttività” delle imprese – di colpire salari, stabilità del lavoro, previdenza, sanità, istruzione e risparmio. E pure se alla fine si otterrà – al suddetto (caro) prezzo – la tanto agognata “maggiore produttività” del sistema paese, la maggiore ricchezza generata alla fine andrà pur sempre a beneficio soprattutto di chi detiene ingenti patrimoni ovvero di chi detiene il capitale delle imprese nonché a beneficio del sistema creditizio, ma non certo a beneficio della maggioranza dei cittadini e dei lavoratori.
Come magari illustrerò meglio in un successivo contributo, la “costituzione economica unionista” – per come definita dal TUE e dal TFUE attualmente vigenti – subordina infatti il benessere e i diritti della maggioranza dei cittadini europei (e in particolare dei lavoratori) sia alle esigenze di “produttività” del sistema economico dell’unione sia alle esigenze di stabilità del sistema finanziario. La differenza tra questa impostazione – essenzialmente fisiocratica e mercatista – e la visione più sociale e laburista della nostra costituzione economica è dunque certamente uno dei grandi problemi che pone l’adesione dell’Italia alla costruzione europea di Lisbona e Maastricht. Problema che sinora è stato passato sotto silenzio forse sperando in buona fede che la buona volontà degli stati membri l’avrebbe risolto da sé, portando a politiche di maggiore solidarietà e condivisione. Purtroppo, però, così non è accaduto né – visto quel che sta accadendo con il nuovo giro di “aiuti” di cui si parla in questi giorni – è probabile che ciò accada nei prossimi anni. L’Unione europea – che ormai va assumendo sempre di più i tratti di una grande Germania – intende mantenersi fedele a Maastricht e Lisbona, lasciando ben poco spazio ai sogni dei “vecchi” europeisti.
Questo significa che per l’Italia – e in particolare proprio per gli europeisti italiani – è forse giunto il momento di porsi seriamente di fronte al “problema europeo”, trattandosi di un problema che non solo esiste, ma che continuerà ad aggravarsi sino a quando la nostra classe politica non troverà il coraggio di sollevare – anche e soprattutto dalle parti di Berlino e Parigi – la questione se non sia il caso di rifondare l’Unione partendo dai suoi trattati fondativi, smettendo in particolare di considerarla solo una zona di libero scambio con annessa unione monetaria (studiata a tavolino per imporre a tutti quanti un modello economico ritagliato sulle specificità e sugli interessi di pochi), per iniziare a pensare a come trasformarla in uno strumento di effettiva integrazione economica e sociale tra i paesi europei. Ovviamente portare avanti un simile tentativo implica il rischio di ricevere una porta (di Brandeburgo) in faccia. Ma a quel punto quella stessa porta potrebbe essere la via per andarsene serenamente e senza troppi strepiti e drammi da un sistema che, quanto meno per noi, non funziona più. L’Italia, per quanto pesta e ammaccata, ha ancora le energie per rialzarsi. Ma magari – messi alle strette sulla riforme del TUE e del TFUE – ci saranno anche dei paesi che si accorgeranno del fatto che, tutto sommato, è ancora meglio averci come compagni di strada che come concorrenti.
Del resto – agendo in questo modo – l’Italia non farebbe altro che imitare il modello tedesco, ordinamento in cui la costituzionalità delle norme unioniste (e dell’Euro in particolare) rispetto alla Carta fondamentale nazionale è questione certamente attuale, come dimostra la recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca che potrebbe indurre in futuro la Bundesbank a non partecipare più all’ultima versione dei programmi di quantitative easing lanciati dall’Eurotower proprio perché si tratterebbe di programmi ritenuti dalla Corte di Karlsruhe potenzialmente lesivi di norme costituzionali nazionali. I tedeschi, insomma, non hanno avuto alcuna paura ad alzare il dito (anche con il rischio di rovesciare il tavolo) non appena il diritto vivente dell’UE ha mostrato i primi timidi segni di voler abbandonare i principi di teutonica austerità vergati nei trattati fondativi. E proprio questa rigidità dovrebbe confermare che forse è giunto il momento di un franco e sereno chiarimento tra gli stati membri circa le scelte di fondo della politica unionista.
Se però i pasdaran europeisti di casa nostra – vuoi per calcolo politico, vuoi per vari interessi di bottega o vuoi per troppa fede in una vecchia e gloriosa idea – si limiteranno ad annuire di continuo ai padroni dell’Europa e ad abbaiare contro i sovranisti di ogni tipo e genere per il solo fatto che osano mettere in discussione i dogmi del sistema, temo che – presto o tardi – potremmo tutti quanti trovarci in una situazione sociale tanto tesa da rendere il diritto costituzionale il meno traumatico degli strumenti con cui la parte scontenta, ma ancora attiva e vitale, del nostro popolo sovrano cercherà di mettere la parola fine a un gioco che – quanto meno con le regole con cui viene giocato ora – si sta dimostrando sempre meno capace di garantire fiducia, tranquillità e benessere alla maggioranza dei cittadini.