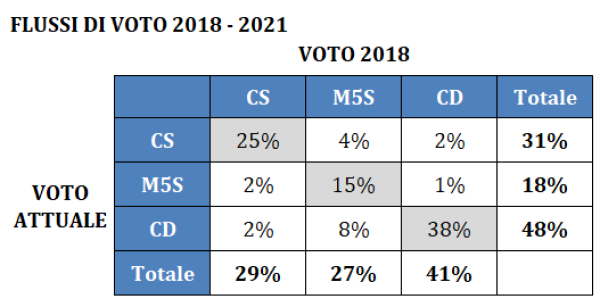Indice DQP: per la pseudo-immunità di gregge (70% di vaccinati) dobbiamo aspettare agosto 2021
Le autorità politiche e sanitarie, in particolare il ministro Roberto Speranza e la sottosegretaria Sandra Zampa, hanno ripetutamente dichiarato che la campagna di vaccinazione serve a raggiungere la cosiddetta immunità di gregge:
5 dicembre: “Il nostro obiettivo è l’immunità di gregge grazie al vaccino” (Roberto Speranza).
17 dicembre: “Immunità di gregge a settembre-ottobre prossimi (Sandra Zampa).
28 dicembre: “Oggi il ministro Speranza ha precisato che entro marzo raggiungeremo la quota di 13 milioni di italiani vaccinati contro Covid-19, e quindi in estate potremo già essere molto avanti nel perseguimento dell’obiettivo immunità di gregge data dal 70%” (Sandra Zampa).
9 gennaio 2021: “Per arrivare all’immunità di gregge dobbiamo vaccinare l’80% di 60 milioni di italiani” (Sandra Zampa).
13 marzo 2021: “È stata considerata una progressione della capacità vaccinale dalle 170 mila somministrazioni medie giornaliere (registrate dal 1 al 10 marzo) fino ad almeno 500 mila entro il mese di aprile” (Piano vaccinale del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19). In base al nuovo Piano vaccinale si dovrebbe arrivare a raggiungere il 70% di copertura vaccinale a fine agosto.
Per “immunità di gregge” si intende una situazione nella quale ci sono abbastanza persone vaccinate (e non in grado di trasmettere il virus) da portare la velocità di trasmissione del virus (Rt) al di sotto di 1, con conseguente progressiva estinzione dell’epidemia. Per calcolare la percentuale di vaccinati necessaria (Vc) per avviare il processo di estinzione dell’epidemia occorre conoscere il valore di R0 (velocità di trasmissione in condizioni di normalità) e il valore di E (efficienza media dei vaccini, intesa come capacità di bloccare la trasmissione):
Vc = (1-1/R0)/E
Poiché R0 ed E dipendono dal tipo di varianti presenti in un determinato paese in un dato momento, nonché dalle caratteristiche dei vaccini, nessuno è attualmente in grado di indicare la soglia per l’immunità di gregge. Se E è troppo basso, il valore di Vc supera 1, il che significa che nemmeno vaccinando tutti si ottiene l’immunità di gregge.
Ecco perché la soglia del 70% da noi utilizzata NON è quella che garantisce l’immunità di gregge (e che è sconosciuta), ma è semplicemente la quota realisticamente raggiungibile in un paese come l’Italia, in cui non si possono vaccinare i più giovani (perché manca il vaccino), e una parte degli adulti non intende vaccinarsi.
Ma quante settimane occorreranno per vaccinare un numero di italiani sufficiente a raggiungere una copertura del 70%?
A rispondere a questa domanda provvede l’indice DQP (acronimo di: Di Questo Passo), che stima il numero di settimane che sarebbero ancora necessarie se – in futuro – le vaccinazioni dovessero procedere “di questo passo”.
A metà della ventunesima settimana del 2021 (mercoledì mattina, 26 maggio) il valore di DQP è pari a 13 settimane, il che corrisponde al raggiungimento della pseudo-immunità di gregge non prima del mese di agosto del 2021.
Il valore del DQP è rimasto sostanzialmente stabile rispetto a quello della settimana scorsa.
Anche questa settimana sono state somministrate più di 3 milioni di dosi, circa 480 mila al giorno, poco meno delle 500 mila dosi previste dal piano vaccinale (l’obiettivo delle 500 mila somministrazioni giornaliere è stato raggiunto soltanto per tre giornate consecutive, fra il 20 e il 22 maggio).
Nel caso in cui si decidesse di utilizzare soltanto vaccini che prevedono una seconda somministrazione, occorrerebbero 2 settimane in più. “Di questo passo” la pseudo-immunità di gregge verrebbe raggiunta in 15 settimane, non prima di inizio settembre del 2021.
Nota tecnica
Le stime fornite ogni settimana si riferiscono ai 7 giorni precedenti e si basano sui dati ufficiali disponibili la mattina del giorno in cui viene calcolato il DQP (quindi possono subire degli aggiornamenti).
Va precisato che la nostra stima è basata sulle ipotesi più ottimistiche che si possono formulare, e quindi va interpretata come il numero minimo di settimane necessarie.
Più esattamente l’interpretazione dell’indice è la seguente:
DQP = numero di settimane necessario per raggiungere almeno il 70% degli italiani con almeno 1 vaccinazione completa procedendo “Di Questo Passo”.
A partire dalla prima settimana completa dell’anno (da lunedì 4 a domenica 10 gennaio) la Fondazione Hume calcola settimanalmente il valore dell’indice DQP (acronimo per: Di Questo Passo).
L’indice si propone di fornire, ogni settimana, un’idea vivida della velocità con cui procede la vaccinazione, indicando l’anno e il mese in cui si potrà raggiungere l’immunità di gregge procedendo “Di Questo Passo”.
Il calcolo dell’indice si basa su 3 parametri:
- quante vaccinazioni sono state effettuate nell’ultima settimana considerata;
- quante vaccinazioni erano già state effettuate dall’inizio della campagna (1° gennaio 2021) fino alla settimana anteriore a quella su cui si effettua il calcolo;
- che tipo di vaccini verranno presumibilmente usati (a 2 dosi o a dose singola).
Nella versione attuale l’indice si basa su due ipotesi ottimistiche, e precisamente:
- l’obiettivo è solo di vaccinare il 70% della popolazione (anziché l’80 o il 90%, come potrebbe risultare necessario);
- ci si accontenta di vaccinare ogni italiano in modo completo una sola volta, trascurando il fatto che, ove la campagna di vaccinazione dovesse prolungarsi per oltre un anno, bisognerebbe procedere a un numero crescente di rivaccinazioni.