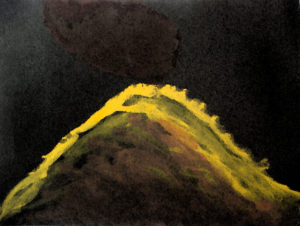Non giocate col passato
Abbiamo oggi, col passato, rapporti strani e contorti. Non sappiamo se amarlo e farlo rivivere in noi, o liquidarlo gettandolo in una specie di dimenticatoio collettivo. Non sappiamo se rievocarlo o affondarlo, se ritenerlo necessario e proficuo o fastidioso e nocivo.
Elenco qui di fila alcuni segnali:
- in America stanno pensando di rimuovere la statua di Cristoforo Colombo, in quanto simbolo della colonizzazione americana, strage di indiani, eccetera;
- una studiosa americana pensa di abbattere tutti gli edifici dell’epoca fascista;
- la Boldrini propone di cancellare la scritta DUX dai monumenti di Roma.
Aggiungo un aneddoto personale. Tempo fa mi capitò di parlare con un giovane italiano di talento che studia in Inghilterra. Gli era stata proposta un’ottima borsa di studi, peccato che fosse intitolata a un noto schiavista (nonché sovvenzionata dai suoi fondi), quindi la rifiutò indignato dicendo anche che si sarebbe battuto insieme ad altri perché tali borse fossero cancellate.
Sullo stesso piano mi paiono i tentativi di revisionare i testi e le immagini del passato. Nelle favole vogliamo espungere il Principe Azzurro, simbolo di un retaggio antifemminista. Censuriamo i versi di Dante in cui trapelino espressioni offensivi verso il mondo arabo e la sua religione. Nei film degli anni 50 tagliamo le scene dove l’attore fuma. Nei libri di Cesare Pavese mal tolleriamo la parola “negro”, che all’epoca era normalmente usata.
Tutto ciò è davvero molto interessante, e sorprendente.
Sembra che tutti noi siamo affetti da una paura retrospettiva. È come se non ci sentissimo capaci di reggere: posti di fronte a Humphrey Bogart che fuma, non siamo più capaci di non fumare? È questo?
Ci sentiamo offesi e minacciati dal passato. Ci ho pensato un po’ su. Come può essere che il passato ci offenda e ci minacci? Poi ho capito. È che noi compiamo il gesto davvero stravagante, e discutibile, di portare di peso il passato nel presente: a quel punto ci offende. Se lasciassimo il passato nel passato, non ci sarebbe nessun problema. Sentirci offesi, o minacciati o aggrediti o messi in discussione dal passato, infatti non vuol dire che questo, che stiamo prendendo qualcosa che appartiene a un’epoca precedente (e che in quell’epoca era neutra, direi innocua, non aveva alcun senso offensivo: vedi “negro” in Pavese o l’attore che fuma), e lo stiamo trasportando arbitrariamente nell’epoca in cui viviamo, nei nostri giorni, dove la sensibilità è cambiata, il mondo non è più quello; e poi, avendolo trasportato fino a noi, a quel qualcosa attribuiamo le regole, i principi, gli stili che caratterizzano oggi il nostro vivere. Ovvio, dunque, che determinate cose di allora possano infastidirci. Ma l’errore sta a monte, ed è nostro. Mi ricorda un po’ quando i cattolici mettevano le mutande ai nudi delle grandi opere pittoriche del passato…
È come se volessimo trasformare tutto quel che ci precede a immagine di quel che oggi ci piace e ci sembra equo, corretto, nobile, civile.
È strano, perché predichiamo a destra e a manca quanto sia bene contestualizzare sempre e comunque, collocare ogni cosa nel suo contesto, capire l’epoca, l’ambiente… E poi invece decontestualizziamo allegramente come niente fosse.
Per dire, non dovremmo più leggere Moby Dick e nemmeno citarlo o ricordarlo tra i capolavori della letteratura universale, visto che uccidere animali e andare a caccia ci pare oggi insopportabile e del tutto deprecabile. Pensate alla tragedia della balena bianca, sempre inseguita, braccata, arpionata… Magari ha dei bambini…
Bene. Se qualcosa non ci piace del passato, lo azzeriamo. Contemporaneamente mi par di scorgere un movimento esattamente eguale e contrario: se qualcosa del passato ci piace, non esitiamo a ripescarlo tal quale e riproporlo identico, del tutto decontestualizzato, come se fosse sempre attuale, o avesse una valenza atemporale e assoluta. Per esempio: continuiamo a chiamare “fascisti” gli esponenti della parte politica avversa, o persone che semplicemente non aderiscono al pensiero progressista dominante; invochiamo, per illustrare i principi che animano una riforma innovativa (v. scolastica), opere e autori di cinquant’anni fa (v. don Milani); celebriamo “giorni della memoria” perché non si dimentichino certi gravi avvenimenti della storia.
Mi sembra che ci giochiamo il passato un po’ come ci pare, a seconda delle nostre convinzioni del momento, spesso dettate da un sentire collettivo che ci fa da diktat. Se ci fa comodo lo ricordiamo ed esaltiamo; se non ci piace, lo cancelliamo.
Credo che dovremmo avere un atteggiamento più sereno e distaccato. Soprattutto, prendere il passato per quel che è: passato. Ricordarlo, studiarlo, ma non stravolgerlo a nostro uso, non attualizzarlo (nel bene e nel male), e meno che mai rimuoverlo.
Facciamo una prova. Prendiamo Mao. A me personalmente non piace Mao, non mi piace nulla di quel che ha fatto, 50 milioni di morti, la rivoluzione culturale e tutto il resto. Ero molto perplessa, per non dir altro, quando i miei compagni liceali, negli anni ’70, inneggiavano al suo libretto. Ora, mettiamo che la mia migliore amica si tenga appeso in camera un manifesto di Mao. Non me n’ero accorta, o non lo sapevo, entro in camera sua vedo Mao sul muro, e mi turba moltissimo. Magari gliene parlo indignata, ma non mi verrebbe mai in mente di ordinarle di togliere quel poster, meno che mai di vietarglielo con una legge. Semmai potrei dire che non la voglio più, un’amica così, che non posso avere niente in comune con lei. Sarebbe nei miei diritti. Sarebbero fatti miei, se decido di essere o non essere amica di qualcuno che si tiene Mao in camera. Potei preferire una che si appende al muro Garibaldi. Ma sono, lo ripeto, fatti miei. Pertengono alla mia coscienza, alla mia storia. Non intaccano il passato, dove, c’è stato tanto Garibaldi quanto Mao. (Stesso discorso, ovviamente, per la statuetta di Mussolini…).
Quel passato io non posso negarlo, o stravolgerlo. E nemmeno santificarlo e celebrarlo, secondo me. C’è stato, e ha una sua esistenza fissata per sempre, ma collocata in un preciso spazio temporale. È il passato. E il passato ha questo di buono, e di innegabile: è stato, non si può cancellare. Ma, anche, non c’è più: quindi nemmeno si può attualizzare. Essendo il passato, non è il presente.
***
Riflettevo in questi giorni anche su un altro fenomeno, solo apparentemente distante. Riguarda i libri di saggistica che oggi si pubblicano, spesso di autori giovani, scrittori o giornalisti che siano. In genere non contengono riferimenti bibliografici. Nessuna nota, nessuna citazione.
Tali nuovi autori affermano tesi, discutono concetti, propongono idee, come se fosse tutta roba loro, nuovissima, inedita, originale: pensata da loro per primi in assoluto nella storia dell’umanità. Sembrano non essere minimamente a conoscenza dei libri, spesso importanti, noti, autorevoli, che li hanno preceduti, scritti magari da mostri sacri della tradizione, o anche solo da autori più anziani di una ventina d’anni. Niente, tutto sparito. Vale anche per i nuovi lettori, anch’essi ignari che quel che leggono abbia radici in libri precedenti. Così, può capitare che esca un saggio che ripete le tesi di un saggio uscito anche solo cinque anni prima, e venga salutato come nuovo e completamente originale.
Non credo sia (solo) ignoranza. E nemmeno sciatteria intellettuale. Credo si tratti di un vero e proprio stile.
Sia chiaro, la saggistica colta è sparita da tempo dai nostri orizzonti, o si annida oggi in certe nicchie buie e introvabili, e non è certo mia intenzione sperare che resusciti. Dico solo che la consuetudine di citare quelli prima di noi è scomparsa. Oggi ci piace essere leggeri ed estemporanei, diretti, comunicativi. Ci piace una prosa quotidiana, un parlato-vissuto, una forma di dichiarata “ingenuità”. Complice lo stile “social”, il rap, il pop. Certo. Fa tutto parte di una evoluzione, o involuzione, dipende dai punti di vista: comunque, è il nuovo stile dei nostri tempi. Niente da dire. Io stessa dovrei fare un bell’esame di coscienza, essendo partita, nei miei anni giovanili, da una saggistica accademica, in cui non si potevano scrivere due pagine senza citare almeno dieci titoli: nessuna affermazione aveva valore se non era suffragata da testi precedenti che la confermassero o la contrastassero. Bisognava mostrare di essere a conoscenza dell’enorme passato che stava dietro di noi, non si poteva scrivere partendo da zero, nascendo in quel momento: nessuno era appena nato, ognuno di coloro che scrivevano avevano ben chiaro di essere solo l’ultimo anello di una catena sterminata. Anzi, scrivere (in ogni ambito, non solo saggistico) forse era proprio quello: inserirsi in una tradizione. Con tanto di inevitabile modestia e umiltà. Ricordo che mi pesava un po’, allora, non essere libera di dire direttamente quel che avevo pensato; mi pesava dover accompagnare ogni mia affermazione critica da citazioni e note a piè di pagina infinite, la trovavo un’inutile esibizione di cultura, un mostrare i muscoli per ottenere plauso presso i pochi eletti o gli addetti, soprattutto un laccio che imprigionava il fluido e naturale sgorgare di pensieri personali. Non escludo sia stata questa una delle ragioni del mio allontanarmi dalla scrittura saggistico-accademica.
Mi sembra però il caso almeno di notare ora questa nostra nuova tendenza, nonché i suoi eccessi. Forse fa parte di quella cancellazione del passato di cui dicevo sopra. Nulla prima di me. Noi unici sopravvissuti di un mondo saltato per aria. Ci dev’essere stata una deflagrazione da qualche parte, in un certo momento, che ci è sfuggita. Intorno a noi solo macerie. E noi siamo i nuovi, i primi. Tutto ricomincia. Tutto può essere di nuovo detto come se fosse la prima volta. Meraviglia del mito delle origini, il culto del primitivo, l’età dell’oro, le origini del mondo e l’umanità bambina che incomincia a camminare su due zampe. Sì, c’è qualcosa di molto affascinante e travolgente in tutto ciò.
Due rischi, però. Che nulla più esista del nostro passato, che nessuna tradizione sia riconosciuta, che neanche un briciolo di autorevolezza sia dovuta ai grandi prima di noi. La grandezza non esiste, non siamo debitori a nessuno. È possibile che ci prenda un’euforia da padreterni, ma anche un forte senso di smarrimento.
Il secondo rischio è che tutto ciò sia vero anche all’inverso, cioè se ci mettiamo noi dalla parte degli autori: nulla durerà di noi, nulla di quel che avremo detto, pensato, scritto sarà mai ricordato, per più di qualche mese, forse. Il problema non è che non saremo citati (riusciamo a superare qualche piccolo sgarbo alla nostra vanità), quel che disturba è la fastidiosa percezione di una forza che malgrado noi ci travolge. Tutti presi nella stessa corrente che porta via tutto in una sorta di oblio cosmico.
Oblio collettivo, molto democratico sì, ma oblio.
L’inutilità del singolo, di ogni suo operato. L’inutilità della storia stessa, dunque.
E siamo arrivati alla vanità del tutto.
Mi par di ricordare che qualcuno l’abbia detto prima di me…