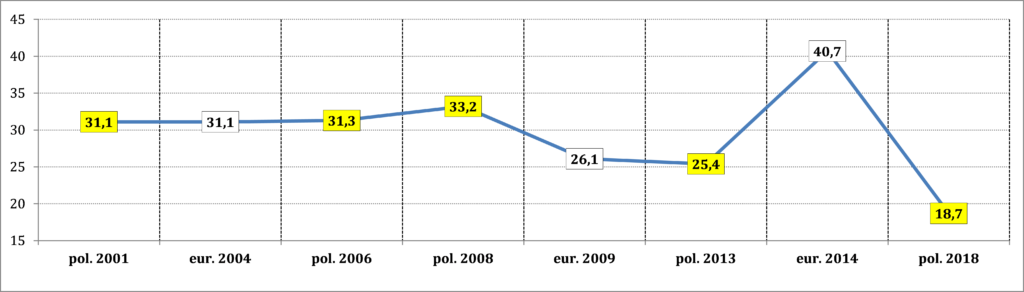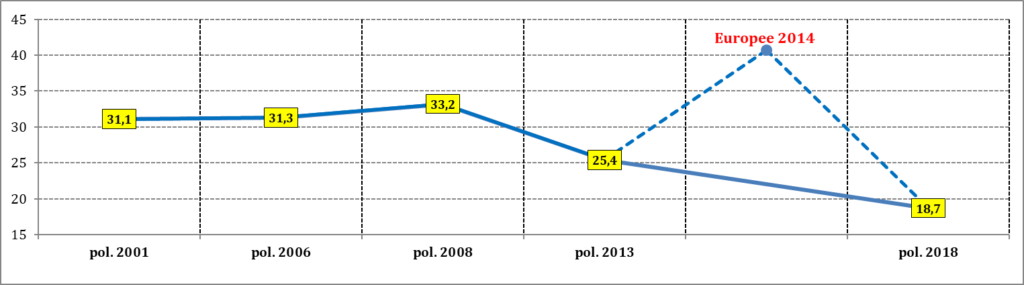Sondaggi, exit-polls e proiezioni: perché tanti errori
Ci risiamo. Come lo scorso anno alle politiche, come nelle precedenti amministrative, come (quasi) sempre in tutti i tipi di consultazione elettorale dell’ultimo decennio almeno, conoscere in anticipo le tendenze del voto degli italiani è una chimera.
La serata del 26 maggio scorso è parsa a tutti una riedizione dell’incubo dell’anno precedente. Exit-polls che non avevano nulla a che vedere con i risultati reali, come avremmo scoperto qualche ora dopo, solamente grazie ai costanti – ma comunque sempre lenti – aggiornamenti del sito Eligendo, del Viminale. Prime proiezioni che si allontanavano, poco alla volta, dai precedenti exit-polls, ma con stime che restavano ancora molto distanti, pur con qualche meritoria eccezione, dalle percentuali di voto che avremmo saputo solo alle prime ore del mattino seguente.
Passi per le televisioni private, Sky o La7, ma se il servizio pubblico della Rai, con i soldi dei contribuenti, mette in scena uno spettacolo politico-giornalistico basato sulle stime di voto, e queste stime sono del tutto erronee, ci troviamo a chiederci: perché dobbiamo buttare i nostri soldi in questo modo? Perchè non seguire invece l’evoluzione dello scrutinio reale dei voti fornitoci del Ministero degli Interni che, oltretutto, è molto più divertente.
Tanto da assomigliare quasi ad un campionato di calcio: dopo le prime giornate è in testa il Partito Democratico, tallonato dal Movimento 5 stelle; ma ecco che nel girone di ritorno torna a farsi avanti la Lega di Salvini, che domina le ultime 10 partite e arriva trionfante ad aggiudicarsi la prima piazza, con un distacco piuttosto sensibile sugli altri contendenti. Scudetto aggiudicato, mentre sono relegate in serie B +Europa e La sinistra, capitanate da Bonino e Fratoianni, che non raggiungono il quorum necessario per restare nella massima serie. Un divertimento puro, anziché la rabbia di non capire se stiamo assistendo a reali anticipazioni di ciò che poi accadrà davvero, oppure a semplici numeri casuali, con beneficio di inventario.
Ora, sappiamo ormai molto bene che le stime prodotte dai sondaggi sono abbastanza deboli, abbastanza aleatorie, sempre più difficilmente veritiere. L’ho scritto qualche settimana fa proprio su questo sito: dieci buone ragioni per cui non credere (troppo) ai sondaggi. In particolare quelli sulle stime sul voto, perché questo è sempre più volatile, meno ancorato all’appartenenza socio-politica (la fedeltà pesante), meno determinato dalla vicinanza ideologica tipico della fedeltà leggera (berlusconiani contro anti-berlusconiani) e sempre più pragmatico ed emozionale. Il tradimento non genera più sensi di colpa, nella vita come nelle urne. Si può fare tutto, come già profetizzava Giorgio Gaber 40 anni fa.
I sondaggi dovrebbero essere in grado di capire dunque, più dell’elettore, quello che lui ancora non sa, cioè per quale partito voterà, anticipando le sue scelte finali: un compito quasi impossibile. Ma se gli errori nei sondaggi sono comprensibili, entro certi limitati, quelli negli exit-polls certamente un po’ meno, soprattutto perché la scelta finale l’elettore l’ha appena fatta, e dunque l’incertezza precedente è stata già risolta. Qui i problemi da superare sono di tre tipi: la desiderabilità sociale, il numero di sedi-campione esiguo e il sistema di rilevazione.
La desiderabilità sociale, vale a dire la scarsa volontà di dichiarare un partito non troppo ben visto dall’opinione pubblica, antica distorsione dei tempi della Democrazia Cristiana o del Berlusconi in crisi, pare essere ormai superata quasi del tutto. Sdoganata ogni possibile scelta politica, non ci si “vergogna” più di nulla, nemmeno del voto per Casa Pound, in sospetto neo-fascismo. E dunque, trovarsi con exit-polls dove la Lega veniva data da tutti con una forchetta tra il 27 ed il 30 per cento, come hanno fatto praticamente tutti gli Istituti di ricerca, sotto-stimandola di una quota compresa tra i 4 e i 7 punti, è un deciso errore che andrebbe sanzionato. Così come le stime del M5s, sovra-stimato in egual misura.
Le cause potrebbero essere individuate nella scarsa numerosità dei punti di campionamento. Se intervisto gli elettori di sole 30-40 sedi di voto, è possibile che i miei risultati saranno ampiamente distorti. Meglio non effettuare nulla in quel caso. E se così si fa perché i committenti non danno abbastanza soldi, ancor meglio astenersi, indicando loro il numero minimo di interviste da effettuare all’uscita dei seggi, altrimenti si declina l’incarico. Ma così non si fa. Si prendono i graditi compensi, sbagliando nettamente le previsioni, tanto chi ci rimette è il cittadino; il ricordo dell’errore sfumerà qualche ora dopo, quando i risultati reali verranno diffusi dal Viminale.
Ultimo possibile errore, il sistema di rilevazione o il modello di stima che non funziona. E in questo caso, inutile sottolinearlo, quegli Istituti dovrebbero chiudere definitivamente i battenti, almeno in questo campo, dopo almeno 30 anni di exit-poll, in Italia e nel mondo.
Infine, le proiezioni. In questo caso, l’errore è quasi “impossibile”, se si hanno a disposizione un numero di sezioni-campione minimamente affidabile, poiché si tratta unicamente di rilevare, attraverso appunto questo campione di sezioni, ciò che è accaduto nella popolazione elettorale nel suo complesso. E a chiusura dei seggi, domenica 26 maggio, ci siamo trovati sul video tre stime del tutto differenti: la Lega, il cui risultato finale è stato come noto del 34,3%, veniva data al 27%, al 29% e al 31%, nelle prime proiezioni. Errori di stima tra il 7,3% e il 3,3%: inammissibile.
Gli Istituti di ricerca che si esibiscono in queste performance dovrebbero venir valutati sulla base della loro efficienza. Se si sbagliano in maniera a volte clamorosa le stime degli exit-polls e, soprattutto, quelle delle proiezioni, si dovrebbe essere squalificati, come con il cartellino rosso nel calcio, almeno per un turno. Ma questo non accade.
Perché? Molto semplice. Si vincono le gare grazie al ribasso dei costi, e questo inevitabilmente porta ad un abbassamento della numerosità campionaria e ad una minor capacità previsiva dei campioni utilizzati, troppo ridotti. Gli errori devono (e possono) venir contenuti, fin dalla prima proiezione, ad un massimo dell’1-1,5%, e non possono essere superiori allo 0,5-0,8% all’ultima proiezione. Ma da anni questa efficienza non si raggiunge più. E non si incorre in nessuna “sanzione”, se non quella economica, forse.
E’ una sorta di “spirale dell’inefficienza”: i committenti (e se sono pubblici è altamente riprovevole) spendono meno e danno un servizio pessimo, con un risparmio ulteriore se tagliano i compensi in caso di errore; gli Istituti risparmiano sui propri costi, fornendo un servizio inutile, ma rientrano delle proprie spese, con un parallelo investimento pubblicitario sostanzialmente gratuito. E così continuerà, se qualcuno non fermerà la macchina.