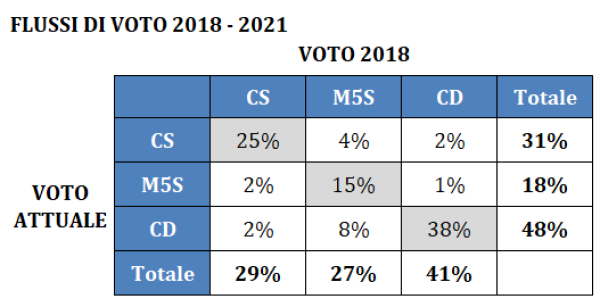Dieci buoni motivi per non credere (troppo) ai sondaggi – 2. Effetto desiderabilità sociale
La distorsione provocata dal ricercatore nel momento in cui si accosta al suo oggetto di studio viene sovente indicata con la formulazione proposta dallo psicologo americano Labov nel 1972, quella del cosiddetto paradosso dell’osservatore. L’obiettivo dell’osservatore è infatti quello di osservare un fenomeno così come esso si presenta nel momento in cui nessuno lo osserva: un evidente paradosso irrisolvibile. Appare dunque chiaro come il sapere sociale non potrà mai essere esente dalle alterazioni provocate dall’osservazione stessa, dalla presenza cioè del ricercatore, ovvero dell’intervistatore.
Il suo compito sarà dunque quello di sforzarsi di agire quasi in punta di piedi, silenziosamente, in modo tale da modificare il meno possibile l’oggetto della sua ricerca. Perché più il soggetto che si sta studiando è cosciente della presenza di chi lo studia, meno il suo comportamento o la sua dichiarazione di opinione risulterà libera dalle distorsioni provocate dal ricercatore. Se pensiamo ad esempio ad un qualsiasi “reality show” televisivo, comprendiamo molto chiaramente come chi sta davanti alle telecamere non si comporti esattamente come se fosse a casa sua, quando nessuno lo osserva.
Oppure ancora, se intervistiamo un hater della Rete, molto difficilmente otterremo delle risposte sincere sulle sue attività online; egli si adeguerà a fornire risposte che risultino accettabili dall’intervistatore, che è in quel momento una sorta di rappresentante della società nel suo complesso. È questo il classico tema della cosiddetta desiderabilità sociale.
Nelle interviste, per alcune domande particolarmente delicate (i cosiddetti “dati sensibili”, come le preferenze sessuali o lo stato di salute), gli strumenti “caldi” (dove è presente il fattore umano) provocano a volte distorsioni molto rilevanti nelle risposte. Più in generale la presenza di un intervistatore, al telefono e più ancora di persona, ha come effetto l’accentuazione di atteggiamenti condizionati dalla desiderabilità sociale: se viviamo in una società dove, ad esempio, la pena di morte è mal giudicata dalla collettività, sarà più difficile esternare il proprio accordo con questo tipo di condanna davanti ad un’altra persona, un po’ più facile rispondendo ad un questionario anonimo auto-compilato. Ma anche in questo caso, la distorsione rimane, benché a livelli più contenuti.
In una recente ricerca comparata, si sono poste alcune domande rispetto al comportamento abituale di un campione di cittadini, attraverso tre strumenti: un’intervista face-to-face, una telefonica e un questionario auto-compilato via web. Le risposte ottenute indicavano la presenza di un bias decrescente passando dagli strumenti più caldi a quelli più freddi. La quantità di ore quotidiane trascorse davanti alla TV, ad esempio, faceva registrare una media di 1,5 ore nell’intervista personale, di 2 ore in quella telefonica e di 3 ore nella web-survey. Il dato più oggettivo, certificato dall’Auditel, ci dice che la media degli italiani è pari invece a 4 ore al giorno. Evidente l’effetto della desiderabilità sociale: trascorrere molto tempo davanti allo schermo televisivo non è ben giudicato dalla società, e gli intervistati (consciamente o meno) si adattano nelle loro risposte a ciò che la società trasmette loro.
Paolo Natale
Estratto del volume “Sondaggi”, in uscita nel prossimo autunno presso Laterza