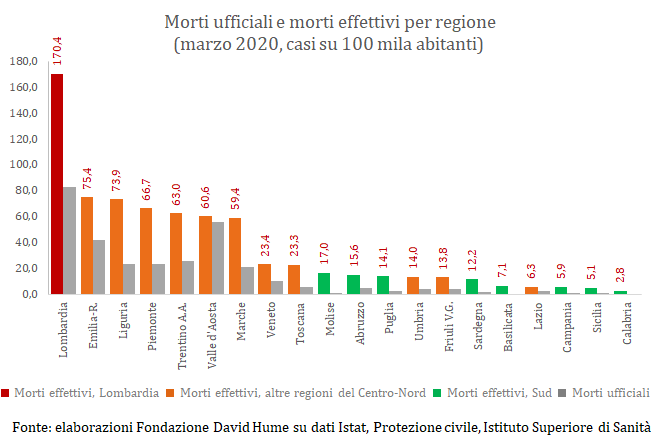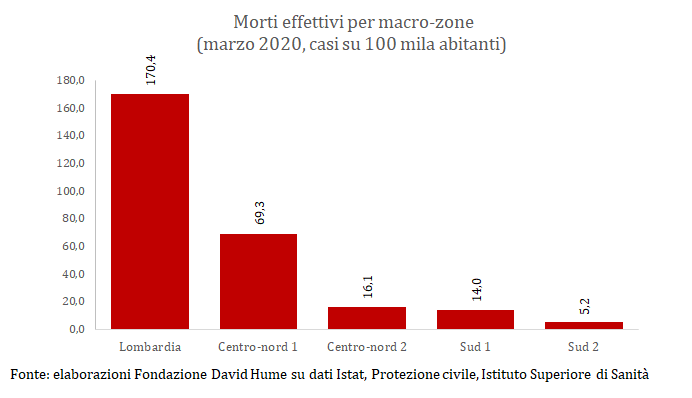Dieci anni di austerity? Qui si fa come l’Irlanda o si muore. Intervista a Luca Ricolfi con le considerazioni di una lettrice
Professor Ricolfi, la critica più diffusa al decreto Rilancio appena varato dal governo riguarda la natura essenzialmente assistenzialistica delle misure. Dei 55 miliardi messi in campo, c’è poco o nulla per far ripartire l’economia. L’ex ministro del Tesoro Giovanni Tria addirittura ha parlato di “investimenti zero”. Ma se l’economia non riparte, nei prossimi mesi l’Italia rischia davvero di essere il “malato d’Europa”. I mercati continueranno a risparmiarci o dobbiamo iniziare a temere?
Andando avanti sulla strada intrapresa, più che di “malato” d’Europa temo che dovremo parlare di “moribondo” d’Europa. Finché la caduta del Pil è “solo” del 10% e dall’anno dopo c’è una ripresa, sei solo malato. Ma se il Pil cade del 15-20% nel 2020, se nell’anno successivo non rimbalza perché la base produttiva si è ristretta, se la quota dell’export cala perché in questi mesi hai perso milioni di clienti, se il rapporto debito-Pil viaggia verso il 200% perché il denominatore è imploso, se lo spread vola perché i mercati pensano che non saremo in grado di restituire il debito, beh se tutto questo dovesse accadere allora questo non è essere malati, mi sembra.
Questo vorrebbe dire tornare indietro di mezzo secolo, prendere commiato da tutto quello che eravamo bene o male riusciti a costruire dopo la seconda guerra mondiale. Individualmente sopravviveremo quasi tutti, si spera, ma assisteremo alla progressiva demolizione del nostro mondo sociale: la società signorile di massa si inabisserà, come l’isola di Atlantide.
C’è il rischio che Germania, Olanda e falchi del Nord tornino a chiedere austerity?
Chiamarlo “rischio” è da inguaribili ottimisti, io parlerei di certezza. Il patto di stabilità è solo sospeso, e possiamo star sicuri che nel 2021 l’Europa non ci consentirà di indebitarci con l’allegria che ora contagia il ceto di governo. E anche ce lo consentisse, nulla potrà evitare che a metterci in riga ci pensino i mercati. Già oggi lo spread è 100 punti sopra il livello pre-Covid.
Da queste pagine ha lanciato l’allarme: l’Italia post-Covid rischia di diventare una società parassita di massa, popolata da tanti non-produttori che vivranno in condizioni di dipendenza dall’assistenzialismo statale. Cerchiamo di fare un passo avanti. Come evitare di arrivare a uno scenario così terribile?
Prima di rispondere, vorrei fare una precisazione. Quando dico che i nostri governanti stanno più o meno intenzionalmente pianificando il passaggio a una società parassita di massa non ho in mente uno scenario in cui il 70% degli italiani se la spassa vivendo alle spalle del 30% che produce. Quel che ho in mente è semmai una situazione in cui la torta del Pil è così ristretta da trasformare i parassiti-signori di ieri nei parassiti-sudditi di domani. Detto brutalmente: gli assistiti non se la passeranno per niente bene. Non a caso ho evocato, giusto per dare un’idea, la Grecia e Cuba: sudditi come a Cuba, poveri come in Grecia.
Detto questo, torno alla domanda, come evitare di arrivare lì. Non so se siamo ancora in tempo, ma io vedo una sola possibilità: cambiare tutto, naturalmente cominciando dalla testa, governo e filosofia di governo.
Che significa cambiare tutto?
Dovessi riassumere con una formula, direi: provare a trasformare l’Italia da inferno burocratico a paradiso imprenditoriale. Una sorta di Irlanda mediterranea, dove chiunque voglia intraprendere un’attività economica può farlo senza ostacoli non necessari.
In concreto vuol dire essenzialmente tre cose.
La prima: renderci un paese normale quanto a burocrazia, eliminando la “presunzione di furbizia” che è ubiqua nella nostra legislazione, dal codice degli appalti alle infinite norme e procedure che asfissiano i produttori.
La seconda: un taglio drastico, immediato, e almeno triennale delle tasse.
La terza: saldare entro 30 giorni tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni verso il settore privato, senza andirivieni bancari e fra enti pubblici. E’ incredibile che lo Stato faccia moral suasion sulle banche perché aiutino i produttori a indebitarsi, e non pensi che molte imprese devono indebitarsi precisamente perché lo Stato non paga i suoi debiti.
Entriamo più nello specifico sul taglio delle tasse. Meglio fare un’operazione di riduzione su imprese e autonomi o sul lavoro dipendente?
In tema di riduzioni fiscali la tendenza del ceto politico, di destra e di sinistra, è sempre stata (fin dal “Contratto con gli italiani” di Berlusconi) di puntare su riduzioni, anche molto modeste, che potessero toccare il maggior numero di beneficiari: Irpef, Iva, Imu, contributi sociali. Molta meno attenzione è stata riservata alle tasse che scoraggiano l’attività produttiva, ovvero Irap e Ires. E invece è da lì che si dovrebbe partire, anche puntando su benefici selettivi e concentrati, che privilegino le imprese che aumentano l’occupazione e, in questo momento, le imprese che rinunciano alla comoda strada di mettere in cassa integrazione i loro dipendenti.
Dico questo perché me lo suggeriscono i miei studi sulle determinanti della crescita in Occidente (è il tema del mio libro L’enigma della crescita), ma lo dico anche perché sono in contatto con tante persone che hanno un’attività, dal commerciante, al gestore di pizzeria, alla fisioterapista, fino al viticoltore. E da loro so che la decisione che devono prendere è drammatica: chiudere, o riaprire e scommettere sul futuro.
E che cosa le dicono?
Quasi tutti, specie se sono over 50 e sono in grado di sopravvivere decentemente senza lavorare, si chiedono: ma in queste condizioni, con nuovi costi, nuovi rischi (anche penali), e a voracità fiscale invariata, chi me lo fa fare?
La decisione di riaprire dipende poco dagli aiuti momentanei e limitati che possono ricevere in questo momento, e molto – moltissimo – dalle condizioni in cui dovranno operare nei prossimi mesi e anni. Queste condizioni includono aumenti certi dei costi, una fiscalità futura di entità sconosciuta, un rischio serio di guai giudiziari legati al rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Lei lo ha letto il protocollo?
Dalla prima riga all’ultima, e ne sono rimasto sconcertato, per la farraginosità (e spesso inapplicabilità) delle norme che detta. Soprattutto sono rimasto sorpreso nel constatare che il protocollo è chiaramente pensato per la grande impresa, ma non è sottoscritto solo dai sindacati confederali e da Confindustria, bensì anche da una dozzina di associazioni professionali e datoriali più piccole, che paiono del tutto ignare dei problemi concreti dei loro associati. Come sociologo, sono colpito dal fatto che, anche nel mondo della produzione, si sia ormai verificato ciò che da tempo accade in posti come l’Università, o la sanità pubblica. Le regole dell’Università non le pensano gli studiosi, ma i manager-burocrati che la governano. Le regole della sanità non le fanno medici e infermieri, ma le fa l’immenso apparato amministrativo che se ne è impossessato.
Credo che nessun artigiano, commerciante o piccolo imprenditore in carne e ossa avrebbe firmato un protocollo come quello concordato dai vertici delle loro associazioni.
Ma torniamo alla riduzione delle tasse. Un’operazione di grossa riduzione fiscale è certamente auspicabile ma rischia di scontrarsi con la realtà dei conti pubblici. Se mettiamo assieme i soldi stanziati dal decreto Cura Italia e da quello Rilancio, vediamo che sono stati già spesi 80 miliardi solo per misure di sostegno sociale. E questo porterà il debito/pil a un rapporto che sfiora il 160%. Non le sembra che le cartucce ce le siamo già sparate tutte?
Su questo ha ragioni da vendere l’ex ministro Tria, che per primo ha sollevato questa preoccupazione, ovvero che largheggiando ora il governo si trovi a stecchetto quest’autunno, quando dovrà varare la finanziaria. Ma il punto cruciale a me sembra più a monte, e riguarda come gestire l’aumento del debito pubblico, che ci sarà comunque, sia che si segua la via iper-assistenziale che piace a questo governo, sia che si imbocchi la via di un taglio immediato e consistente del carico fiscale sui produttori. Quell’aumento del debito risveglierà le autorità europee, e soprattutto risveglierà i mercati. Lo spread tenderà a salire, e noi dovremo trovare un modo di convincere i mercati e le istituzioni sovranazionali a comprare e ricomprare il nostro debito. Ebbene, a quel punto avremo solo due vie.
La prima: anni e anni di austerità vera (non la pseudo-austerità di questi anni, che è esistita solo nella propaganda anti-europea), in una spirale di contrazione della base produttiva → contrazione della base imponibile → tagli alla spesa pubblica → aumenti delle aliquote → imposte patrimoniali di scopo.
La seconda: crescere a un ritmo tale (almeno il 3% all’anno per diversi anni) da rassicurare i mercati sulla sostenibilità del nostro debito. Dico questo anche perché, come fondazione Hume, da anni ci occupiamo delle determinanti dello spread, e una cosa gliela posso dire senza esitazione: nell’equazione dello spread il deficit annuale non entra, mentre hanno un ruolo importante (di contenimento) le prospettive di crescita di un paese. Se cresci, questa mera circostanza calmiera lo spread. Ma bisogna convincersi che crescere molto di più di oggi è la nostra unica possibilità, se non vogliamo beccarci dieci anni di austerità. Chi obietta che non ci sono le “risorse” per alleggerire la pressione fiscale sui produttori dovrebbe rispondere a questa domanda: quanto ci costa, in termini di erosione della base imponibile (e quindi del gettito), il fallimento di migliaia e migliaia di imprese che, con questa pressione fiscale, non riescono a restare sul mercato?
Dunque lei è contrario all’austerità?
Io sono sempre stato a favore di quella che Veronica De Romanis chiama l’austerità buona: mettere a posto i conti pubblici riducendo la spesa corrente e abbassando le tasse sui produttori. Poteva funzionare, e lo avessimo fatto a tempo debito – anziché invocare flessibilità ad ogni pie’ sospinto – ora saremmo messi meno male di come siamo. Ma adesso la situazione è completamente cambiata, ed è paradossale.
Noi rischiamo di essere commissariati dall’Europa, o dal Fondo Monetario, o da qualche altro organismo sovra-nazionale, perché fra pochi mesi apparirà a tutti che lo Stato si sta indebitando troppo, il Pil non dà segni di ripresa, e la base imponibile si assottiglia, aggravando il bilancio pubblico. Ci chiederanno di agire sul numeratore, ovvero sul debito, perché “è nella loro natura”, come recita la fiaba dello scorpione e della rana: la tecnoburocrazia che governa il mondo ha una visione ragionieristica dei conti pubblici. A quel punto il paradosso prenderà forma: l’Italia perderà la sua sovranità perché nel momento più difficile il caso ha voluto che il governo fosse in mano ai sovranisti, o meglio alla variante più anti-crescita del sovranismo, quella dell’assistenzialismo pentastellato.
Ma possiamo evitare tutto ciò?
Probabilmente no, a questo punto, troppo grande è il danno che si è già fatto. Ma se uno spiraglio è dato intravedere, è quello di ribaltare tutto: indebitiamoci, ma facciamolo in modo da salvare le attività che possono farcela, e di rendere profittevole crearne di nuove. Affinché la schumpeteriana “distruzione creatrice”, che ci sarà comunque, sia più creatrice di nuove attività e meno distruttrice di vecchie.
Lei parla anche di semplificazioni e sburocratizzazione. Negli ultimi anni i governi che si sono succeduti mi sembra siano andati nel verso opposto: più controlli e documenti per evitare corruzione e infiltrazioni criminali. Il Covid farà cambiare idea a una maggioranza il cui partito più grande – M5s – ha nel Dna una carica ultra-legalitaria?
Qui mi sento di attenuare le responsabilità dei Cinque Stelle. Avere i Cinque Stelle al governo si limita a peggiorare la situazione, perché stimola la iper-produzione di norme dannose per l’economia, ma non è il vero problema. Anche ci fosse Einaudi al governo, non ce la farebbe, in pochi mesi, a smontare il cancro burocratico che sta uccidendo l’Italia. Il vero problema è che chiunque provi a semplificare la burocrazia, tende a farlo creando nuove norme, anziché disboscando l’esistente.
Da questo punto di vista il fatto che Conte annunci un “decreto semplificazioni” semplicemente mi terrorizza. Lo smantellamento del mostro burocratico e la riforma della giustizia civile richiederebbero almeno 4 o 5 anni di lavoro anche al più serio e ben intenzionato dei governi. Nel breve periodo, l’unica strada percorribile a me pare quella di prevedere, ovunque sia possibile e ragionevole, norme transitorie che scavalchino e sospendano tutte le altre, come si è fatto con il ponte di Genova, e come si potrebbe fare in molti altri casi.
Non hanno esitato a toglierci le nostre libertà più preziose, possibile che l’unica cosa intoccabile sia la giungla degli adempimenti e delle procedure che stanno strangolando l’Italia?
Intervista rilasciata all’Huffington Post il 17 maggio 2020
Considerazioni di una lettrice
Buonasera professore.
Ho letto una Sua interessante intervista in cui esprime preoccupazione per il momento attuale. Io come tanti italiani – Lombardi in particolare – ho con mio marito una azienda familiare che esiste (non senza fatica) da 80 anni … tre generazioni, ma di questo passo non credo proprio che arriverà alla quarta.
Ci sotterrano sotto montagne di provvedimenti inutili, tasse, gabelle e altri balzelli che servono solo a mantenere privilegi per una classe politica inefficace.
Ci rendiamo conto che dobbiamo versare in tasse praticamente i 3/4 di ciò che produciamo?
Di questo passo NESSUNO FARÀ PIÙ IMPRESA.
Diventeremo un popolo di “ mantenuti?”… CERTAMENTE tutti! Loro elargiscono sussidi con i soldi che succhiano ai piccoli imprenditori e artigiani … ma quando noi chiuderemo tutti… come pensano di pagare i sussidi e gli stipendi dei milioni di dipendenti pubblici ed in primo luogo i loro?
Non abbiamo più nemmeno la forza di lamentarci. Questa è la cosa più grave… ci siamo arresi. L’Italia così finirà male.
Saremmo un popolo eccezionale (con qualche furbo, certamente e qualche delinquente che froda il fisco… dovrebbero accanirsi su quelli e non su chi lavora duramente).
Ci vorrebbero più menti come la Sua.
Lettera firmata