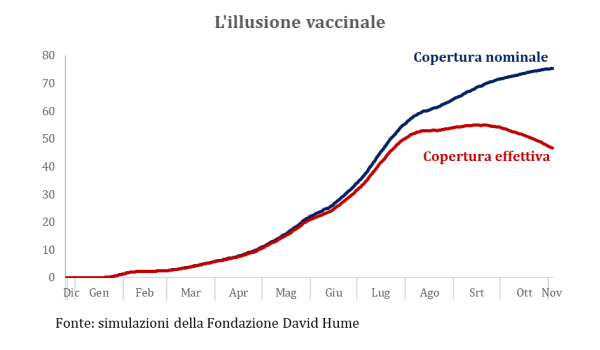Quant’è difficile parlare di vaccini con libertà. Intervista a Luca Ricolfi
Professore, perché stampa e talk show sul Covid sembrano prigionieri di una logica da «curva»? Inscenando lo scontro tra opposti estremismi – vaccino «sola salus» contro no vax per principio – non ci si preclude la possibilità di una discussione seria e informata?
La possibilità di una “discussione seria” non interessa granché neppure i cosiddetti scienziati, troppo spesso prede di faziosità (e di conflitti di interesse), figuriamoci la grande stampa e i talk show. La realtà è che tutta la comunicazione pubblica risente del clima di guerra che si è instaurato dopo l’arrivo del vaccino. E in guerra chi solleva dubbi è trattato come un disertore.
Lo scontro, comunque, non è simmetrico: c’è una posizione, quella di totale adesione alle scelte del governo, che ha dalla sua una sorta di «bollinatura». È per questo che, dall’altro lato, si sovrarappresentano le voci più grottesche, dai negazionisti ai complottisti del vaccino? Insomma, si dà l’impressione che l’unica alternativa all’agenda governativa sia un coacervo di tesi deliranti…
E’ una precisa strategia, specie nei talk show. I paladini della campagna vaccinale vengono selezionati fra gli studiosi autorevoli, o comunque insediati in posizioni apicale del sistema sanitario, e per ciò stesso guardati con rispetto. Per quanto riguarda gli “infedeli” si alternano tre tecniche principali: non dar loro la parola; invitare solo i personaggi da operetta; farli parlare, ma affiancati da personaggi che li interrompono continuamente, insultando e screditando.
Al contrario, gli elementi che potrebbero incrinare la narrativa dominante e che provengono da fonti qualificate sono prontamente minimizzati. Il caso più recente mi sembra il tentativo di liquidare l’inchiesta del British medical journal sulle gravi lacune in uno dei trial di Pfizer. Questo atteggiamento non rischia di privarci di elementi di riflessione importanti?
Certo, questo atteggiamento priva il pubblico di informazioni cui avrebbe diritto ad accedere. Con la complicazione che il pubblico rischia di trovarle lo stesso (su internet), senza però essere in grado di soppesarle. Però…
Forse la deluderò, ma voglio provare a fare l’avvocato del diavolo dei grandi media, giusto per mettere a fuoco un meccanismo (e un problema). Supponiamo che la stampa e le tv non stendessero il velo pietoso che sono solite stendere sulle numerose controindicazioni della campagna vaccinale, a partire da quelle sulla vaccinazione di massa dei bambini: lei pensa che avremmo la medesima copertura? Crede davvero che il generale Figliuolo sarebbe riuscito a superare l’80% di vaccinati?
Se lei fosse convinto (come molti) che senza un’altissima copertura vaccinale avremmo decine di migliaia di morti in più, non sentirebbe la pressione a censurare le informazioni che disincentivano la vaccinazione? Forse è anche questa convinzione che induce una parte dei media a rinunciare alla completezza e imparzialità dell’informazione, che pure dovrebbero essere imperativi categorici della professione di giornalista.
In suo articolo sul sito della Fondazione Hume, lei ha deplorato il modo in cui è stata frettolosamente accantonata un’ipotesi, discussa in seno alla comunità scientifica, sulla possibilità che la vaccinazione di massa favorisca la selezione di varianti più resistenti del virus. Un altro tabù pericoloso?
Più che deplorarlo, ho messo in evidenza questa ed altre omissioni, alcune innocue (frutto di pura sciatteria), altre influenti e presumibilmente intenzionali. Quello che mi dà fastidio è il paternalismo di questo modo di fare informazione: si assume che noi popolo-bue non capiremmo, ci spaventeremmo, e agiremmo in modo sconsiderato. A me invece piace credere che le persone vadano aiutate a vagliare le informazioni, e a prendere decisioni difficili. Qualche volta tragiche.
Tragiche?
La decisione di una madre che vaccina un bambino di 6 anni è tragica, come quella di Antigone: proteggere il figlio, o proteggere la città?
È apparentemente impossibile, a livello mediatico, separare il giudizio sul vaccino e quello sul green pass. Indipendentemente da come la si pensi sulla tessera verde, perché non si possono avanzare obiezioni al passaporto Covid senza essere accusati, se non di essere dei no vax, di servire assist alle tesi di questi ultimi?
Per il solito motivo: si ritiene che se si critica il green pass si finisce per indebolire la campagna vaccinale. Ma potrebbe esserci anche un altro motivo…
Quale?
Che il governo abbia il problema di trovare un capro espiatorio in caso di fallimento della campagna vaccinale: e i critici del green pass sono “un colpevole quasi perfetto”, come l’uomo bianco nel bel libro di Pascal Bruckner.
Lei non crede che i no-pass siano la causa dell’attuale esplosione dei contagi?
Sono una concausa. E forse nemmeno la più importante. Lei lo sa che l’epidemia galoppa, con un Rt preoccupante, anche nei paesi che hanno vaccinato quasi tutti, come ad esempio il Portogallo, che ha una copertura del 98%?
E allora qual è la causa principale?
Il “generale inverno”, e la scelta del governo di non contrastarlo con la messa in sicurezza degli ambienti chiusi, a partire da aule scolastiche e metropolitane. Avessero dato retta ai sostenitori della ventilazione meccanica controllata nelle scuole (studiosi, medici, ingegneri e, fra i partiti, ahimè solo Fratelli d’Italia) forse non saremmo a questo punto. Dico “forse” perché l’impatto protettivo dei filtri Hepa e della Vmc (ventilazione meccanica controllata) nessuno lo conosce ancora con esattezza.
Anche sulla vaccinazione dei bambini si è determinata una curiosa coincidenza: ora che si vuole spingere su questo fronte, dei piccoli, finora descritti come sostanzialmente al riparo dalla malattia grave, si è iniziato a dire che finiscono in terapia intensiva, che sviluppano il long Covid e che sono «untori» per i nonni, peraltro già vaccinati. È ancora legittimo esprimere dubbi sul programma di iniezioni sui bambini?
Lo sarà ancora per qualche giorno, approfittando del fatto che gli esperti sono divisi, poi non più. La libertà di parola finisce quando, nel mondo della cosiddetta scienza, la politica riesce a far emergere una posizione nettamente dominante, che mette fuori gioco tutte le altre.
La comunicazione scientifica è stata caratterizzata da una quantità spropositata di giravolte. Più si va indietro, più si trovano casi clamorosi: ad esempio, gli esperti che snobbavano la mascherina sono gli stessi che dopo l’hanno santificata. Cambiare idea può essere il risultato di un avanzamento nelle conoscenze, ma allora perché ogni affermazione dei tecnici ci viene presentata in modo apodittico? Con questo metodo, alla fine, i progressi appaiono, invece, come delle contraddizioni.
E’ esattamente così. La scienza dice di coltivare il dubbio e la discussione critica, ma questo avviene solo finché il dubbio e la discussione critica non urtano contro interessi economici o politici soverchianti. Quando questo accade, il dubbio si può esprimere solo a condizione che gli utenti che possono accedervi siano pochi, come nei giornali a bassa tiratura e nelle riviste. E’ una delle cose che mi ha insegnato Piero Ostellino, il padre spirituale della Fondazione Hume.
E poi ci sono i toni trionfalistici, seguiti da altrettante inversioni a U nella narrativa. Gli stessi vaccini, fino a pochi mesi fa, ci venivano presentati come l’unica via d’uscita dalla pandemia (con un’aperta sottovalutazione del ruolo delle terapie), come la sola salvezza che ci avrebbe riconsegnato la libertà. Adesso, il vento è cambiato: la protezione cala, serve un’altra dose, ma poi vi promettiamo che basterà così, tornerà veramente la libertà. Ecco, questo approccio alla comunicazione non è controproducente? È proprio questo il modo di fornire un assist ai no vax – e poi ci si ritrova a dover «convincere» gli indecisi con un obbligo vaccinale surrettizio…
E’ la conseguenza della sfiducia nella gente. Pensano che noi non capiremmo, se ci dicessero tutto.
Franco Locatelli, alcuni giorni fa, in conferenza stampa ha affermato che non ci sono under 59 vaccinati in terapia intensiva. Sono gli stessi dati Iss a smentirlo. È lecito, o almeno utile, rimaneggiare un po’ i numeri a scopi persuasivi? Non è sempre meglio essere precisi e dire la verità? Anche perché bastano i numeri reali a dimostrare l’efficacia dei vaccini…
Sì, ma è anche colpa della stampa e dei media, che sulle bugie dei potenti raramente hanno il coraggio di chiedere dimissioni che in altri paesi sarebbero scontate.
È indubbio che le vaccinazioni – e, auspicabilmente, questo effetto sarà consolidato dai richiami sulle fasce di popolazione più a rischio – abbiano mitigato enormemente l’impatto del Covid su ricoveri e decessi. Ma in questo contesto, ha senso tenere in piedi lo stato d’emergenza? Se i vaccini funzionano, perché ogni «ondata» viene accompagnata da una massiccia offensiva «terroristica» sui canali d’informazione, e si tiene in piedi anche sul piano giuridico una sorta di regime speciale? Non sarebbero opportuni un approccio più sobrio e un’uscita anche de iure dalla logica emergenziale?
Su questo sono completamente d’accordo con lei (e con Cacciari!). Non possono continuare a dirci che dovremo convivere con il virus, che i vaccini ci consentiranno di farlo, e poi mantenere ad oltranza lo stato di emergenza. O meglio: possono anche farlo, ma allora ci dicano quali sono le soglie di morti-ricoverati-infetti-Rt al di sotto delle quali “lorsignori” si degneranno di rinunciare ai poteri speciali.