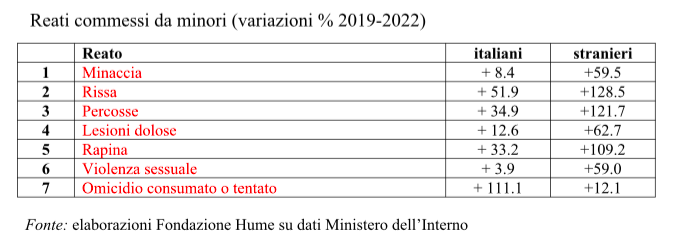Migranti, l’esperimento Albania
Difficile, dopo lo scontro in Albania fra Giorgia Meloni e il segretario di +Europa, discutere di migranti in modo pacato, senza troppa ideologia. Eppure dobbiamo farlo, se non vogliamo che questo problema, nei prossimi anni, finisca per concentrare su di
sé tutta l’attenzione della politica, a scapito dei tanti problemi che affliggono il paese, dai bassi salari alle liste di attesa in ospedale, dai morti sul lavoro alla mancanza di asili nido, dal declino della scuola al modesto tasso di occupazione delle donne.
Intanto, vale forse la pena sottolineare che quello dei migranti è un problema irrisolto non solo sul versante dell’immigrazione irregolare, ma anche su quello dei flussi regolari. È di pochi giorni fa la scoperta di enormi squilibri, specie in alcune regioni
del Sud, fra il numero di contratti di lavoro nominali (connessi ai decreti flussi) e il numero di posti di lavoro effettivamente attivati. Tutto fa pensare che anche i flussi regolari nascondano un ingente traffico di falsi contratti di lavoro, verosimilmente
gestiti dalla criminalità organizzata. Forse è venuto il momento di chiedersi se, oltre a intensificare i controlli, non sia il caso – dopo oltre vent’anni – di porre mano alla legge Bossi-Fini, che come si sa si fonda sulla finzione che il lavoratore che emigra
abbia già – in Italia – un datore di lavoro che lo attende.
Se dai flussi regolari ci volgiamo a quelli irregolari, e in particolare agli sbarchi sulle nostre coste, il dato che non possiamo ignorare è che nessuna fra le politiche adottate fin qui dall’Italia è stata capace di risolvere il problema. Fermare le partenze nei paesi di origine, una politica perseguita in epoche diverse da Berlusconi e da Minniti, si scontra con la instabilità dei governi che dovrebbero bloccare i flussi all’origine, ma anche con la difficoltà di neutralizzare i trafficanti e garantire il rispetto dei diritti
umani nei paesi di partenza. Ma non meno problematica è l’altra linea di condotta, per lo più sponsorizzata dalla sinistra e dai vertici dell’Unione Europea, e che punta sulla cosiddetta redistribuzione (di fatto: dall’Italia agli altri paesi). Contrariamente a
quanto si sente spesso lamentare, quel tipo di politica non è fallita solo per un deficit di solidarietà, imputabile anzitutto all’Ungheria del “cattivo” Orban, ma perché il meccanismo della redistribuzione è intrinsecamente poco efficace, dal momento che non è obbligatorio, e comunque coinvolge solo una modestissima frazione degli sbarcati.
Rispetto a queste due strategie classiche – fermare alla partenza e redistribuire – l’accordo con l’Albania si presenta come un terzo modello di gestione dei flussi irregolari. L’idea è di deviare una parte dei soccorsi in mare verso un paese extra-Ue,
e di espletare lì le pratiche di identificazione e valutazione della domanda di asilo. I vantaggi, rispetto ai due modelli storici, sono principalmente due: primo, si evita la dispersione sul territorio italiano di migranti irregolari, che non hanno diritto all’asilo
e rischiano di entrare in circuiti illegali; secondo, si introduce (o si spera di introdurre) un elemento di deterrenza e freno alle partenze.
Solo il tempo potrà dirci se il modello Albania funzionerà, se i benefici per l’Italia supereranno i costi, e se i diritti dei migranti saranno adeguatamente tutelati. Nel frattempo, è forse il caso di prendere atto che ben 14 paesi dell’Unione europea hanno manifestato interesse per l’idea di coinvolgere paesi extra-Ue, come l’Albania, nella gestione dei flussi migratori. Può darsi che questo inatteso interesse per il modello italiano sia strumentale, ossia dettato da ragioni elettorali: alla vigilia del voto europeo tutti i partiti, che siano al governo o siano all’opposizione, hanno bisogno di dire all’opinione pubblica che non hanno rimosso il problema dell’immigrazione.
Resta il fatto che, sul tema degli ingressi irregolari in Europa, le alternative in campo o sono troppo radicali, come le deportazioni in Ruanda ventilate tempo fa dalla Danimarca, o sono troppo blande, come la mera riproposizione dei recenti, traballanti, accordi di redistribuzione.
In breve, il modello Albania è l’unica idea nuova in campo. Ma più che un’idea, è un esperimento, che subirà molti aggiustamenti, e di cui per ora nessuno è in grado di prevedere accuratamente l’esito. Ecco perché, schierarsi a priori a favore o contro, è irrazionale: di fronte agli esperimenti, l’unico atteggiamento razionale è la curiosità.
[articolo uscito sul Messaggero il 7 giugno 2024]