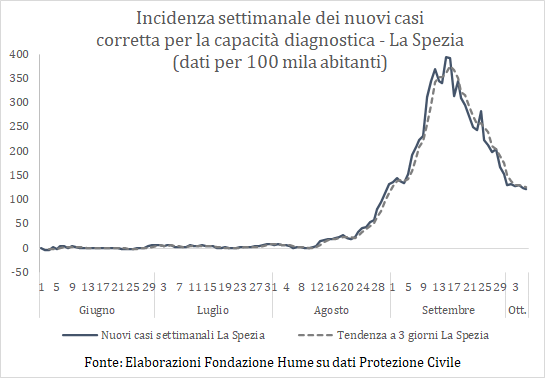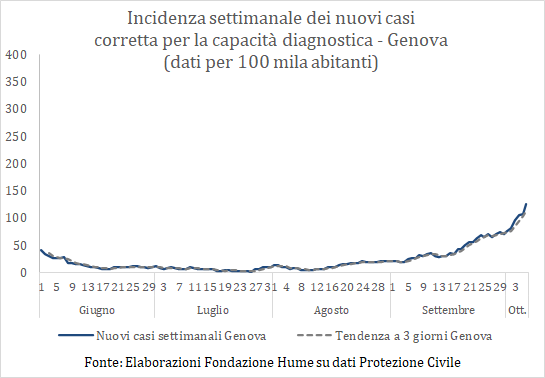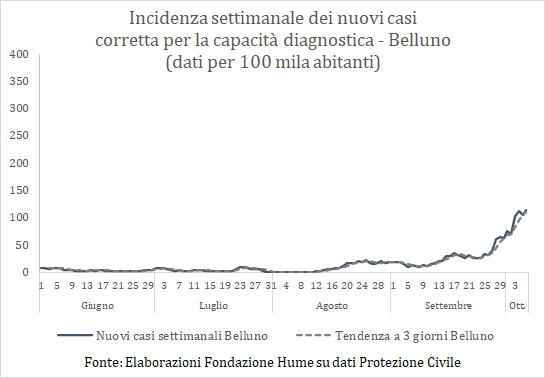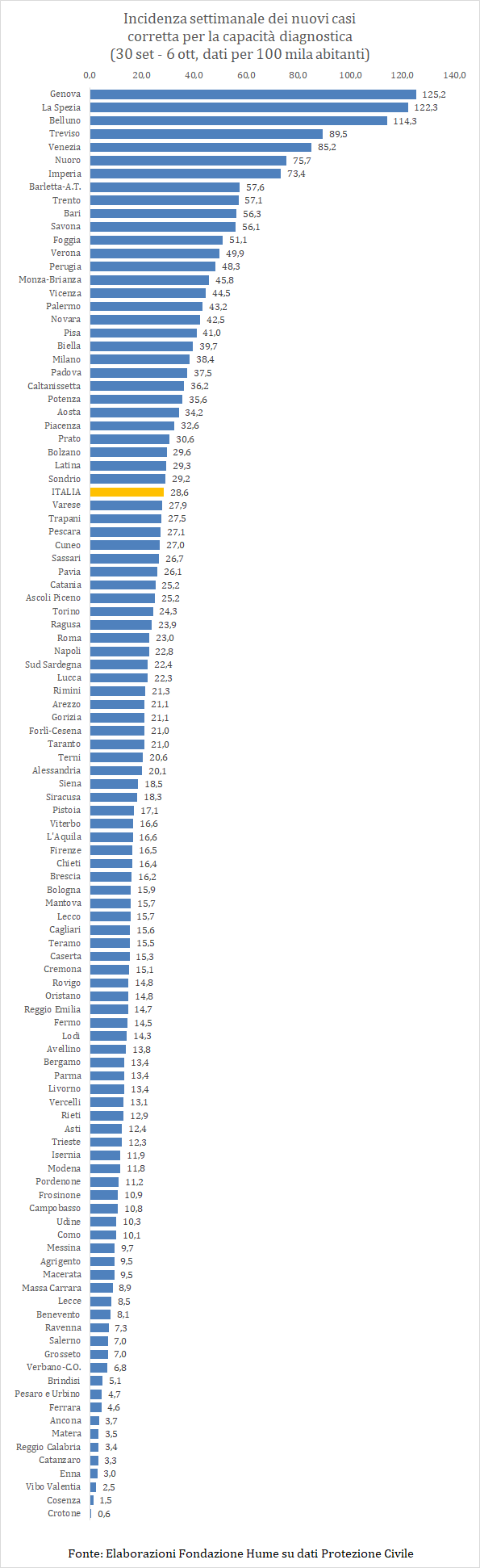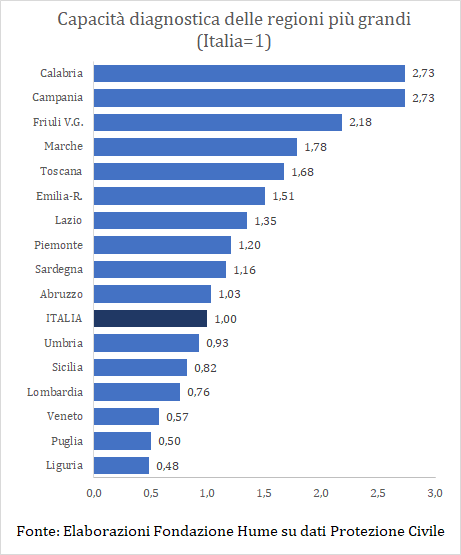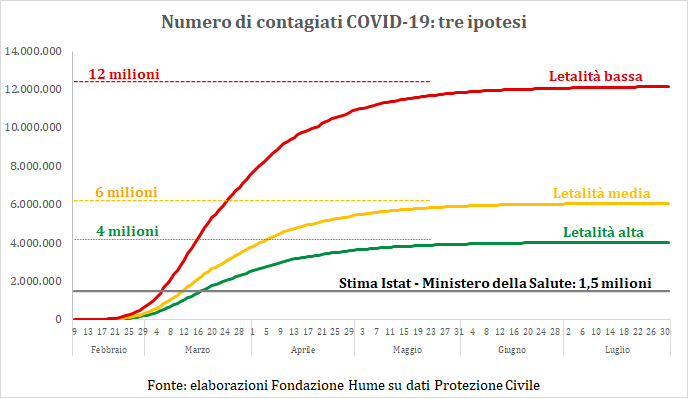Capisco che sentirsi seduti sopra una montagna di euro sia inebriante. E’ la sensazione che doveva provare lo zio Paperone quando si tuffava fra le monete del suo deposito. E dev’essere la sensazione che provano i nostri governanti quando parlano dei 209 miliardi in arrivo dall’Europa.
Ci sono due importanti differenze, tuttavia. I soldi che arriveranno in Italia non saranno dollari, bensì euro. Ma soprattutto: lo zio Paperone sedeva su soldi propri, perché li aveva guadagnati. Invece i nostri governanti si accingono a sedersi su soldi altrui, che dovranno essere restituiti.
Qualcuno potrebbe obiettare: una parte dei soldi che attendiamo dall’Europa, più di 80 miliardi, sono a fondo perduto. Ma è un’illusione. Chi ha provato a fare i conti, come l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, avverte che, dal momento che l’Italia è contributore netto al bilancio europeo, il beneficio effettivo per il nostro paese potrebbe aggirarsi sui 46 miliardi. Che sono meno della metà del nuovo debito che il Governo ha contratto con i tre scostamenti di bilancio approvati durante il primo semestre, e circa un terzo dell’incremento del debito pubblico intervenuto in appena 5 mesi, da febbraio a luglio di quest’anno.
In poche parole: i soldi “veri” (diversi dai prestiti) che prima o poi arriveranno dall’Europa non bastano nemmeno a ripianare il debito aggiuntivo (più di 100 miliardi) che abbiamo già accumulato nella prima parte dell’anno. L’occasione meravigliosa e “senza precedenti” che l’Europa ci offre è di aggiungere ai debiti già contratti nei mesi scorsi altri 130 miliardi di ulteriori debiti, destinati a diventare quasi 170 se ci decideremo a ricorrere anche al MES.
E’ in questa situazione che, da qualche giorno, è partito l’assalto alla diligenza delle “risorse” in arrivo dall’Europa. Centinaia e centinaia di progetti si contendono l’accesso ai nuovi fondi, come se si trattasse solo di decidere che cosa è importante per il nostro futuro. Parole fumose e astratte si inseguono nella speranza di incontrare la comprensione e la benevolenza delle autorità europee cui spetta approvare i nostri progetti di spesa: digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica, rivoluzione verde, infrastrutture, istruzione, formazione, equità, inclusione sociale.
Quel che resta del tutto in ombra è il punto decisivo: a conti fatti la manna che arriverà dal cielo europeo è fatta solo di prestiti, e i prestiti andranno restituiti. Il che significa: il problema non è di spendere in cose che riteniamo utili al paese (su questo ognuno ha ovviamente le sue idee), il problema è di far sì che, alla fine, ogni euro speso generi più di un euro di nuovo Pil. Solo così potremo rimborsare domani i prestiti che ci vengono erogati oggi.
E’ questo che i vari piani e progetti dovrebbero essere in grado di garantire, o perlomeno rendere verosimile. E non è affatto un requisito facile. La spesa pubblica corrente di norma distrugge più risorse di quante ne crei, e gli investimenti stessi non sempre sono in grado di far crescere il Pil più di quanto costino. Molto dipende dai settori in cui si investe, dalla qualità dei piani, dai manager chiamati ad attuarli, ma ancor più da un fattore che troppo spesso trascuriamo: l’ambiente economico e istituzionale in cui l’investimento avviene. Se la burocrazia soffoca l’iniziativa privata, la giustizia civile non funziona, il mercato del lavoro è ingessato, il fisco asfissia i produttori, anche i migliori investimenti e i migliori stimoli all’economia rischiano di generare benefici modesti, o addirittura nessun beneficio netto.
Perché la politica non si pone il problema della restituzione del debito? Perché si parla e si ragiona come se i prestiti fossero finanziamenti a fondo perduto, o come se il creditore potesse dimenticarsi del debitore, o rimettere i suoi debiti “come noi li rimettiamo ai nostri debitori”?
Sinceramente non lo so. Alle volte penso che sia la nostra cultura cattolica che ci rende così irresponsabili. Come il peccatore pecca e ripecca sereno in attesa della prossima confessione o indulgenza che lo laverà di tutti i suoi peccati, forse allo stesso modo il politico pensa che alla fine si troverà una quadra, e che i debiti non debbano essere davvero restituiti.
Altre volte, invece, mi capita di pensare che dietro la rimozione del problema del debito vi sia un calcolo preciso, e cioè: il problema riguarda chi verrà dopo, noi intanto spendiamo e acquisiamo consenso, poi chi vivrà vedrà. Può darsi che sia così, che il governo giallo-rosso pensi di durare fino al 2023, spendendo allegramente i 209 miliardi del Recovery Fund, e che la restituzione del debito tocchi a Salvini-Meloni-Berlusconi, quando sarà il loro momento.
Se fosse così, sarebbe un calcolo alquanto cinico. Però, a mio parere, sarebbe anche un calcolo azzardato. La scommessa di poter fare tranquillamente le cicale per 2-3 anni, lasciando a chi verrà dopo la gestione della bancarotta del Paese, non tiene nel debito conto un’eventualità tutt’altro che remota: i mercati finanziari, che in questi mesi sono stati drogati dalle politiche dei bassi tassi di interesse, potrebbero anche svegliarsi. I calcoli della Fondazione Hume sui rendimenti dei titoli di Stato dei paesi europei segnalano che, in questi mesi, gli interessi richiesti alla maggior parte dei paesi dell’Eurozona (compresa la Francia, ma escluse Germania e Irlanda) sono molto più bassi di quanto i fondamentali dei vari paesi suggerirebbero e giustificherebbero. Il che significa: domani potrebbero essere più alti, anche molto più alti. A quel punto i paesi indebitati fino al collo, come l’Italia, la Grecia, e il Portogallo potrebbero salvarsi da una spirale di innalzamento dei rendimenti (come quella del 2011) solo se le loro economie fossero state nel frattempo risanate, e poste su un robusto sentiero di crescita.
Perché è inutile illudersi: il debito “buono” non è quello che serve a fare le cose che i politici di turno ritengono prioritarie per il paese, ma è quello che i mercati giudicano rimborsabile. E, quando il rapporto debito/Pil è molto alto, ci sono due modi soltanto di rassicurare i mercati: l’austerità (più tasse e meno spese), che serve a diminuire il numeratore, e la crescita, che serve ad aumentare il denominatore.
Ecco perché l’enfasi esclusiva su “come spendiamo questa montagna di soldi”, e la demonizzazione delle riduzioni fiscali (fra le poche misure in grado di dare una spinta alla crescita) sono estremamente pericolose. Certo, potrebbero creare problemi solo ai governi successivi, quando i mercati si sveglieranno. Ma ne potrebbero creare anche al governo in carica, ove esso dovesse durare più a lungo del sonno dei mercati.
Pubblicato su Il Messaggero del 19 settembre 2020